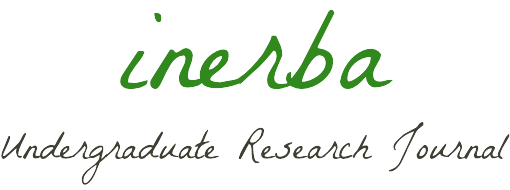La venuta alla luce del Commento alle Verrinae di Cicerone si pone nell’era della grande scoperta dei testi classici. Nel 1416, durante il Concilio di Costanza, l’allora segretario apostolico Poggio Bracciolini, in compagnia di tre amici umanisti (Bartolomeo da Montepulciano, Cencio Rustici e Sozomeno da Pistoia) fece visita al monastero di San Gallo: a questa visita si deve la scoperta di un Quintiliano completo (mentre fino a quel momento si aveva a che fare con esemplari mutili) e di un codice in pessimo stato di conservazione, contenente quattro libri delle Argonautiche di Valerio Flacco seguiti da una lunga serie di annotazioni alle orazioni ciceroniane in Pisonem, pro Scauro, pro Milone, pro Cornelio, in toga candida, divinatio in Quintum Caecilium, actio prima in Gaium Verrem, actio secunda in Gaium Verrem liber primus, actio secunda in Gaium Verrem liber secundus (quest’ultima solo fino al paragrafo 35).
Queste note di commento vennero fin da allora attribuite ad Asconio Pediano, illustre figura di studioso del secolo I d.C.1, il cui nome Poggio aveva letto all’inizio e alla fine del commento all’orazione in Pisonem e all’inizio di quello alla pro Cornelio, cosa che portò l’umanista a ricondurre proprio ad Asconio l’intera silloge.
Questo codice Sangallensis, forse databile al secolo IX, andò presto perduto: la tradizione del testo, giunta a noi in circa 30 esemplari del secolo XV, si basa pertanto sulle tre copie che Poggio e Bartolomeo prima e frettolosamente2 e, un anno dopo Sozomeno più accuratamente, approntarono. L’unico esemplare dei tre che sopravvive ancora oggi è proprio quello di Sozomeno, il Forteguerriano A. 37 siglato S nelle edizioni critiche, conservato presso la Biblioteca Forteguerriana di Pistoia: ad esso spetta il primo posto fra gli apografi del Sangallensis, come sostennero inizialmente A. Kiessling e F. Shöll che lo trascrissero e ne curarono un’edizione critica nel 1875, e poi altri studiosi.
Sozomeno era forse un paleografo meglio dotato di Poggio e di Bartolomeo, ma la sua copia è da preferirsi specialmente perché egli si accontentò di trascrivere con estrema diligenza il manoscritto di San Gallo, non arrischiò congetture o emendamenti e neppure volle correggere gli errori più evidenti. La sua cautela giunse fino al punto di saltare le parole di lettura incerta o difficile, lasciando una lacuna di lunghezza corrispondente, cosa che accadeva non di rado a causa del pessimo stato di conservazione del Sangallensis.
Per quanto riguarda l’apografo di Bartolomeo da Montepulciano, malgrado questo sia andato perduto, è tutt’ora esistente una sua copia diretta conservata a Firenze, il Laurenziano 54. 5 (M)3, il cui scriba è definito indoctus dalla maggior parte degli studiosi. Lo stesso Thomas Stangl, la cui edizione del 1912 è tuttora il testo di riferimento, tende a soffermarsi su quegli errori trascurabili e per lo più meccanici peculiari del codice M, che lo studioso ritiene essere indizio di un copista alquanto inesperto, il quale avrebbe trascritto il testo dall’esemplare che Bartolomeo da Montepulciano aveva creato sulla base dell’archetipo di San Gallo, ma lo avrebbe spesso corredato delle correzioni presenti nell’apografo dello stesso Poggio. Queste caratteristiche contribuirono nella storia degli studi a designare M come il testimone meno affidabile della tradizione e a far sì che esso non fosse considerato almeno fino al 1875, quando fu utilizzato per la prima volta insieme al codice S nell’edizione critica Kiessling-Schöll (1875).
Rimane da menzionare una delle questioni più spinose relative alla storia della tradizione manoscritta del nostro testo, ovvero la sorte dell’apografo di Poggio Bracciolini. Della sua copia, che sappiamo essere giunta nelle mani del Niccoli, si persero presto le tracce e spesso i dotti hanno creduto di riconoscerla ora in un codice, ora in un altro: esiste in compenso una serie numerosa di manoscritti, di vario valore dal punto di vista testuale e tutti trascritti nel secolo XV, che, sulla base di subscriptiones o di lezioni condivise, sembrano derivare in maniera piuttosto certa dall’apografo Poggiano, e grazie ai quali è possibile determinare le lezioni e l’importanza del modello.
Nella biblioteca nazionale di Madrid, con la segnatura X 81, si conserva un manoscritto di Asconio Pediano (P). Questo codice del secolo XV contiene il Chronicon del monaco Sigisberto di Gembloux4 (fol. 1-17), cui seguono 9 fogli in bianco che precedono i commentari di Asconio in 17 fogli e altri commenti a Cicerone di dubbia paternità (questo autore fu poi definito ps.Asconio per distinguerlo da quello autentico) in fogli 21 (fol. 27-64) e le Argonautiche di Valerio Flacco fino al libro IV 317 (fol. 65-94). È evidente che le tre opere non fossero dall’inizio riunite in un unico volume: mentre i libri di Asconio e di Valerio Flacco, entrambi vergati da una stessa mano, si mostrano connessi da sempre tra loro, il Chronicon di Sigisberto è stato sicuramente aggiunto in un secondo momento. Mentre infatti tutti i 26 fogli che contengono l’opera del gemblacense formano un unico fascicolo, a partire da Asconio le pagine sono unite 32 alla volta a formare 8 quaternioni. Inoltre, i fogli della cronaca presentano una filigrana diversa rispetto a quella ricorrente nelle pagine di Asconio e Valerio Flacco: quest’ultima è infatti caratterizzata da un serpente attorcigliato su di un arco.
Il codice è corredato da correzioni e note marginali: mentre quest’ultime non sembrano portare ad alcun elemento significativo, in quanto aggiunte in epoca più tarda e contenenti soltanto il sunto di alcuni passi dei commentari di Asconio e dei versi di Valerio Flacco, le correzioni, invece, visibili all’interno del testo o a margine, contribuiscono a stabilire il rapporto di parentela del Madrileno con i restanti esemplari della tradizione. Differiscono tra loro per il ductus e per il colore dell’inchiostro, cosa che fa presupporre che siano state vergate da tre mani diverse5. Si riscontra, poi, la presenza di un altro correttore che ha aggiunto qua e là nel margine alcune congetture, con le quali spesso vengono sanate lezioni erronee del testo, e che sono a volte accompagnate da segni quali c o dalla parola credo. È sulla base di questi elementi che Albert Clark (1899:120), avendo comparato questo testimone con il Laurenziano contenente le epistole ciceroniane ad Attico, nel quale si riscontrano gli stessi segni, sostiene che tali congetture siano opera dello stesso Niccolò Niccoli. Moltissime correzioni infine sono state vergate da una mano con un ductus molto simile a quella che ha vergato il testo, tanto da poter supporre che si tratti della medesima.
Ciò che, tuttavia, rende tanto degno di nota questo esemplare è la presenza di una subscriptio che riporta la firma di Poggio Bracciolini6, fatto che ha spinto gli studiosi a dividersi tra quelli che, confidando nella subscriptio, riconoscono nel Madrileno la copia autentica dell’umanista, e coloro che invece credono che questo codice P sia stato trascritto dalla copia di Poggio andata perduta.
Un punto fondamentale per affrontare questo problema è accertare la discendenza dal Madrileno di tutti gli esemplari di stampo Poggiano, quali: 1) l’editio princeps a stampa, edita a Venezia nel 1477 (Pw), considerata un’edizione instar codicis, che può quindi essere utilizzata per recensire il testo di Asconio in qualità di testimone a tutti gli effetti; 2) il Neapolitanus V B 20 (Pn), scoperto a Napoli da Thomas Stangl nel 1884 e da lui inizialmente considerato un quarto apografo del Sangallensis, indipendente sia dai codici Poggiani sia da quelli di Sozomeno e Bartolomeo7, ma poi ricondotto anch’esso nel novero della tradizione Poggiana; 3) il Gothanus II n 118 (Pc); 4) l’Ambrosianus H 100 (Pd); 5) il Laurentianus pl. 50. 4 (Pb); 6) il Lugdunensis Batav. 222 (Pl); 7) il codice della soc. Colomb. Fiorent. B 7 (Pa); 8) il Ricciardianus (Pr); 9) il codice Guelferbytanus n. 88 Gudianus (Pg).
L’unico argomento che si potrebbe addurre contro la discendenza di tutti costoro dal Matritensis è il fatto che nessuno di questi codici riporta l’accostamento di Valerio Flacco con Asconio, che si verifica invece nel codice di Madrid. Tale argomentazione, tuttavia, non sembra implicare nient’altro se non che il codice P sia connesso in maniera molto più stretta degli altri all’apografo di Poggio. Infatti, quando l’umanista nella sua lettera a Guarino Veronese afferma di aver trascritto di suo pugno entrambi gli autori antichi per inviarli a Leonardo Bruni in Italia, nessuno dubita che lo abbia fatto unendoli in un unico volume.
Ciò che ne consegue è evidente: o tutte le copie Poggiane discendono dal Matritensis, o questo e quelle traggono la loro origine da uno stesso esemplare ora perduto. Tutti gli studiosi ormai propendono per la prima delle due ipotesi.
Già Knust (1843) aveva creduto di riconoscere nel codice di Madrid l’apografo di Poggio, ma fu avversato poco tempo dopo da A. Kiessling e F. Shöll, i quali, tuttavia, nella loro edizione del 1875 non si curarono neppure di esaminare il codice Madrileno, mettendo maggiormente in risalto S e M. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento A. Clark (1896), sulla base del confronto di alcune lezioni, cercò di dimostrare che i codici migliori della famiglia Poggiana come Pb (il Laurenzianus 50, 4), Pa (soc. Colomb. Fiorent. B 7), Pl (Leidensis n. 222) derivano dal Madrileno e concluse che questo codice, se anche non è propriamente l’apografo del Poggio, è almeno il rappresentante più antico della famiglia Poggiana e può, quindi, dispensare i futuri editori di Asconio dal tener conto di altri codici della stessa famiglia. Infine Krohn (1899), confrontando il Madrileno con altri esemplari che risultavano trascritti in maniera evidente da Poggio (in particolare il Berolinensis Hamiltonensis 166) e riconoscendone la mano, affermò che si fosse in presenza dell’apografo del noto umanista; né, di fatto, secondo lo studioso, può andar contro a tale ipotesi l’osservazione per cui il ductus di alcune lettere presenti in P differisce da quello delle medesime presenti nel testimone di Berlino. Sappiamo infatti che Poggio copiò l’esemplare di Madrid velociter, come già esposto in precedenza, mentre nel trascrivere il codice contenente le epistole di Cicerone si adoperò manu bellissima. Questa argomentazione non persuase del tutto A. Clark, il quale, considerando che gli esemplari sicuramente poggiani (Laurenziano pl. 48, 22; 50, 31; 67, 15 e il Berlinese Hamilton 166) sono stati trascritti in un momento diverso rispetto a quello in cui fu copiato il Madrileno, sostenne che la questione non potesse essere sciolta fin quando non venisse alla luce un manoscritto autentico di Poggio, copiato anch’esso rapidamente. P. Schmiedeberg (1905), invece, concorda con F. Krohn nell’identificare il codice di Madrid con l’apografo di Poggio.
Quello che è certo è che il manoscritto di Madrid rimane un codice di grande importanza e che l’ipotesi di A. Clark sembra avere vari argomenti a suo favore, tra i quali il più notevole appare la presenza in molti passi di un fenomeno alquanto curioso: la prima mano del Madrileno riproduce la lezione del Forteguerriano, poi la stessa o una seconda mano corregge la lezione del Madrileno e tutti gli altri codici della famiglia Poggiana riproducono solo la lezione corretta. Questa constatazione fa nascere due ipotesi: nella prima ricostruzione il Madrileno deriva dal Forteguerriano, cosa alquanto improbabile per tutta una serie di motivi e specialmente perché nel Forteguerriano ci sono lacune di parole e di intere linee, che si leggono invece nel Madrileno; in alternativa entrambi derivano direttamente dallo stesso codice, che non potrebbe che essere il Sangallese. Mentre Sozomeno non volle tentare la correzione degli errori dell’archetipo, il dotto a cui si deve il Madrileno, che a questo punto non potrebbe essere che Poggio, aggiunse qua e là emendazioni proprie (studiate da Giarratano 1906).
Ammesso, dunque, che il Matritensis X 81 sia la copia autentica dell’umanista fiorentino, bisogna comunque domandarsi quanta autorevolezza abbia come testimonianza dell’antigrafo per noi perduto. L’edizione berlinese di Keissling-Shöll metteva in primo piano il Forteguerriano, considerando la copia di Sozomeno un’ottima immagine del Sangallese. Non fu dello stesso avviso Stangl, il quale sosteneva che l’esemplare di Poggio conservasse invariato il testo dell’antigrafo, e pensava che lo facesse a tal punto che lo stesso canonico di Pistoia molto spesso avesse corretto la propria copia sulla base di quella dell’amico. Seguendo P. Schmiedeberg (1905) sembra che entrambe le affermazioni vadano mitigate, in quanto non si potrà pensare né che Sozomeno abbia sempre conservato il testo tramandato dal Sangallese8, né, d’altro canto, si potrà concordare con Stangl che Poggio non l’abbia mutato affatto, poiché sappiamo con certezza che in almeno tre passi egli corresse quanto trovò scritto nell’antigrafo. Le conclusioni di P. Schmiedeberg sono state successivamente accettate da Stangl stesso (1906; 1913), che vede tuttavia in P non tanto la copia trascritta da Poggio a San Gallo, quanto, in accordo con Clark (1896), una prima “edizione” delle note ad opera dell’umanista.
Si è così portata a termine in questa sede la rapida rassegna di quella triade di manoscritti, P, M e S, considerata tuttavia canonica soltanto a partire dagli studi del diciannovesimo e ventesimo secolo, cioè dal momento in cui gli editori riconobbero il valore di questi tre esemplari9.
In tutti i manoscritti superstiti e in tutte le edizioni critiche a partire dalla prima (edita a Venezia nel 1477 ad opera dello Squarzafico) fino a quelle del secolo XIX, al commento di Asconio Pediano alle cinque orazioni ciceroniane è allegata l’edizione di un ulteriore commento di stampo per lo più grammaticale e non storico-prosopografico di parte delle Verrinae, opera costituita da 7 orazioni, composte per il processo giudiziario incentrato sulle malversazioni del governatore della Sicilia, Gaio Licinio Verre, compiute tra il 73 ed il 71 a.C. e nell’ambito delle quali Cicerone riveste il ruolo di accusatore. Questa sezione fu da sempre attribuita allo stesso Asconio Pediano, fino a che L. Madvig nella sua edizione del 1828 riuscì a dimostrare con convincenti argomentazioni che, in realtà, si trattava dell’opera di un autore anonimo molto più tardo, che egli situò all’incirca nel secolo V, sulla cui personalità non sappiamo nulla, se non quel poco che si riesce ad evincere dalle sue stesse parole.
In precedenza alcuni studiosi, confrontando il commento alle Verrinae con le altre cinque orazioni ciceroniane commentate da Asconio Pediano, non si resero conto che molte frasi, l’utilizzo di alcune parole o la narrazione dei fatti non potessero essere proprie del secolo I d.C., età dell’Asconio autentico (Pauly-Wissowa 1896: 1524-1527); altri talvolta rimanevano addirittura stupefatti nell’incappare in espressioni che sembravano essere molto distanti dall’età giulio-claudia propria del vero Asconio. Soltanto pochi andarono più a fondo e riconobbero in molti vocaboli le tracce di un’epoca più tarda: essi però giungevano alla conclusione che si fosse davanti a interpolazioni, e non certo che si trattasse in realtà di un differente autore.
Madvig, d’altro canto, riprendendo un pensiero che era stato già di Niebuhr (1827), capì fin da subito che queste note di commento, che egli chiama nugae, “inezie”, si allontanavano molto dall’opera a noi nota di Asconio e che per nessun’altra ragione si era creduto fino ad allora che fossero opera di questo autore, se non per il fatto che la trasmissione dei due testi risultava legata dal tempo della loro scoperta da parte del Bracciolini, ammettendo che costui li avesse già trovati uniti in un unico codice.
Cominciando dall’aspetto esteriore di questo commento, balza subito all’occhio come molte note siano caratterizzate da due o tre parole, a volte addirittura da una soltanto, e che nessuna frase del testo di Cicerone venga ripresa in maniera integrale nella sua completezza. Numerose evidenze sono indizio di una forma che rispecchia quella di solito presente negli scoli di età tardoantica. L. Madvig giunge ad ipotizzare che inizialmente si trattasse di note scritte ai margini delle stesse orazioni ciceroniane e solo successivamente trascritte a parte: prova di ciò, a suo dire, sarebbe lo sconvolgimento del loro ordine nel manoscritto di Poggio, avvenuto quando tali noticine, aggiunte qua e là al di fuori dello specchio di scrittura, furono trasferite in un altro codice, sconvolgimento che invece non è presente nel testo dei Commentari di Asconio, che evidentemente fin dalla loro origine ebbero la forma di un commento continuo. Molte note marginali ad opere di Cicerone sono testimonianza di quanto nei codici sia possibile scovare non solo glosse e spiegazioni di lemmi, bensì anche tracce di annotazioni in qualche modo di stampo retorico, che non sarebbero mai sopravvissute, se non si fossero legate ad un commento esteso e continuo. Questo commentario alle Verrinae non è, infatti, di carattere storico alla stregua di quello di Asconio, quanto retorico e grammaticale, volto alla spiegazione di lemmi e sentenze molto semplici o di fatti molto noti, spesso banale, pieno di errori e di inezie.
Dall’argumentum della Div. in Quintum Caecilium10 sembra emergere la figura di un maestro di scuola: vi si trova per prima cosa una descrizione dei personaggi e dei fatti ad essi connessi, poi, dopo la rievocazione di pochi avvenimenti storici, un’esposizione di argomenti contrari ad entrambe le parti in causa; né differiscono molto da questo gli argumenta delle altre orazioni. Nei commenti che seguono il testo delle orazioni si incontrano spesso consigli di carattere retorico e morale, ma la maggior parte degli scoli rimane di carattere grammaticale, e la loro povertà di contenuto, la banalità, nonché la poca sicurezza con cui vengono riportate alcune notizie fanno pensare che siano da collocare molto più tardi da un punto di vista cronologico rispetto ai commenti di Donato a Terenzio e di Servio a Virgilio, entrambi del IV secolo d.C. Stranamente il nostro anonimo autore talvolta tralascia le osservazioni dei grammatici a lui precedenti riguardo il singolare uso di alcuni vocaboli, mentre riporta delle citazioni con le quali questi contrastano ampiamente11. Quanto sia inferiore ai suoi predecessori è evidente dall’utilizzo che fa delle fonti antiche; nell’esplicazione di fatti storico-istituzionali non cita mai gli autori, mentre nelle questioni grammaticali sfrutta soprattutto l’autorevolezza di due scrittori, quali Virgilio e Terenzio, tra i pochi rimasti in auge insieme a Cicerone e Orazio durante il periodo tardoantico e altomedievale. In aggiunta a questi due riscontriamo due menzioni di Sallustio, tre di Plauto, due di Lucilio, una di Nevio, che molto difficilmente può essere considerata una citazione diretta, quanto piuttosto presa dai commentarii a lui precedenti; talvolta si incontrano prevedibilmente anche passi dello stesso Cicerone. Queste sono le esigue tracce della letteratura classica di cui il nostro anonimo fa mostra; niente sembra essere osservato in maniera scrupolosa, niente con una qualche erudizione, nessun confronto tra il lessico di Cicerone e quelle di altri oratori della latinità.
Che il nostro autore non padroneggi in modo disinvolto la lingua latina appare evidente anche dal fatto che spesso non comprende la sintassi delle frasi12 o erra nell’interpretare il valore semantico delle parole con commenti che testimoniano la mancata comprensione del passo dell’Arpinate13 che egli intendeva glossare.
In genere, tra gli ambiti principali in cui si colloca l’operato dei grammatici tardoantichi e da cui emerge la loro dottrina o la loro ignoranza vi sono la costruzione di etimologie e la differenziazione delle parole in base al loro significato: nel nostro caso gli scoli sono provvisti di esempi di entrambi i generi. La gran parte delle etimologie fornite dallo ps.Asconio sono comuni anche ad altri, mentre tre sono prive di riscontri e, a detta del Madvig, piuttosto divertenti: lo ps. Asconio spiega astutum con ἀπὸ τοῦ ἄστεος come se fosse urbanum (I, 1, 11); alacrem da non lacerum (I, 1, 6); compilare da pilos pervellere (II, 1, 35). Circa, poi, le molte differenze semantiche tra le parole, egli si sofferma soltanto su quel valore con cui tendono a presentarsi più spesso e in alcuni casi si mostra ampiamente incerto e non in grado di capire in che modo impostare la questione14.
Di certo la lingua rappresenta l’elemento principale per collocare lo ps.Asconio in epoca tardoantica, anche se l’esiguità del materiale in nostro possesso – si tratta infatti soltanto di brevi scoli – ostacola delle approfondite ricerche a riguardo. Ciò che balza subito all’occhio sono le tracce di una certa “ruvidezza” linguistica; vi si trovano parole come animositas, annonae in forma plurale, appellativus, argumentalis, auctionari per emere, celebrare per habere fideiussor, incubare per iniuste possidere e come queste molte altre parole singole o espressioni che sono indizio dell’imminente corruzione della lingua latina. Da notare il frequente uso del pronome iste al posto di hic e il quod usato con valore dichiarativo, tratti comuni a tutti gli scrittori della tarda-antichità.
In quale momento di quest’epoca storica debba essere situato il nostro anonimo autore rimane ancora da chiarire. L. Madvig sostiene che possa essere nato poco tempo dopo personaggi quali Servio e Donato, dal momento che mentre in costoro emerge una consapevolezza adeguata delle antiche strutture e istituzioni statali romane, costui ne mostra una conoscenza assai debole, tanto da far dedurre che in quel piccolo lasso di tempo che separerebbe i due grammatici dallo ps.Asconio, grandi furono i cambiamenti nel campo delle lettere e degli studi. Del resto, non sembra eguagliare in nessun modo neppure la cultura di grammatici come Diomede e Carisio, situabili nella metà del secolo IV, motivo per cui Madvig ritiene che questo commento sia stato scritto non molto tempo prima della caduta dell’Impero romano d’Occidente, quando l’immagine dell’antico impero era ormai solo un vago ricordo, la lingua si era irrimediabilmente corrotta e la conoscenza diretta delle opere degli antichi scrittori andava sempre più scomparendo dal bagaglio culturale degli uomini dell’epoca.
Se è vero, come sostiene Madvig, che queste note di commento alle Verrinae ciceroniane non sono di carattere storico-prosopografico quanto retorico e grammaticale, con un gusto tipicamente tardoantico nella costruzione di etimologie e nella differenziazione delle parole in base al loro significato, è altresì vero, a difesa dell’anonimo grammaticus di V sec. d.C. redattore degli scholia15, che egli ebbe evidentemente a disposizione una copia di Cicerone corrotta e interpolata. Lo dimostra in molti casi la difficoltà dello ps.Asconio di districarsi tra diverse interpretazioni possibili e, soprattutto, la presenza nel testo di glosse dal tenore filologico, nelle quali egli sembra menzionare varianti al testo a lui tradito.
Proprio queste note si sono rivelate le più problematiche nella costituzione del testo, divenendo oggetto di interventi da parte dei vari studiosi che, nel corso dei secoli fino all’ultima edizione critica di Stangl (1912), vi hanno messo mano.
Il loro contenuto, nonché i diversi e spesso fallimentari tentativi di sistemazione testuale che hanno subito, rendono queste esigue glosse idonee ad offrire uno spaccato delle competenze dell’anonimo commentatore tardoantico, dello stato della tradizione manoscritta delle Verrinae intorno al V secolo d.C. e, al tempo stesso, permettono di analizzare un certo modus operandi della critica testuale alle prese con un testo piuttosto lacunoso e manomesso.
L’analisi testuale e la proposta di traduzione che in questa sede vengono presentate si basano sull’edizione di Thomas Stangl del 1912, ancora oggi testo di riferimento16.
Il primo segno di attenzione filologica che si riscontra nel commento alle Verrinae, II, 1 è presente nel glossare il passo Verr. II, 1, 52, in Ps.Asc. in Verr. Stangl 236, 16, dove il commentatore sembra riportare nel testo una varia lectio, quaesitorem, per poi aggiungere di essere consapevole che nella tradizione manoscritta ciceroniana si trova scritto anche quaestorem:
(§ 52.) quaesitorem. Legitur et «quaestorem». Si «quaesitorem»: ipsum illum Glabrionem, cuius cura est ut sociis omnia rapta reddantur; si «quaestorem»: ad quem rediguntur proscripti bona et a quo sociis adnumerantur. «sectorem» autem dicit aestimatorem redemptoremque bonorum damnati atque proscripti, qui spem sectans lucri sui, id est secutus spem aestimationis suae, bona omnia reauctione vendit et semel infert pecuniam vela aerario vel sociis. Contra hos igitur iam pugnat Verres, inquit, iis subtrahens omnia signa, non contra me qui illum, etiam subtractis signis, testimoniis tamen possum convincere.
(§ 52.) giudice. Si interpreta anche quaestorem, «funzionario dell’erario». Se si intendesse quaesitorem, «giudice», il termine sarebbe da riferire a quello stesso Glabrione, il quale doveva occuparsi che tutto ciò che era stato rubato fosse riconsegnato agli alleati; se invece quaestorem, «funzionario dell’erario», indicherebbe la persona presso la quale venivano ammassati i beni del proscritto e dalla quale venivano restituiti agli alleati. Chiama, invece, sectorem, «compratore», l’estimatore e colui che riscatta i beni del condannato o del proscritto, colui che, inseguendo l’aspettativa di un proprio profitto, cioè avendo riposto speranza nella propria valutazione, rivende tutti i beni con una vendita all’incanto e in una sola volta presenta del denaro sia all’erario sia agli alleati. Dunque, ormai Verre combatte contro costoro, dice, sottraendo loro tutte le statue, non contro di me che posso dimostrare la sua colpevolezza attraverso i testimoni, pur essendo scomparse le statue.
Il passo ciceroniano commentato si riferisce alle ruberie di statue e immagini sacre perpetrate da Verre durante la sua legatio Asiatica come coadiutore al governo di Gneo Cornelio Dolabella nella provincia di Cilicia (80 a.C.) e in particolar modo alla lotta messa in atto dall’imputato contro il funzionario dell’erario e contro il venditore all’incanto dei beni che gli erano stati confiscati, piuttosto che contro Cicerone, il suo accusatore. Considerato il contesto, la glossa dello ps.Asconio si rivela un’osservazione piuttosto importante dal momento che dalla continuazione del suo commento egli sembra aver compreso quanto l’interpretazione del passo ciceroniano sarebbe condizionata se si scegliesse l’una o l’altra lezione.
A questo problema di carattere eminentemente filologico è legata, inoltre, una questione interpretativa, ovvero cosa effettivamente lo ps.Asconio sapesse circa le funzioni in età repubblicana del quaesitor e del quaestor.
Purtroppo non siamo in grado di stabilire se quaesitorem fosse un’effettiva varia lectio circolante al posto di quaestorem in un ramo a noi non pervenuto della tradizione delle Verrinae ciceroniane al tempo dello ps.Asconio. Attualmente, infatti, il nostro commentatore è l’unico rappresentante di questa variante, dal momento che l’intera tradizione manoscritta, corroborata anche dagli scholia Gronoviana, riporta la lezione quaestorem. La maggior parte degli editori moderni delle Verrinae non solo presentano nel testo il lemma quaestorem, ma non ritengono la variante pseudoasconiana degna nemmeno di essere citata in apparato critico, vista la sua unicità rispetto a tutta la restante tradizione manoscritta (Zumpt 1831; Peterson 1916; Mueller 1908; Greenwood 1966); caso isolato è l’edizione di Klotz (1923), in cui l’editore sceglie di mettere a testo la variante tramandata dalla glossa pseudoasconiana.
L’interpretazione di quaesitorem come varia lectio, attestata solo nello ps.Asconio, deriva dalla frase legitur et quaestorem, e in particolar modo si basa sulla presenza del verbo legitur, «si legge», che fa immaginare la coesistenza di queste due forme, forse in rami diversi della tradizione.
Tuttavia, analizzando l’apparato critico di Stangl (1912: 236), si può constatare che legitur è una congettura risalente allo studioso Pierre Danés e presente nell’edizione di Aldo Manuzio del 1547, accettata e messa a testo dallo stesso Stangl, mentre la lectio vulgata, che doveva essere propria del codice di San Gallo, è dicitur. In questo caso, la presenza del verbo dicitur porterebbe ad escludere un’interpretazione “filologica” della glossa, in quanto lo scoliasta non avrebbe voluto qui mostrare una varia lectio, ma ammonire, probabilmente con fini didascalici essendo egli un grammaticus, circa il diverso significato di due parole, quaesitor e quaestor, che ormai in età tardoantica venivano percepite come un unico lemma avente due grafie differenti. Sulla base di ciò si spiega anche il tentativo dello ps.Asconio di spiegare l’accezione dei due termini per mostrarne la differenza; un atteggiamento che ben si situerebbe all’interno di tutto un filone tardoantico, dedito alla distinzione di parole dalla grafia simile ma dal diverso significato, che tendevano ad essere confuse tra loro o percepite come varianti di un’unica parola.
Nel suo commento all’edizione degli scolii pseudoasconiani alle Verrinae, Stangl (1909) giustifica e motiva la propria scelta editoriale di mettere a testo la congettura legitur, già proposta dal Danés. Egli sostiene che la forma dicitur sia entrata nel testo e abbia soppiantato legitur in quanto supportata da tutta una serie di attestazioni del verbo dico, in diverse forme della sua coniugazione, nella glossa a Verr. II, 1, 51 appena precedente, e in particolare dal gerundio dicendum separato da legitur da sole tre parole (Stangl 1912: 236):
(§ 51.) Ad omnis columnas. Locus «antecolumnium» dicitur.
In silva. In viridario.
Sub dio. Id est sub coelo. Coelum Graeci τὸν Δία dicunt, sed ita declinatur: «Hoc ‹dium›, huius
dii, huic dio, hoc dium, o dium, ad hoc dio».
Quamdiu alium praetorem. Metellum scilicet cum iudicibus, quos in horum locum,
quemadmodum supra dixit, subsortiturum se Verres esse credebat.
Nostris testibus quam horis. Usus est enim prima Actione Cicero magis testibus suis quam
‹horis›, id est temporibus sibi ad dicendum lege datis.
(§ 51.) Accanto ad ogni colonna. Questo luogo viene chiamato antecolumnium.
Nel boschetto. Cioè, nel parco.
Sotto il dio. Si intende «sotto la volta celeste». I greci chiamavano il cielo τὸν Δία, “dio”,
ma viene declinato così: hoc dium, huius dii, huic dio, hoc dium, o dium, ad hoc dio.
Fintanto che un altro pretore. Ovvero, Metello con i giudici che Verre credeva avrebbe
sorteggiato al posto di questi, come ho detto sopra.
Dei miei testimoni piuttosto che delle ore. Cicerone, infatti, nel primo discorso
d’accusa si è valso più dei suoi testimoni che delle ore, cioè del tempo che gli era stato
concesso dalla legge per pronunciare il suo discorso.
A vantaggio della lezione legitur, secondo l’editore, si possono inoltre riscontrare altre tre occorrenze sicure di tale verbo in contesti simile a questo: la glossa a Verr. II, 1, 34, a II, 1, 60 e a II, 1, 90.
Nella glossa a Verr. II, 1, 34 lo ps.Asconio (Stangl 1912: 233) spiega che Cicerone con il riferimento al console Gneo Papirio Carbone volesse intendere sia il momento in cui si svolse l’imputazione di Verre sia l’imputazione stessa: «Quaestor Cn. Papirio consuli fuisti. Uno nomine Cn. Papirii Carbonis et tempus criminis significavit et crimen. Legitur tamen et «consule», ‹sed male›». «Fosti questore del console Gneo Papirio. Con il solo nome di Gneo Papirio Carbone ha indicato sia il momento in cui si svolse l’imputazione che l’imputazione stessa. Tuttavia, si legge anche consule, ‹ma in maniera errata›».
Nella parte finale dello scolio egli sembra voler informare della coesistenza di una varia lectio, consule in ablativo, al posto del dativo consuli, attestato dalla vulgata delle Verrinae, con la sola eccezione del codice G₁b (Guelferbytanus 2652), che presenta anch’esso, per esteso e non in forma abbreviata, consule. Proprio sulla base del testo ciceroniano riportato dalla vulgata, Danés prima e poi lo Schmiedeberg emendarono il testo pseudoasconiano alquanto confuso: i codici S (Forteguerrianus A. 37) e M (Laurentianus 54.5) riportano infatti la lezione abbreviata cons., mentre P (Matritensis 8514) cos., probabilmente da intendere come forma abbreviata del plurale consules, mentre tutti e tre i codici presentano la varia lectio testimoniata dallo ps.Asconio nella forma consuli, probabilmente attestata nel Sangallese (C). Il Danés e lo Schmiedeberg emendarono cons. di SM e cos. di P con la lectio vulgata presente nella tradizione delle Verrinae e, nel punto in cui ps.Asconio indicava quella che doveva essere una varia lectio, emendarono il dativo consuli con l’ablativo consule.
Inoltre, lo stesso Stangl ammette che i due filologi avessero ben compreso il senso dello scolio pseudoasconiano, dal momento che essi interpretarono quel legitur non tanto come legitur in quibusdam codicibus, ma piuttosto come a criticis quibusdam legitur, ovvero non come una vera e propria variante letta in qualche esemplare, ma come l’interpretazione di qualche commentatore. Questo sarebbe confermato, secondo Stangl, dal commento al passo Cic. Verr. ad Div. 1, dove il verbo lego si riferisce chiaramente ad un’interpretazione proposta da molti, non tanto alla lettura di una diversa lezione in alcuni esemplari manoscritti (Stangl 1912: 186): […] multi non descenderim legunt, sed descendere. Un’ulteriore conferma deriverebbe dalla lacuna con cui si chiude la glossa a Verr. II, 1, 34, lacuna che secondo il filologo tedesco nasconderebbe un sed male, ovvero un commento dello ps.Asconio, che ricorre anche in ad Div. 3 ugualmente in riferimento all’interpretazione – per lui errata (sed male) ‒ da parte di alcuni del significato di un lemma17.
Qualora si accetti questo tipo di esegesi di Verr. II, 1, 34 relativamente a legitur tamen et “consule”, come ammette lo stesso Stangl, è chiaro che questo passo non possa essere citato come occorrenza di legitur da intendere filologicamente nel senso di legitur in quibusdam codicibus e quindi non possa essere preso a sostegno della congettura legitur al posto di dicitur di Verr. II, 1, 52.
Il secondo scolio addotto da Stangl come parallelo a quello di Verr. II, 1, 52 è la glossa a Verr. II, 1, 90 (Stangl 1912: 244), passo in cui Cicerone tratta dell’azione piratesca perpetrata da Verre, legato d’Asia, nei confronti dei Milesi, i quali, dal tempo della guerra mitridatica, dovevano al popolo romano la costruzione e l’equipaggiamento di dieci navi da poter utilizzare contro i pirati. I Milesi, insieme ai documenti pubblici che attestavano la perdita di una di queste dieci navi, causata non tanto da un attacco dei pirati, quanto dalle malversazioni del legato, si erano recati a Roma per denunciare il fatto al Senato, ma furono costretti ad attendere il mese di febbraio, quando le ambascerie straniere venivano ricevute, e il nome dei consoli designati:
(§ 90.) Et consulum designatorum nomen expectant. Et «extimescunt» legitur, nam utroque verbo idem significatur. Hortensii autem et Metelli metu dicit legatos Milesios posse terreri ne de myoparone dicant, praesertim cum ad beneficia petenda venturi sint Februario mense et in manu sit consulum quando et quemadmodum referant ad senatum. Et bene «nomen consulum» dixit, ut potentiam demonstraret eorum quorum etiam nomen ad formidinem sufficit.
(§ 90.) E sono in attesa del nome dei consoli designati. Si intende anche extimescunt, «temono»: infatti, entrambi i verbi hanno lo stesso significato. Del resto, afferma che per paura di Ortensio e di Metello gli ambasciatori milesi possano essere distolti dal denunciare il fatto riguardante il brigantino, tanto più che hanno intenzione di recarsi a chiedere concessioni nel mese di Febbraio e che è nelle mani dei consoli quando e in quale modo questi possano rivolgersi al senato. E giustamente ha parlato di nomen consulum, «nome dei consoli», per dimostrare l’autorità di coloro il cui solo nome è sufficiente a destare timore.
Prendendo in esame le parole ciceroniane, lo ps.Asconio commenta affermando che alla stregua del verbo exspectant, «attendono», si può intendere anche extimescunt, «temono», in quanto, a suo avviso, i due predicati verbali possono assumere la stessa sfumatura semantica. Effettivamente, se si intende exspecto in senso negativo, ovvero nel senso di exspectare malum, «aspettarsi qualcosa di male», l’idea che ne deriva è quella di un timore. Egli sostiene inoltre che ciò sarebbe confermato dal fatto che è proprio per paura dei nuovi consoli, ovvero Ortensio e Metello, favorevoli a Verre, che gli ambasciatori milesi possano essere distolti dal denunciare il fatto riguardante il brigantino.
Anche in questo caso, dunque, come per lo scolio a Verr. II, 1, 34, la forma verbale legitur non vale come legitur in quiusdam codicibus, ovvero come se lo ps.Asconio riportasse una varia lectio, ma deve essere considerata come un «si intende, si interpreta»: evidentemente lo scopo dello scoliasta è semplicemente quello di chiarire il significato del verbo exspecto, offrendo un suo sinonimo.
L’ultimo parallelo è la glossa a Verr. II, 1, 60 (Stangl 1912: 238-239), testo che si presenta in uno stato evidentemente corrotto; seguo in questa sede la scelta editoriale di Thomas Stangl (1912):
(§ 60) Habeo ‹et› ipsius et patris eius accepti tabulas. Id est acceptarum pecuniarum. Legitur et «Ab eo et accepi». Moris autem fuit unumquemque domesticam rationem sibi totius vitae suae per dies singulos scribere, [in] quo appareret quid quisque de reditibus suis, quid de arte fenore lucrove seposuisset quo die, et quid item sumptus damnive fecisset. Sed postquam obsignandis litteris reorum ex suis quisque tabulis damnari coepit, ad nostram memoriam tota haec vetus consuetudo cessavit. Dicit igitur Tullius habere se et patris eius tabulas, quoad vixit, et ipsius Verris, quoad confecisse dixit: ex quibus prodit quam multae tabulae pictae, quanta signa apud eum nulla emptionis origine furto capta noscantur, remoraturque in eo quod se dicat Verres non ex aliquo tempore coepisse litteras domesticae rationis facere, set ex aliquo tempore destitisse: quod factum nullo exemplo defendi potest.
(§ 60) Sono in mano mia tutti i registri delle entrate di costui e di suo padre. Si tratta delle entrate in denaro. Si legge anche Ab eo et accepi, «Ho addirittura ricevuto da lui». Era consuetudine che ciascuno registrasse i conti privati ogni giorno per tutta la sua esistenza, in modo che apparisse chiaro in quale giorno che cosa ciascuno avesse accantonato dalle sue entrate, cosa dall’abilità per gli interessi e per il guadagno, e quale acquisto o perdita avesse subito. Ma dopo che nel sigillare i documenti degli imputati ciascuno iniziò ad essere condannato per i propri registri, ai nostri tempi questa antica consuetudine venne meno interamente. Dunque, Tullio sostiene di avere in mano anche i registri di suo padre, fintantoché visse, e dello stesso Verre, fintantoché disse di averli tenuti: attraverso questi svela quale gran numero di quadri, statue di quale valore si vedono presso di lui, sottratte attraverso il furto e senza alcun origine commerciale, e indugia sul fatto che Verre affermi non di aver iniziato da un certo momento a tenere i registri dei conti privati, ma di aver desistito: questo fatto non può essere difeso da nessun esempio.
Per prima cosa si può notare che il primo et è frutto di un’integrazione del Danés, basata sul testo presente in alcuni codici della tradizione ciceroniana e sulle congetture riscontrate in alcuni esemplari poggiani della tradizione asconiana. In secondo luogo, la forma pronominale ipsius, messa a testo da Stangl, è lezione attestata soltanto nel manoscritto di Sozomeno a fronte di istius testimoniato da PM, considerata lectio vulgata e presente anche in tutta la tradizione ciceroniana. Tuttavia ipsius è lezione preferita già dal Danés, che la spiega con la presenza del precedente eius, mentre Stangl giustifica la sua scelta individuando un parallelo nello scolio a Verr. II, 1, 32 (Stangl 1912: 233), dove si trova la forma ex ipso di nuovo attestata in S, mentre in PM e nella vulgata si trova ex isto:
(§ 32) Aut ex ipso quem sui simillimum produxit. Reprehendunt homines stultissime Tullium, quod in filio Verris innoxiam laedat aetatem, ignorantes illum accusatoria arte providere ne in epilogis productus ab Hortensio conciliet misericordiam iudicum patri.
(§ 32) O in suo figlio che egli ha allevato in tutto simile a sé. Gli uomini in maniera assai sciocca biasimano Tullio, poiché nei confronti del figlio di Verre offenderebbe l’età innocente, ma ignorano che egli faceva in modo con la sua abilità accusatoria che, presentato nella perorazione da Ortensio, non suscitasse la compassione dei giudici a vantaggio del padre.
Tornando all’aspetto del testo dello scolio a Verr. II, 1, 60, è frutto di una congettura del Danés anche la separazione ab eo dalla forma habeo, che nel Sangallese doveva seguire legitur et. Proprio grazie alla presenza di quest’ultima formula si è giunti alla conclusione che in questo caso lo ps.Asconio avesse intenzione di riportare la coesistenza nella tradizione ciceroniana di una varia lectio, ab eo, al posto di habeo, variante che trova un riscontro soltanto nel codice di S. Marco 255 (b) e in tutti gli esemplari che discendono da questo.
Ammettendo tale sistemazione del testo pseudoasconiano, sembra effettivamente che si assista al tentativo da parte dello scoliasta di fornire un commento di carattere filologico. Nell’occuparsi, infatti, dell’esegesi del passo Verr. II, 1, 60, con le parole legitur et Ab eo et accepi, si legge anche: “Ho addirittura ricevuto da lui”, egli mostra di essere consapevole dell’esistenza di una varia lectio rispetto al testo ciceroniano che aveva sotto gli occhi o che ricordava a memoria, «habeo et ipsius et patris eius accepti tabulas», «sono in mano mia tutti i registri delle entrate di costui e di suo padre».
È interessante notare che parte di quella lezione che lo ps.Asconio riporta come variante, accepi, è invece presente nella maggior parte dei manoscritti contenenti le Verrinae18, mentre la forma accepti è testimoniata soltanto dallo scoliasta. È pur vero comunque che il testo ciceroniano, così come viene testimoniato dalla sua tradizione manoscritta, «habeo et istius et patris eius accepi tabulas», deve essere necessariamente emendato, mentre quello attestato nello ps.Asconio sarebbe in sé e per sé coerente. Di questo sembra essersi accorto lo Zumpt (1831: 140), che nella sua edizione delle Verrinae sceglie di mettere a testo la lezione pseudoasconiana habeo…accepti tabulas, meravigliandosi che ciò che lo scoliasta attestava come varia lectio corrisponda alla vulgata nella tradizione delle Verrinae. Lo Zumpt viene seguito dal Klotz (1923), uno dei pochi che riconosce una certa autorità al testo pseudoasconiano, mentre il resto degli editori preferisce emendare il testo tramandato dagli esemplari ciceroniani, non prestando alcuna fiducia alle parole del commentatore tardoantico: c’è chi come Peterson (1917) lascia a testo accepi espungendo habeo, e chi, al contrario, come fanno Mueller (1908) o Greenwood (1966), mantiene habeo ed espunge accepi.
In conclusione, tornando al punto da cui si era partiti, in questo caso si può effettivamente parlare di una glossa di carattere filologico in cui legitur può essere interpretato come legitur in quibusdam codicibus, cosa che – come si è potuto constatare ‒ non può valere allo stesso modo per gli scoli a Verr. II, 1, 34 e a Verr. II, 1, 90. Bisogna inoltre aggiungere che il carattere filologico di questo legitur in Verr. II, 1, 60 non fornisce un elemento a favore della congettura legitur al posto di dicitur nella glossa a Verr. II, 1, 52, in quanto il senso dei due scoli risulta molto differente. Se da un lato, infatti, ab eo et accepi rispetto a habeo accepti di Verr. II, 1, 60 sembra essere una vera e propria variante, la quale differisce non solo nella forma esteriore, ma anche e soprattutto nel significato, dall’altro la nota di commento dello ps.Asconio su quaesitor/quaestor a Verr. II, 1, 52 sembra voler testimoniare soltanto che i due lemmi, malgrado la differente grafia, in età tardoantica venivano ormai percepiti come se fossero la medesima parola con il medesimo significato, motivo per cui il commentatore si premura di spiegarne la differenza semantica. In questa sede si ritiene dunque che nella glossa pseudoasconiana a Verr. II, 1, 52 la congettura legitur, formulata prima dal Danés e poi accolta da Stangl, al posto della lectio vulgata dicitur non sia necessaria e che i paralleli addotti a suo favore, in realtà, mostrino delle situazioni testuali e interpretative ben diverse, tali per cui non possano fungere da sostegno per la congettura stessa.
Se dunque, come è stato evidenziato in questa breve rassegna, è vero che quelle fornite dallo ps.Asconio non possano essere definite delle varianti al testo ciceroniano e che quindi non dimostrino una vera e propria competenza di carattere filologico e critico-testuale da parte dell’anonimo autore degli scholia, è altresì vero che proprio questa tipologia di glosse evidenzia lo stato già piuttosto corrotto e interpolato della tradizione manoscritta delle Verrinae alla prima metà del V sec. d.C. Molte delle lezioni, che l’autore deve aver letto nel codice in suo possesso, risultano apertamente erronee, di modo tale che la lettura da lui fornita di alcuni passi appare di fatto basata su un’interpolazione. Lo stesso commento a Verr. II, 1, 60 trattato supra ne è un esempio manifesto, anche se un altro scolio allo stesso passo rappresenta un caso ancor più evidente di interpolazione, tanto che viene espunta da Stangl nella sua edizione critica (Stangl 1912: 238): «Cum imperio ac securibus. Bene quia licet negotiari equitibus et privatis». «Con pieni poteri e con i segni del comando. Giustamente, perché può trafficare con i cavalieri e con i privati». In riferimento alla giustificazione addotta in tribunale da Verre di aver acquistato quegli oggetti d’arte che gli vengono imputati come ruberie perpetrate durante la legatio Asiatica, Cicerone in questo passo si esprime in maniera fortemente sarcastica affermando che, certo, Verre sarebbe stato inviato a spese pubbliche e con il titolo di coadiutore al governo in Acaia, Caria e Panfilia per fare il mercante di statue e quadri. Sembra sufficientemente chiaro che se Cicerone avesse messo a testo le due parole riportate dallo ps.Asconio, «cum imperio ac securibus», certo non avrebbe aggiunto nella stessa frase «sumpto publico et legationis nomine», «a spese pubbliche e con il titolo di coadiutore al governo», i due ablativi, infatti, veicolano sostanzialmente lo stesso significato, ma con molta meno forza espressiva di cum imperio ac securibus. Quest’ultima espressione era molto probabilmente un’annotazione a margine, glossa poi entrata a testo; dal momento che la stessa formula ricorre in II, 4, 819 il fine del commentatore deve essere stato quello di paragonare i due passi in maniera, tra l’altro, errata, in quanto in II, 1, 60 le parole sono rivolte ad un legato, mentre in II, 4, 8 ad un pretore; questa formula è poi finita con l’essere introdotta nel testo.
Bibliografia
Benario, Herbert (1973), Asconiana, «Historia» 22, p. 64-71.
Clark, Albert C. (1918), The Descent of Manuscripts, Oxford, Clarendon Press, p. 364-382.
Clark, Albert C. (1913), Ciceronis orationum scholiastae, «The Classical Review» 27, 5, 169-170.
Clark, Albert C. (1907), Q. Asconii Pediani Orationum Ciceronis quinque enarratio; recognovit brevique adnotatione critica instruxit Albertus Curtius Clark, Oxford, Clarendon Press, «Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis».
Giarratano, Cesare (1967), Q. Asconii Pediani commentarii, recognovit Caesar Giarratano, Amsterdam, A.M Hakkert.
Giarratano, Cesare (1906), Due codici di Asconio Pediano, il Forteguerriano e il Madrileno, «Studi Italiani di Filologia Classica» 14, p. 195-205.
Greenwood, Leonard Hugh Graham (1935), Cicero, The Verrine Orations with an English translation by L. H. G.Greenwood, II (Against Verres: II, 3, 4 and 5), Cambridge-London, Harvard University Press.
Greenwood, Leonard Hugh Graham (1928), Cicero, The Verrine Orations with an English Translation by L. H. G. Greenwood, I (Against Caecilius, Against Verres: I, II, 1 and 2), Cambridge-London, Harvard University Press.
Klotz, Alfred (1923), M. Tulli Ciceronis Scripta quae manserunt omnia, V in Q. Caecilium divinatio, in C. Verrem actio I et II, recognovit A. Klotz, Lipsia e Berlino, Teubner Verlag.
Knust, Heinrich Friedrich (1843), Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesammtausgabe der Quellenschriften deutscher Geschichten des Mittelalters, vol. 8, p. 152, Hannover, Weidmann.
Madvig, Johan Nikolai (1828), De Q. Asconii Pediani et aliorum veterum interpretum in Ciceronis orationes commentariis disputatio critica, Copenaghen, Typis H.F. Popp.
Schmiedeberg, Paul (1905), De Asconi codicibus et de Ciceronis scholiis sangallensibus, Breslau, Grass, Barth & comp.
Stangl, Thomas (1912, 1964), Ciceronis orationum scholiastae: Asconius, Scholia Bobiensia, Scholia Pseudasconii Sangallensia, Scholia Cluniacensia et recentiora Ambrosiana ac Vaticana, Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum excerpta Lugdunensia, Hildesheim, Georg Olms Verlag.
Stangl, Thomas (1910), Asconiana, «Philologus» 69, p. 489-550.
Stangl, Thomas (1909), Pseudoasconiana: textgestaltung und sprache der anonymen Scholien zu Ciceros vier ersten Verrinen auf Grund der erstmals verwerteten altesten Handschriften, «Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums», vol. 2, Padeborn, Schöningh Verlag.
Zumpt, Karl Gottlob (1831), M. Tulli Ciceronis Verrinarum libri septem ad fidem codicum manuscriptorum recensuit et explicavit C. T. Zumptius, Berlino, Dümmler Verlag.
Note
- La datazione relativa a questa figura di studioso si basa sull’interpretazione di un passo di Girolamo in cui per l’anno di Abramo 2092 (76 d. C.) si parla di uno scriptor historicus: «Q. Asconius Pedianus scriptor historicus clarus habetur. Qui LXXIII aetatis suae anno captus luminibus duodecim postea annis in summo omnium honore consenescit». Tralasciando in questa sede le argomentazioni che hanno portato a preferire i 73 anni d’età, citati nel passo, come data d’inizio della sua cecità e non della sua morte (Benario 1973), oggi, seguendo il Madvig (1828), si propende per una cronologia che pone il 3 d.C. come data di nascita di Asconio e l’88 d.C. come anno della sua morte.
- In una lettera mandata da Poggio a Guarino Veronese si trova scritto: «Haec mea manu transcripsi, et quidem velociter, ut ea mitterem ad Leonardum Aretinum et Nicolaum Florentinum». (edita in Epistolari, vol. IV, ep. 5 a cura di H. Harth, Olschki, Firenze 1984-87).
- L’explicit del codice recita: «Finis argumentorum quorundam Orationum Ciceronis, eorum, quae invenimus in Monasterio Sancti Galli, quae licet imperfecta et in compluribus locis corrupta esse videantur, non mediocrem tamen bene studentibus poterunt utilitatem afferre. Die XXV. Julii MCCCCXVI. B. de Montipoliciano».
- Opera che sappiamo Poggio Bracciolini trovò in Inghilterra tra il 1419 e il 1422.
- Shmiedeberg (1905), sulla base della tinta fortemente nera che caratterizza una di esse, crede che questa sia più recente delle altre due.
- «C. valeri flacci argonauticon. Hoc fragmentū repertū est in monasterio sancti galli prope costantiā XX milibus passum una cū parte Q. asconii pediani. Deus concedat alteri, ut utrumque opus reperiat perfectum. Nos quod potuimus egimus. Poggius florentinus».
- Schmiedeberg (1905), dopo un’attenta collazione dei codici, dimostra come tale conclusione sia assolutamente errata.
- Stangl (1884) ha dimostrato come in trenta passi Sozomeno non ha tanto trascritto, quanto semmai emendato il testo tradito, soprattutto per quanto riguarda gli scholia alle Verrinae. Si tratta di interventi di omissione (145, 5); trasposizione (158, 24; 180, 6; 187, 20; 200, 2; 200, 14; 209, 8); congettura (99, 16; 107, 7; 107, 18; 131, 14; 139, 4; 141, 21; 154, 13; 159, 16; 161, 15; 201, 21); interpolazione (120, 14; 128, 2; 130, 18; 132, 16; 139, 20; 148, 17; 171, 9; 171, 10; 177, 24; 181, 9; 203, 4; 203, 12).
- La prima rivalutazione di P, M e S si trova in Madvig (1828).
- Si tratta del dibattito preliminare con cui si apre il corpus di sette orazioni giudiziarie raccolte sotto il titolo di Verrinae e finalizzato a stabilire chi avrebbe assunto il ruolo di accusatore per conto dei Siciliani al processo contro Gaio Licinio Verre. Nell’orazione Cicerone denuncia e reprime il piano di Verre, dimostrando che quest’ultimo voleva imporre in qualità di accusatore proprio questo tale, Quinto Cecilio, finanziato da lui, così da avere la meglio in tribunale.
- È il caso, ad esempio, del commento al passo II, 1, 15 (Stangl 1912: 228) dove dubita se con ostilità iustae si intenda magnae, cosa che grammatici quali Servio e Donato rilevano in un passo virgiliano (Georg. III, 347).
- Exempli gratia II, 1, 114 (Stangl 1912: 248): «Hoc populus Romanus non manu vindicasset. Confusa locutio: abundare enim videtur “non”». «Il popolo romano non si sarebbe già vendicato con la violenza di questo. Locuzione di difficile lettura: sembra, infatti, esserci un “non” in eccedenza».
- II, 1, 11 (Stangl 1912: 226): «Ad aliud iudicium. Populi scilicet et equitum R.». «Ad un altro giudizio. Si intende, evidentemente, del popolo e dei cavalieri romani». Lo ps.Asconio non si accorge che Cicerone dice questo non in merito ad un nuova tipologia di tribunale, ma in riferimento ad un’altra inchiesta, quella cioè per l’accusa di peculato.
- È il caso, ad esempio, della differenza tra suscipio e recipio nel commento a Div. 8 e in II, 2, 1.
- La questione cronologica è stata recentemente ripresa da Benario (1973), il quale, confermando la tesi del Madvig (1828) che poneva l’anonimo autore nel V sec. d.C., si persuade di giungere ad una datazione più precisa sulla base di alcuni riferimenti testuali: un periodo di composizione compreso tra il 417, anno di pubblicazione delle Historiae adversos paganos di Orosio, che il nostro autore mostra di conoscere, e il 550, data entro la quale i ludi circenses prendevano ancora posto nel Circo Massimo, luogo in cui l’anonimo autore in una glossa afferma di avervi assistito.
- Ciceronis orationum scholiastae: Asconius, Scholia Bobiensia, Scholia Pseudoasconii Sangallensia, Scholia Cluniacensia et recentioria Ambrosiana ac Vaticana, Scholia Lugdunensia sive Gronoviana et eorum excerpta Lugdunensia, edita a Hildesheim nel 1912 e successivamente nel 1964 per Georg Olms.
- Ps.Asc. ad Div. Stangl 188, 2-3: «Sunt etiam qui delubra ligna delibrata, id est decorticata, pro simulacris deorum more veterum posita existiment, sed male». «C’è anche chi intende, ma in maniera errata, delubra come simulacri di legno scortecciato, cioè privato della corteccia, posti secondo l’uso antico in luogo delle effigi degli dei».
- Il Parisinus lat. 7775 (D) e il Parisinus lat. 7776 (p) con tutti gli esemplari che da questi discendono presentano la lezione «habeo et istius et patris eius accepi tabulas».
- Cic. Verr. II, 4, 8: Mercatorem in provinciam cum imperio ac securibus misimus, omnia qui signa, tabulas picta, omne argentum, aurum, ebur, gemmas coemeret, nihil cuiquam relinqueret! «Sta a vedere che noi in provincia abbiamo mandato un mercante con pieni poteri e con i segni del comando perché facesse incetta di tutte le statue e i quadri, di tutti gli oggetti d’argento, d’oro, d’avorio, di tutte le pietre preziose, senza lasciare niente a nessuno!» (trad. D. Vottero).