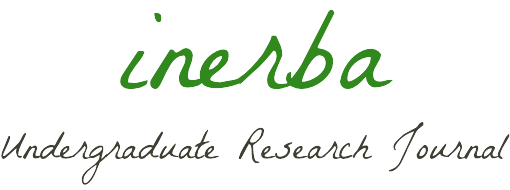Introduzione
L’obiettivo alla base di questo lavoro è mettere in dialogo il film Big Hero 6 con il mitologema e psicologema prometeici. Big Hero 6 è un film d’animazione del 2014 realizzato in collaborazione da Walt Disney Pictures e Marvel Studios, regia di Don Hall e Chris Williams1.
Si desidera avvalorare l’ipotesi interpretativa secondo la quale, nell’opera cinematografica, gli elementi prometeici che, come vedremo, si polarizzano assiologicamente in positivi e negativi, non si focalizzano su un personaggio centrale, ma si parcellizzano in più attanti. Il testo si presenta diviso in nove parti volte ad analizzare narratologicamente i fatti principali della fabula di Big Hero 6 da un punto di vista narratologico. Una parte di questo contributo sarà inoltre dedicata all’esplorazione dei personaggi centrali del film in chiave psicodinamica. Infine, a un inquadramento teleologico-assiologico degli eventi più importanti, segue la sezione dedicata alle conclusioni: verranno presentati i risultati ottenuti dall’applicazione del mitologema e psicologema prometeico all’opera cinematografica.
Tra parcellizzazione prometeica e narratologia applicata
Come accennato nello spazio introduttivo, si è preferito focalizzare l’indagine della parcellizzazione prometeica su quegli attanti nei quali sono stati riscontrati i tre più salienti tratti fenomenologici e caratteriali del mito: la figura proiettata nel futuro e nel progresso che si spende per offrire al mondo un’esistenza migliore applicando le regole del pensiero razionale, il plasmatore di strumenti tecnologici sofisticati, animati con mezzi scientifici e, infine, la connessione all’elemento naturale del fuoco2.
Si è deciso inoltre di incrociare questa selezione con una ricerca semiologica mirata a ricostruire il valore antropologico dei personaggi a partire dalla loro onomastica. In Big Hero 6 ogni nome proprio è parlante poiché rappresenta simbolicamente aspetti dell’attante o funzioni che esso svolge nella storia3. In ordine di apparizione si riportano:
- Hiro, nome polisemico giapponese riconducibile agli aggettivi «abbondante, generoso» (Koop e Inada 1922: 80).
- Tadashi, nome giapponese che a seconda del sistema di scrittura è traducibile con «sincero, onesto» (Koop e Inada 1911: 356).
- Robert, nome gotico-germanico che significa «illustre per gloria» (Burgio 1992: 303).
- Alistair, variante anglicizzata del nome greco Alexandros: «protettore degli uomini» (Burgio 1992: 37).
- Yōkai, nome di origine cinese che significa «ambiguo, dubbio» (Foster 2009: 13). Utilizzato anche nella cultura giapponese come sostantivo per indicare esseri soprannaturali tanto spaventosi quanto giocosi.
Una volta acquisite queste prime competenze di codice di lettore ideale, è possibile riscontrare il dualismo tra la tradizione giapponese e anglo-americana dell’onomastica anche nello spazio narrativo nel quale si verificano le vicende. Il film è ambientato nella città californiana di San Fransokyo, concepita in un futuro alternativo e hi-tech che è un ibrido tra San Francisco e Tokyo. La metropoli ospita l’università di robotica San Fransokyo Institute of Technology (SFIT), luogo di altissima valenza semico-simbolica.
Plasmatore e soggetto tecnologico
«I’m not giving up on you»4 (Tadashi Hamada).
Tadashi, studente presso la SFIT, è rappresentazione positiva del prometeico e dell’archetipo junghiano del senex. Sin dalle prime scene, Tadashi si mostra come un personaggio alimentato dal valore etico dell’altruismo e della difesa della vita in ogni sua forma. Per questo, si dedica a sfruttare il suo straordinario intelletto a beneficio dell’umanità. Grazie all’instancabile impegno e duro lavoro che lo contraddistinguono, ha brillantemente portato a termine il suo programma d’azione di plasmatore assemblando Baymax, un operatore sanitario personale robot.
«The only limit is your imagination»5 (Hiro Hamada).
Hiro, fratello minore di Tadashi, è un ragazzo eclettico che sin da piccolo ha mostrato un ingegno così spiccato da diplomarsi a 13 anni, superando in potenzialità intellettive i coetanei e ben presto anche il fratello. Questo fattore è responsabile del suo isolamento dagli altri e della volontà di non conseguire un titolo di studio universitario, bensì di coltivare le sue illimitate conoscenze di robotica da autodidatta. Inizialmente, l’unica occupazione di Hiro è costruire microbot da combattimento per competere e lucrare sulle gare clandestine della città. Di fronte a questo spreco di talento, Tadashi fa emergere il suo psicologema di senex, da buon fratello maggiore volenteroso di guidare Hiro verso un uso più responsabile del suo genio. Lo sfida a candidarsi alla SFIT, spiegando che per essere accettato è necessario impressionare il professor Robert Callaghan in occasione della fiera annuale di ammissione all’università. Per aggiudicarsi l’accesso, Hiro si dedica in maniera inflazionata alla riproduzione in serie dei microbot e di un trasmettitore neurocranico che ne permette il controllo telepatico. La genialità di quest’invenzione susciterà l’interesse delle due figure più influenti dell’università: Robert Callaghan e Alistair Krei.
«My students go on to shape the future»6 (Robert Callaghan).
Callaghan è un docente e direttore dei laboratori di robotica della SFIT, nonché il membro più importante della commissione per l’accesso all’università. È celebre nella comunità scientifica per aver inventato i servomotori e i cuscinetti elettromagnetici.
«We were asked to do the impossible. That’s what we did»7 (Alistair Krei).
Oltre a essere il secondo membro più importante della commissione per l’accesso all’università, Krei è fondatore della Krei Tech: un’illustre azienda di prodotti tecnologici avanzati e innovativi.
Questo personaggio sfrutta la tecnologia a fini di lucro, a differenza di Callaghan, il quale predilige la ricerca accademica a discapito del suo utilizzo commerciale. Questa loro incolmabile distanza di pensiero è esemplificata efficacemente nelle interazioni che hanno con Hiro al termine della sua presentazione. Krei afferma: «I want your microbots at Krei Tech»8 e Callaghan, invece, sostiene: «You can continue to develop [your microbots], or you can sell them to a man who’s only guided by his own self-interest»9.
Analizzando il loro fare discorsivo secondo le funzioni della comunicazione di Jakobson è evidente che la produzione testuale del primo si carica di una spiccata funzione emotiva, incentrata sull’egoità del personaggio, a differenza del secondo che produce un testo di funzione conativa.
Il fuoco: elemento distruttore e trasformatore
Proseguendo con la lettura del film in chiave narratologica, il racconto continua nel suo sviluppo con una prima manifestazione di quello che Tomasevskij (1978: 186) definisce «motivo legato». Esattamente come l’immagine archetipica ambivalente di Prometeo, il motivo legato più importante di Big Hero 6 non poteva che essere connesso all’elemento ambivalente per eccellenza: il fuoco o, in questo caso, un improvviso incendio che divora l’università al termine della fiera. Tadashi apprende da una studentessa che Callaghan è vi rimasto bloccato all’interno ed espleta, così, il suo programma d’azione di difensore della vita offrendosi di entrare per soccorrerlo, affermando: «someone has to help». Dopo essersi precipitato nella struttura, questa esplode violentemente con ancora Tadashi e Callaghan all’interno.
In questa scena la commistione di tratti oscuri e luminosi del fuoco è più che mai evidente: stronca due vite, distrugge un edificio e trasforma la SFIT, in termini di Greimas (2000: 126), da uno spazio «euforico» a uno «disforico». Oltre a essere determinante per lo sviluppo della trama successiva, l’incendio è un evento che trasforma irreversibilmente la psicologia dei personaggi, le cui forme archetipiche acquisiscono ora dei tratti ben distinti.
Grazie ai contributi di Hillman (2014) e Bachelard (1964), il mitologema prometeico è interpretabile anche come forma della psiche umana, ovvero, come psicologema. Il Prometeo moderno è quindi risemantizzato come un ambizioso che sfida l’autorità costituita per portare innovazione e, a questo scopo, è propenso a forzare i tempi o, ancora, a ingannare e violare le leggi della vita. Avvalendosi di queste nozioni, è possibile studiare la fenomenologia dei personaggi secondo il paradigma archetipico dell’Ombra e del Trickster.
Ricostruzione della fabula
Nel corso della narrazione cinematografica, attraverso un’analessi, lo spettatore apprende che l’incendio è stato appiccato da Callaghan stesso il quale, in realtà, è riuscito a salvarsi dall’esplosione impossessandosi del neurotrasmettitore per il controllo dei microbot. Le azioni di Callaghan, ora nel suo doppio Yōkai, sono dettate da due moventi correlati tra loro. Il professore ha rubato i microbot di Hiro per vendicarsi di Krei il quale, in passato, ha condotto un esperimento sul teletrasporto quantico. Per questo progetto ha coinvolto come pilota della navicella Abigail Callaghan, la figlia del professore, la quale, pochi secondi dopo aver varcato la soglia del portale, è rimasta bloccata nell’alterazione spazio-temporale. Costruendo un parallelismo con il mitologema classico, è possibile rilevare delle affinità tra Abigail e Pandora. Sebbene la prima non presenta le caratteristiche comportamentali della seconda, risulta comunque essere origine di discordia tra altri due attanti.
L’archetipo Ombra
L’archetipo Ombra è illustrato da Jung (2019: 38) come un’entità che rende visibili aspetti inconsci e regressivi del singolo, aspetti che quest’ultimo non accetta come facenti parte della propria personalità. Nel film è perfettamente incarnato da Yōkai, doppio oscuro e brutale che porterà Callaghan alla follia e all’ignominia. Nonostante l’affermato professore a primo impatto risulti essere una figura positiva, in realtà, è profondamente corrotto a livello morale e psichico. Proprio come il Prometeo romantico, manifesta l’elemento della liminalità, tipico del satanico, in quanto personaggio caratterizzato da un’iniziale purezza che, col progresso della catabasi, resta solo un lontano ricordo.
L’archetipo del Trickster: Robert Callaghan
L’acquisizione di questa nuova competenza di codice di lettore ideale permette di avvalorare la tesi di Callaghan anche come Trickster. Si tratta di un archetipo dotato di tratti fenomenologici ben definiti: sovvertitore dello status quo che assottiglia i confini tra polarità in contrapposizione come verità e menzogna, lecito e illecito servendosi delle sue capacità retoriche e manipolatorie10. Lo studio di questa figura risulta essere interessante anche da un punto di vista narratologico in quanto funge da cerniera dell’intreccio, producendo una trasformazione della situazione narrativa. Proprio come il Trickster, anche Callaghan è un soggetto menzognero che intesse le fila nascoste della vicenda principale. Nascoste come le fattezze del suo volto, coperto da una maschera kabuki usata per portare avanti il suo programma d’azione di ladro. La scelta di menzionare indirettamente il teatro kabuki autorizza a mettere in dialogo Big Hero 6 con questo elemento della tradizione giapponese. In tali rappresentazioni la staticità degli attori suggerisce l’idea di trascendenza dei limiti del presente e universalità delle tematiche calcate sulla scena. L’utilizzo della maschera diventa simbolo di un’atemporalità dei valori, tra i quali benevolenza, empatia e autocontrollo: virtù esaltate nei Bushidō degli eroici samurai e, proprio per questo, assenti in Yōkai.
Essenziale ricordare che Callaghan si è appropriato illecitamente dei microbot e del neurotrasmettitore di Hiro come strumento per i suoi scopi di vendetta. Interessante notare come l’interpretazione allegorica di Prometeo formulata da Boccaccio (1998: 449-459), nel film sia ribaltata nel suo contrario. Difatti, Yōkai ladro non è vettore di civilizzazione, ma bensì portatore di distruzione e, più in generale, rappresentazione di istinti brutali e animaleschi diametralmente opposti all’idea di cultura e civiltà umana.
Hýbris reazionaria e rivoluzionaria
Yōkai pecca di hýbris reazionaria per la sua volontà di ricostruire il portale al fine di trascinarvi all’interno Krei e tutto il suo impero. Il suo orgoglio è rappresentato dalla frase «my daughter is gone because of your arrogance! You took everything from me, now I’m taking everything from you!»11. Con questa dichiarazione Callaghan esibisce la sua istintualità brutale attraverso il processo psicologico della proiezione: estroietta su un altro soggetto caratteristiche negative di sé che, a livello conscio, non accetta. Scagliarsi contro Krei è un meccanismo attraverso cui il professore nega l’evidenza di essere lui il vero criminale arrogante. Esaminando con più attenzione la frase soprariportata, si può evincere che l’attante reagisce alla scomparsa di Abigail applicando la legge del taglione. Arreca al suo nemico un’uguale lesione a quella subita legittimando la giustezza delle azioni che sta per compiere: essendo lui la prima parte lesa, si investe del diritto di distruggerlo.
Se Callaghan pecca di hýbris reazionaria, a sua volta Krei pecca di hýbris rivoluzionaria. Pur di ottenere investitori per il suo progetto di teletrasporto quantico, in occasione di una dimostrazione al governatore americano, Krei ignora volontariamente delle irregolarità nei valori del campo magnetico del portale: decisione che ha condotto al fallimento dell’esperimento e alla presunta morte di Abigail.
L’archetipo del Trickster: Hiro Hamada
Un altro personaggio che mostra tratti dell’archetipo del Trickster è Hiro il quale, dalla morte del fratello, ne eredita il motto «look for a new angle»12. Nella soluzione dei problemi, infatti, occorre essere in grado di rompere con gli schemi, cambiare prospettiva e dinamizzare i processi cognitivi momentaneamente in stallo.
In seguito al sacrificio di Tadashi, Hiro trova nella sua creatura, Baymax, un amico, nonché compagno fondamentale per fare chiarezza sulla natura dell’incendio. A questo scopo, però, lo trasforma in un colosso da combattimento realizzandogli un’armatura e codificando un chip contenente mosse di karate.
Durante un primo scontro con Yōkai nel quale, senza rimorso, il criminale confessa di aver abbandonato Tadashi al suo tragico destino, Hiro viola il protocollo di Baymax. Senza il consenso del compagno, gli rimuove il chip di operatore sanitario e mantiene quello da combattimento per poi ordinargli di uccidere Callaghan. In questa scena lo spettatore attento rileva l’inserimento di due elementi dell’immaginario collettivo nipponico: le arti marziali e l’introiezione della colpa prometeica altrui nelle vittime.
È autoevidente l’elemento del thanatos: mortifero nel primo caso e distruttivo nel secondo. Baymax in quanto karateka e ancor di più in quanto operatore sanitario è familiare con i centri energetici vitali e letali del corpo umano. Malgrado il robot sia stato inizialmente costruito per sfruttarli al fine di rigenerare e preservare la salute, quando privato del corrispettivo chip, agisce per condurre la vittima designata alla morte. È legittimo dedurre che siano proprio tali componenti elettronici a costituire la coscienza di Baymax e a permettergli di elevarsi dalla condizione di mero automa.
Considerazioni come queste sono ascrivibili alla consuetudine giapponese di riportare negli anime e nei manga preoccupazioni per gli effetti negativi del prometeico tecnologico. L’esperienza della bomba atomica ha segnato così a fondo la psicologia collettiva che nei prodotti culturali la colpa altrui è stata introiettata nell’immaginario delle vittime. Vittime come Baymax il quale, essendo privo di una coscienza propriamente detta, non poteva che agire come il robot quale è.
Hiro commette una violazione della norma che, a suo giudizio, è funzionale al rispetto di una norma più ampia: ottenere giustizia per la morte di Tadashi. Risulta evidente che il ragazzo è mosso dalla convinzione di far prevalere gli aspetti libertari, legati all’autodeterminazione individuale e all’autonomia decisionale. In realtà, prevaricando sulla vera essenza di Baymax, le sue azioni riflettono gli aspetti psicologici e attanziali legati all’ambito dell’autoritarismo, dell’ingiustizia, dell’ineguaglianza.
Alla luce di questi eventi è possibile riscontrare come, in quanto Trickster, né la condotta di Hiro né di Callaghan siano giudicabili secondo una visione strettamente manichea. Sarebbe riduttivo sostenere che entrambi siano colpevoli ma, allo stesso tempo, non possono neppure essere considerati innocenti. Entrambi, infatti, hanno mostrato l’elemento negativo del prometeico seppur soltanto perché accecati dall’opprimente senso di vuoto che la morte di una persona cara ha lasciato nella loro vita.
Tra riscatto e compassione: Baymax e Hiro Hamada
Per Hiro, tuttavia, il percorso di riscatto e riscoperta del valore della compassione inizia quando Baymax, sempre più umano e sempre meno robot, lo invita a riflettere sulla convinzione che la morte di Callaghan lo farà davvero sentire meglio. A sostegno del contrario, con un’analessi, gli mostra alcuni degli ottantaquattro tentativi necessari a Tadashi per il perfezionamento di Baymax, al quale non si è mai arreso perché fortemente motivato ad aiutare quante più persone possibili. Così facendo, il robot diventa personificazione degli aspetti positivi della personalità di Tadashi e, di riflesso, di Hiro. Aspetti legati al valore della speranza e alla possibilità di concepire una rivoluzione non violenta. Alla fine del video, Hiro acquisisce consapevolezza delle sue ultime azioni nelle quali non si riconosce e decide di prendervi le distanze. Il recupero da parte di Hiro del suo programma d’azione di difensore della vita latentizzato è lampante nella frase che rivolge a Yōkai durante lo scontro finale: «our programming prevents us from injuring a human being»13.
Mentre il portale quantico è sul punto del collasso, Baymax rileva all’interno la presenza di Abigail, ancora viva. Senza pensarci due volte Hiro afferma: «she’s alive in there. Someone has to help»14. Da un punto di vista di organizzazione logico-sintattica della frase, è significativo rilevare come questa si connoti di una funzione poetica. Il testo è orientato sul livello del messaggio, al fine di attirare l’attenzione dello spettatore sul fatto che Hiro abbia appositamente ripetuto le stesse parole pronunciate da Tadashi prima di morire. Dopo essersi precipitati all’interno del varco, Baymax e Hiro ritrovano Abigail ma, nel tragitto per raggiungerla, i propulsori dell’armatura del primo vengono danneggiati. Pur di salvare Hiro e la figlia di Callaghan in tempo, il robot si sacrifica usando il suo pugno a razzo come spinta per farli uscire dal portale, nel quale rimane rinchiuso.
Il trionfo della libertà e dell’autodeterminazione individuali
In seguito a un’ellissi, lo spettatore è invitato a ricostruire la logica degli eventi successivi alla perdita di Baymax. La narrazione riprende in medias res mostrando Hiro che, nel vecchio laboratorio di Tadashi, scopre il chip sanitario di Baymax nel palmo del pugno a razzo. È plausibile colmare il vuoto informativo ipotizzando che prima di separarsi, da non visto, Baymax si sia rimosso il componente elettronico lasciandolo nel pugno affinché Hiro lo utilizzasse per ricostruirgli un nuovo corpo. Il film si conclude con i due amici che, dopo la riattivazione di Baymax, si scambiano un abbraccio.
Conclusioni
Big Hero 6 è un film d’animazione che presenta un futuro alternativo nel quale viene indagata la correlazione tra progresso tecnologico e morale: come avere la certezza che al primo corrisponda necessariamente il secondo?
In quanto appartenente al genere fantascientifico, il film esplora tematiche affini ai generi letterari della hard sci-fi come la descrizione dettagliata e verosimile di componenti tecnologici (es. «magnetic-bearing servos» o «hyperspectral cameras»15) o ancora della British New Wave quali l’attenzione allo stato psicologico e al contesto relazionale nel quale i personaggi agiscono.
Nel film si rileva anche l’inserimento di un concetto tipico della letteratura postmoderna: l’entropia. In Big Hero 6 tale fenomeno è analizzato sia da una prospettiva esterna che interna agli attanti. Nel primo caso, è intesa come distruzione antropica dell’equilibrio sistemico rappresentata, per esempio, dal ritorno in funzione del portale o ancora dall’introiezione della colpa altrui nell’immaginario delle vittime: risultato dell’esperienza della bomba atomica. Nel secondo caso, il concetto di entropia è applicato alla mente dei personaggi, i quali, in un primo momento, sembrano essere centrati e con identità forti: caratteristiche che nel tempo vengono alterate. I percorsi trasformativi della psiche di Callaghan e di Hiro, benché possano sembrare affini, presentano una differenza sostanziale. L’integrità etica del professore intraprende un processo di catabasi che lo conduce allo sgretolamento del sé e alla prevaricazione di Yōkai. Il percorso mentale di Hiro, invece, ricalca quello del cammino dell’eroe. Dall’abisso morale riemerge grazie a un’anabasi in cui l’umano si eleva allo spirito attraverso la compassione, sentimento che prova verso Callaghan quando comprende che per lui la violenza è inevitabile e giusta da infliggere.
In ultimo, si desidera offrire un’interpretazione dell’onomastica dei personaggi alla luce delle considerazioni attanziali e psicologiche esposte nel saggio. Si osservano due casistiche opposte: nomi in cui vi è una corrispondenza tra significato etimologico e fenomenologia attanziale (Hiro, Tadashi e Yōkai) e nomi al cui significato etimologico viene applicato il procedimento antifrastico (Robert e Alistair). Esaminando quest’ultima casistica è interessante riscontrare come, sebbene Robert significhi «illustre per gloria» (Burgio 1992: 303), le azioni di questo personaggio sono tutt’altro che gloriose, bensì contaminate dalla sete di potere e rivalsa contro il nemico. Alistair significa «protettore di uomini» (Burgio 1992: 37), ma l’unica persona che Krei tutela è sé stesso dal momento che, pur di consolidare la sua posizione socioeconomica, non si è fatto scrupoli a mettere a repentaglio la vita di Abigail.
Per quanto si possa pensare che il film sia destinato a un pubblico infantile, è chiaro che dei bambini non possono comprendere a fondo la sottigliezza del racconto di formazione che è Big Hero 6. Un’opera cinematografica che, senza dubbio, necessita di essere riguardata più volte al fine di pervenire a un’interpretazione quanto più possibile all’altezza della sua complessità segnica, psicologia e simbolica.
Bibliografia / Sitografia / Filmografia
Bibliografia
Bachelard, Gaston (1964), Psychoanalysis of Fire, Londra, Routledge e Kegan Paul.
Boccaccio, Giovanni (1998), «Genealogie deorum gentilium», In: Zaccaria V., Branca V., (dir.) Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, Milano, Mondadori, p. 449-459.
Burgio, Alfonso (1992), Dizionario dei nomi propri di persona, Terni, Hermes Edizioni.
Callahan, Tim (1991), Devil, Trickster and Fool, «Mythlore», 4, 17, p. 29-34, 36.
Foster, Michael Dylan (2009), Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yōkai, Berkeley, University of California Press.
Genette, Gerard (1976), Figure III. Discorso del racconto, Torino, Einaudi.
Greimas, Algirdas Julien (2000), Semantica strutturale. Ricerca di un metodo, Roma, Meltemi Editore.
Hillman, James (2014), Figure del mito, Milano, Adelphi.
Jung, Carl Gustav (2019), Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Torino, Bollati Boringhieri.
Koop, Albert James e Inada, Hogitaro (1922), Japanese Names and How to Read Them: A Manual for Art Collectors and Students, Londra, Bernard Quaritch.
Maurone, Joseph (2002), The Trickster Icon and Objectivism, «The Journal of Ayn Rand Studies», 2, 3, p. 229-258.
Nitobe, Inazo (2021), Bushido. L’anima del Giappone, Varese, Crescere edizioni.
Robbins, Dorothy Dodge et al. (2023), Literary Onomastics, Lanham, Rowman & Littlefield.
Tomasevskij, Boris (1978), Teoria della letteratura, Milano, Feltrinelli.
Sitografia
«Big Hero 6 – Rassegna stampa», In: Mediateca Toscana Lanterne Magiche, consultato il 08/09/2024, URL: <https://www.mediatecatoscana.it/wpcontent/uploads/2020/03/Big-Hero6_Rassegna_Stampa.pdf>.
«Yokai: Ghosts & Demons of Japan», In: Museum of International Folk Art, consultato il 08/09/2024, URL: <https://yokai.moifa.org/#/>.
Filmografia
Big Hero 6 (2014), diretto da Don Hall e Chris Williams, Stati Uniti, Walt Disney Pictures.
Note
- <https://www.mediatecatoscana.it/wp-content/uploads/2020/03/Big-Hero-6_Rassegna_Stampa.pdf>.
- Sul concetto di evoluzione mitopoietica di Prometeo si vedano Callahan 1991, Hillman 2014.
- Sul concetto di nomi propri correlati a valori lessicali si veda Robbins 2023.
- Big Hero 6 (2014), min. 00:15:15.
- Big Hero 6 (2014), min. 00:19:29.
- Big Hero 6 (2014), min. 00:14:18.
- Big Hero 6 (2014), min. 01:04:57.
- Big Hero 6 (2014), min. 00:20:13.
- Big Hero 6 (2014), min. 00:20:22.
- Per ulteriori approfondimenti sulla figura del Trickster si vedano Callahan 1991, Maurone 2002.
- Big Hero 6 (2014), min. 01:17:17.
- Big Hero 6 (2014), min. 01:20:07.
- Big Hero 6 (2014), min. 01:23:20.
- Big Hero 6 (2014), min. 01:24:34.
- Big Hero 6 (2014), rispettivamente min. 00:13:39 e 00:12:38.