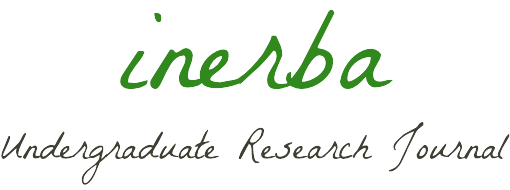Introduzione
Il mitologema prometeico è un tema ricorrente nella letteratura. Come afferma Weiner (2018), esso è multiforme, è un fenomeno che assume molteplici sfaccettature in funzione di vari fattori, quali la posizione geografica, il mezzo di cui ci si serve e il tempo storico dell’autore. Innegabilmente, nella letteratura occidentale, il prometeico assume infinite forme, a partire dal sapiente Titano che dona all’uomo la conoscenza di Boccaccio, fino all’ambizioso e meschino Prometeo di Mary Shelley o al rivoluzionario e ribelle benefattore di Percy Bysshe Shelley. Senza dubbio, il mitologema e lo psicologema prometeici sono una presenza quasi costante nel corso dei secoli e continuano a essere riproposti nelle opere contemporanee. In questo breve saggio andremo a interrogarci su un genere letterario ancora poco studiato: il fantasy. Nello specifico, indagheremo il prometeico nella saga di Throne of Glass (Maas 2012-2018), un’opera fantasy contemporanea della scrittrice statunitense Sarah J. Maas.
Lo sviluppo del genere fantasy
Prima di addentrarci nel mondo di Prometeo, ritengo necessaria una breve introduzione sullo sviluppo del fantasy. Si tratta di un genere letterario relativamente giovane, la cui nascita come genere a sé stante è da collocare tra il XIX e il XX secolo (Nikolajeva 2003). Non è semplice classificare un’opera fantasy, possiamo tuttavia identificare alcune caratteristiche che accomunano i romanzi facenti parte di questo genere. Solitamente, assistiamo a una lotta tra il bene e il male, anche se, spesso e volentieri, l’appartenenza dei personaggi all’una o all’altra categoria non è netta. I protagonisti si trovano ad affrontare delle prove che dovranno superare per il bene comune, questo perché il fantasy deriva in buona misura dalle fiabe, di cui mantiene alcuni tratti caratteristici (Egoff 1988). È ricorrente anche il tema del viaggio, durante il quale i personaggi si trovano ad affrontare determinate situazioni che porteranno a una loro crescita personale1. Infine, una caratteristica imprescindibile di questo genere, è l’esistenza di un mondo magico e di esseri fantastici (Pagan 2020). Le tematiche ricorrenti sono legate al folklore e alla tradizione popolare; infatti, spesso incontriamo esseri mitologici provenienti dalle tradizioni più disparate, basti pensare ad esempio agli elfi o ai nani di origine norrena2.
Anche dal punto di vista stilistico si possono individuare alcune caratteristiche comuni a buona parte dei romanzi fantasy. La creazione di un nuovo mondo da parte dell’autore porta inevitabilmente alla creazione di una grande quantità di neologismi e all’utilizzo di numerose sequenze descrittive molto dettagliate, necessarie per la definizione di questa nuova realtà in cui il lettore si sta addentrando. In un buon fantasy, il ritmo narrativo è incalzante e gli eventi si succedono rapidamente, inoltre sono comuni i colpi di scena (Pagan 2020).
Una tappa molto importante nello sviluppo di questo genere è il Medioevo, durante il quale iniziano a circolare i romanzi cavallereschi3. Questi ultimi possono essere considerati gli antenati dei romanzi fantasy, tali opere presentano molti dei tratti che abbiamo elencato qui sopra, come il tema del viaggio. Non dimentichiamo, inoltre, che buona parte dei romanzi cavallereschi presenta al suo interno elementi sovrannaturali; ricordiamo tra gli altri le avventure di King Arthur and his Knights of the Round Table, appartenenti al Ciclo Bretone o l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto che fa parte, invece, del Ciclo Carolingio.
Si dovrà tuttavia attendere la fine dell’Ottocento per assistere al vero e proprio sviluppo del genere fantasy. Ci troviamo in un contesto storico ben preciso, in cui la rivoluzione industriale ha stravolto il modo di vivere e si ha la necessità di evadere dalla realtà e da tutti i cambiamenti socioculturali intercorsi. Si ricercano le proprie origini nella mitologia e nella tradizione popolare, andando a ripescare tutti quegli elementi fantastici e naturali diametralmente opposti alla tecnologia invasiva del presente. Siamo nel periodo romantico, durante il quale si sviluppa anche il romanzo gotico, che presenta a sua volta elementi sovrannaturali, caratterizzato tuttavia da atmosfere cupe ed eventi volti a spaventare il lettore (Punter 2016). In questo scenario si annoverano opere come The Castle of Otranto, di Horace Walpole (1764) e Dracula di Bram Stoker (1897), nonché l’opera di Mary Shelley, Frankenstein or the Modern Prometheus (1818).
È in questo contesto, durante la seconda metà dell’Ottocento, che nasce il genere fantasy (Gates, Steffel, Molson 2003). Iniziano a delinearsi due filoni narrativi distinti: uno per bambini e l’altro per adulti. Tra le prime opere fantasy per bambini abbiamo Alice’s Adventures in Wonderland (1865) e Alice through the Looking Glass (1871) di Lewis Carroll e The Wonderful Wizard of Oz (1900) di L. Frank Baum. I primi veri e propri romanzi fantasy concepiti per un pubblico adulto, invece, sono The Hollow Land di William Morris e Phantastes, A Faerie Romance for Men and Women di George MacDonald, rispettivamente pubblicati, rispettivamente, nel 1856 e 1858. Alla fine dell’Ottocento, l’interesse per i romanzi fantastici è sempre maggiore, perciò a inizio Novecento nasce anche la prima rivista interamente dedicata a questo genere, Weird Tales4, che pubblica i racconti di quelli che diventeranno i nomi di spicco di questo genere, come H.P. Lovecraft.
Tuttavia, il punto di svolta si ha tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, quando J.R.R. Tolkien pubblica The Hobbit e The Lord of the Rings, codificando quello che gli studiosi avrebbero indicato come il genere high fantasy o fantasy epico. Questi romanzi riscuotono un enorme successo popolare, tanto che J.R.R. Tolkien è spesso erroneamente ritenuto il padre del fantasy in senso lato, soprattutto dai non addetti ai lavori. Indubbiamente, le sue opere hanno dato una fortissima spinta al genere, che ancora oggi è tra i più apprezzati dal pubblico.
Breve introduzione alla saga di Throne of Glass di Sarah J. Maas
Throne of Glass è una saga classificata come high fantasy e young adult. È formata da sette volumi e un prequel, pubblicati tra il 2012 e il 2018 dall’autrice statunitense Sarah J. Maas, la quale ha iniziato la stesura del primo romanzo all’età di diciassette anni.
La storia è ambientata nell’Erilea, un mondo fantastico popolato da umani e creature fantastiche, dove la magia è stata bandita da un sovrano dispotico, il Re di Adarlan (uno dei territori dell’Erilea). Ai fini della nostra indagine, è necessario riportare una breve sinossi degli snodi principali del plot, senza i quali sarebbe difficile procedere con l’analisi narratologica.
La protagonista è Celaena Sardothien, un’orfana di diciannove anni, nonché l’assassina più temuta e crudele di Adarlan. Il primo romanzo (Throne of Glass 2012) inizia in medias res, con la protagonista prigioniera nella miniera di Endovier, un campo di lavoro in cui criminali e persone comuni ritenute in qualche modo legate alla magia vengono schiavizzati e torturati. Celaena riceve una visita dal Principe Dorian, figlio del tiranno: il re ha indetto un torneo per eleggere il suo «assassino personale» e il vincitore, dopo quattro anni di servizio, sarà un cittadino libero. Nel corso del primo romanzo, assistiamo al crudele torneo mediante il quale il re sceglierà il suo campione, ma iniziano ad accadere alcuni eventi sovrannaturali che inducono Celaena a indagare sul perché ci sia magia proprio nel castello del re che l’ha bandita. Ovviamente, alla fine del romanzo, la protagonista vince il torneo e diventa l’Assassina del Re.
Nel secondo volume, Crown of Midnight (2013), Celaena inizia a lavorare per il sovrano. Tra vari intrecci, la protagonista entra in contatto con un gruppo di ribelli che vogliono spodestare il tiranno e inizia a collaborare con loro alle spalle di quest’ultimo. Dopo diverse vicissitudini, alla fine del secondo romanzo, scopriamo che Celaena non è solo l’assassina di Adarlan, ma in realtà è Aelin Galathynius, la regina scomparsa di Terrasen. Quest’ultimo era uno dei territori confinanti con Adarlan, in cui la magia prosperava e la cui famiglia regnante stessa era per metà Fae5 e portatrice di incredibili poteri.
In questa fase del plot, il Re di Adarlan è ancora all’oscuro della vera identità di Celaena, perciò la invia verso un altro regno per commettere degli omicidi. Lì, Aelin scopre che la magia non è scomparsa dappertutto, e per di più si accorge di essere lei stessa dotata di poteri. Questi ultimi erano rimasti latenti da quando, dieci anni prima, fu miracolosamente salvata dallo sterminio della sua famiglia e diventò Celaena. Veniamo a sapere che Aelin possiede un enorme potere6 e che il suo elemento totemico è il fuoco. Inoltre, anche lei, come i suoi genitori, è in parte Fae.
Proseguendo nella lettura, il plot diviene più complesso, la saga diventa corale, a tratti difficile da seguire a causa della mancanza di linearità della trama. Nel corso della narrazione, entreranno in gioco i più disparati esseri fantastici come demoni, streghe, draghi e perfino divinità7.
Il prometeico nella saga di Throne of Glass
Il mitologema prometeico in Aelin Galathynius
Dalla breve sinossi appena conclusa si può già intuire che il personaggio di Aelin presenta alcuni tratti tipici del prometeico. Nel presente saggio, ci concentreremo esclusivamente su questo personaggio, approfondendo e analizzando tutti i tratti di Aelin facenti parte del mitologema e dello psicologema prometeici.
Per mitologema, si intende il nucleo centrale del mito originale che non cambia nel tempo. Alcuni temi tipici del mitologema prometeico sono, ad esempio, il fuoco e la tortura. Lo psicologema, invece, definisce alcuni tratti della personalità dell’essere umano in quanto tale, cristallizzati nella nostra psiche. In questa ottica, possiamo individuare alcuni archetipi che compongono lo psicologema prometeico. Tra questi ricordiamo, ad esempio, il trickster.
Innanzitutto, la protagonista presenta una forte dualità fenomenologica. Quando incontriamo Celaena, ella è l’assassina più temuta di Adarlan, benché le azioni che compie siano, come avviene nel prometeico, volte a beneficiare gli altri personaggi, in particolare quelli più bisognosi di aiuto.
Allo stesso modo, quella che pensavamo essere una spietata assassina, si rivela una regina che ha vissuto una vita dura e ricca di soprusi per potere, un giorno, rivendicare il suo regno. Scopriamo che, proprio come Prometeo, anche Aelin agisce in funzione del bene dell’umanità, in questo caso del popolo di Terrasen. Proprio come l’eroe di Eschilo, in parte umano e in parte titano, anche Aelin ha in sé una dualità insita, in quanto è per metà umana e per metà Fae. Queste due personalità coesisteranno in lei fino quasi alla fine della saga, quando rinuncerà definitivamente alla sua parte umana per salvare il suo popolo.
Altri tratti prometeici che ritroviamo nel carattere di Aelin sono l’ambizione, l’impulsività e la testardaggine. Il suo scopo è sempre quello di primeggiare, non a caso è la migliore assassina di Adarlan e la vincitrice del torneo. Questo tratto caratteriale del personaggio emerge, ad esempio, nell’episodio di Empire of Storms (2016: 200-319) in cui Aelin si reca alla baia del Teschio, isola di pirati da cui era stata bandita dopo aver causato un enorme danno economico al Capitano Rolfe (The Assassin’s Blade 2014). In questa occasione, Aelin dimostra la sua ambizione e testardaggine nel voler convincere un antico nemico a combattere per la sua causa. Inoltre, in questa occasione, Aelin induce dei demoni ad attaccare l’isola per garantirsi il favore di Rolfe, una mossa calcolata ma allo stesso tempo impulsiva, dato che non può prevedere l’esito della battaglia.
Proprio come Prometeo, anche Aelin infrange le regole: è una ribelle che si oppone al tiranno. Questo tratto diviene manifesto nelle interazioni tra la protagonista e i personaggi che detengono più potere di lei, in quanto demoni (come, ad esempio, Erawan o Maeve) o divinità (come Deanna e Mala).
Quando entreranno in gioco queste ultime, la futura regina di Terrasen si eleverà al loro livello, riuscendo perfino nell’impresa, appunto titanica, di superarle in potenza attraverso l’inganno, quindi comportandosi in linea con il mitologema. Riportiamo qui di seguito il passaggio in cui Aelin si confronta con le divinità e le sconfigge:
That power flowed and flowed into Aelin. Her lips curved upward.
It was not the end. And she was not finished.
But they were.
“To a better world,” Mala said, and walked through the doorway into her own.
A better world.
A world with no gods. No masters of fate.
A world of freedom.
Aelin approached the archway to the gods’ realm.
[…] Aelin’s smile turned into a grin. Wicked and raging.
It did not falter as she found the world she sought. As she dipped into that eternal, terrible power.
She had been a slave and a pawn once before. She would never be so again.
Not for them. Never for them.
The gods began shouting, running toward her, as Aelin ripped open a hole in their sky. Right into a world she had seen only once. Had accidentally opened a portal into one night in a stone castle. Distant, baying howls cracked from the bleak gray expanse. A portal into a hell-realm. A door now thrown open.
Aelin was still smiling when she closed the archway into the gods’ world. And left them to it, the sounds of their outraged, frightened screams ringing out (Maas 2018: 738-739).
In questo passo risultano molto evidenti alcuni tratti prometeici presenti nella protagonista, come il motivo della prigionia, che analizzeremo più a fondo nei paragrafi successivi. Quando fa riferimento a «A world with no gods. No masters of fate. A world of freedom» (Maas 2018: 738), l’analogia con il Prometheus Unbound di P.B. Shelley è pressoché inevitabile, per via dell’archetipo attivo in entrambe le opere: ci troviamo di fronte a una protagonista fortemente prometeica e proiettata verso il polo che, per usare la terminologia teologica shelleyniana, corrisponde a “Liberty” e si oppone a “Tyranny” (Cameron 1942). Allo stesso modo, poco più avanti affiorano dei tratti del personaggio più prossimi al Frankenstein di Mary Shelley: «Aelin’s smile turned into a grin. Wicked and raging» (Maas 2018: 739).Da questo passaggio, infatti, emerge un lato oscuro della personalità di Aelin che decisamente non appartiene all’eroico Prometeo di P.B. Shelley, ma risulta invece più affine al tormentato e faustiano Victor.
Un altro punto in comune con il mitologema lo troviamo nel fatto che Aelin è la benefattrice dell’umanità, e anzi, è lei stessa a proclamarsi tale. Come abbiamo detto in precedenza, l’intero percorso di vita e crescita dopo lo sterminio della famiglia è volto a un unico scopo: quello di salvare il suo popolo, e Aelin è disposta a tutto pur di raggiungere tale obiettivo, anche a sacrificare la sua stessa vita. Infatti, nell’ultimo romanzo della saga veniamo a sapere che la regina di Terrasen ha escogitato un piano che la sua cerchia più fidata dovrà mettere in atto qualora lei venisse a mancare. Da ciò si deduce anche come Aelin sia un personaggio fortemente proiettato verso il futuro. Il suo sguardo è cataforico, ha sempre un piano pronto, un asso nella manica, e spesso tiene la sua corte all’oscuro di tutto riuscendo a prevedere le loro mosse in base ai suoi stessi complotti. Vale per tutte, a questo proposito, un’emblematica affermazione della protagonista, tratta dal quarto romanzo della saga, Queen of Shadows: «It helps no one and nothing to look back. We can only go on» (Maas 2018: 739). Si tratta di un’affermazione manifestamente in linea con il mitologema e lo psicologema prometeici, tanto che potrebbe essere pronunciata dallo stesso Prometeo in persona.
Un altro punto in comune con il mitologema è il motivo della prigionia e dell’incatenamento, un motivo presente nella narrazione prometeica sin dalle origini classiche (Esiodo ed Eschilo). Durante il corso della storia, infatti, più volte la protagonista viene incatenata e torturata. All’inizio della saga, quando la conosciamo, si trova nelle miniere di Endovier, dove i prigionieri sono costretti a lavorare incatenati alla roccia e vengono abitualmente malmenati. In particolare, Aelin ha sulla schiena le cicatrici delle ripetute frustate che furono la sua punizione quando, in passato, provò a fuggire. Nel corso della saga e del prequel (The Assassin’s Blade 2014) scopriamo che, dopo il massacro della sua famiglia da parte del Re di Adarlan, la protagonista viene salvata da Arobynn Hamel, il Re degli Assassini. Quest’ultimo la cresce, per poi addestrarla a diventare la più temuta assassina del regno, utilizzando metodi estremamente violenti sia sul piano fisico che psicologico. Ad esempio, durante il suo addestramento, Arobynn si accorge che Celaena non è abile a tirare di spada con la sinistra come lo è con la destra, perciò le intima di rompersi il braccio. In caso contrario, la minaccia di farlo egli stesso. La giovane protagonista opta per la prima opzione, preferendo farlo da sola, ed è così costretta a usare solo la mano sinistra fino alla completa guarigione della destra. Più avanti nella storia, Aelin verrà di nuovo catturata dal nemico, in questo caso la Regina Maeve, e incatenata a una bara di ferro. Qui, per oltre un mese, verrà torturata ogni giorno e arsa viva, ma non abbastanza da essere uccisa.
Un ulteriore tratto fenomenologico che si aggiunge agli altri già menzionati, e riconducibile al prometeico, è l’ibridismo ontologico della protagonista, a metà tra il divino e l’umano. Nel caso specifico di Aelin, la ragazza è una dea che si priva della sua condizione divina per l’uomo. Fino a ora, infatti, abbiamo volutamente tralasciato di menzionare che la protagonista, nonostante sia una mezza-Fae, possiede anche dei poteri soprannaturali ben superiori agli altri Fae, in quanto discende direttamente dalla dea del fuoco, Mala. Quasi alla fine della saga, Aelin rinuncerà, appunto, a questi stessi poteri, per ottenere l’imprigionamento delle divinità in un regno demoniaco e ucciderle, di fatto sacrificandosi per salvare l’umanità dalla tirannia di queste ultime. Il buon esito del sacrificio di Aelin sarà suggellato dalla stessa protagonista, la quale, anche qui titanicamente, affermerà: «Only an ember remains» (Maas 2018: 745).
Aelin e la simbologia del fuoco
Come abbiamo già menzionato, Aelin possiede la magia del fuoco, un potere immenso, che lei stessa definisce «endless well of power» (Maas 2018: 795). Nel corso dei romanzi le vengono dati numerosi appellativi dai suoi compagni e dai nemici, molti dei quali hanno a che fare proprio con il fuoco. Ho deciso di riportare qui di seguito quelli che ritengo più significativi ai fini della nostra indagine: “Fire Queen”, “Heir of Fire”, “Fireheart”, “Aelin of the Wildfire”, “Aelin Fire-Bringer”, “Aelin Light-Bringer”, “Queen of Flame and Shadow”, “The Gods Killer”. Tutti questi appellativi sono decisamente prometeici; in particolare, mi vorrei soffermare su “Fire-bringer” il quale viene spesso utilizzato anche per descrivere lo stesso Prometeo nella tradizione classica. Aelin, proprio come quest’ultimo, possiede il fuoco degli dèi (della Dea Mala, sua antenata) e lo dona all’uomo in senso metaforico, in quanto mette il suo potere a servizio del suo popolo, per donargli la salvezza. In questo contesto, il fuoco è anche sinonimo di rivoluzione, in quanto è proprio la Regina di Fuoco a guidare i ribelli contro la tirannia. Nel corso dell’ultimo romanzo, Aelin guadagnerà anche il titolo di “Gods Killer”, dato che, come anticipato, riuscirà nell’impresa prometeica di superare in astuzia le divinità e ucciderle (Maas 2018: 738-739).
Il simbolismo del fuoco è presente ampiamente in tutti i romanzi. Il rapporto che Aelin ha con questo elemento è ambivalente. Fin da piccola, ha difficoltà a gestire il suo immenso potere e assistiamo a diverse scene in cui ne perde il controllo, facendo del male a sé stessa e alle persone che la circondano. Il fuoco di Aelin è un fuoco prometeico: è benevolo e rivoluzionario, ma allo stesso tempo distruttore e mortifero. L’astenersi da esercitare questo potere, rende la protagonista debole; l’uso costante della magia ignea, invece, la rende radiosa e sana, ma, se portato all’eccesso, può avere conseguenze catastrofiche. Più volte, nel corso della storia, Aelin attinge talmente tanto al suo potere da ustionarsi dall’interno, giungendo spesso prossima alla morte. Vorrei riportare qui di seguito un passaggio tratto da Heir of Fire in cui si narra la prima volta in cui, dopo aver riacquisito i suoi poteri, Celaena ne perde il controllo:
Agony lashed down her spine, so hard she fell to the grass. Light flared – not from her or Ro-wan, but from the fires surging. People yelled, the music faltered. The grass hissed beneath her hands, smoking. […] She tried to groan, to move, but she had no air. No air for that inner fire. Blackness swept in.
Oblivion.
Then she was gasping, arcing off the grass, the fires now crackling naturally and Rowan hover-ing over her. “Breathe. Breathe.”
Through he’d snapped her tethers to the fire, she was still burning. Not burning on the outside, where even the grass had stopped smoldering. She was burning up from within. Each breath sent fire down her lungs, her veins. She could not speak or move. She had shoved herself over some boundary – hadn’t heard the warning signs to turn back – and she was burning alive be-neath her skin (Maas 2014).
Il fuoco viene anche usato dalla stessa Regina di Terrasen con valore simbolico. Questo è il suo marchio e lo usa anche in maniera spettacolarizzata e politica, per impressionare sudditi e nemici. È significativo, a questo proposito, l’episodio della battaglia finale in cui Aelin, allo stremo delle forze e con solo un tizzone di magia rimasto, si fa comparire una corona di fuoco sulla testa per intimorire i suoi nemici e prendere tempo (Maas 2018: 816-817).
Il complesso di Prometeo
Come abbiamo visto fino a ora, Aelin è un personaggio massicciamente intriso di prometeico, e questo emerge anche nel rapporto con la figura paterna di Arobynn Hamel. Arobynn viene chiamato “the king of the Assassins” di Rifthold (capitale di Adarlan), è un ricco signore del crimine, capo della Gilda degli Assassini di cui Celaena fa parte. È lui a trovare la piccola Aelin in fin di vita sulla riva di un fiume dopo lo sterminio della sua famiglia per mano del Re di Adarlan, e a crescerla e addestrarla fino a farla diventare l’assassina più temuta del regno.
Riportiamo di seguito una citazione tratta da Queen of Shadows: in queste poche righe, l’autrice ci illustra i tratti principali del personaggio di Arobynn Hamell visto dagli occhi della protagonista: «The man responsible for that initial brutal training—the man who had been savior and tormentor, but never declared himself father or brother or lover—was now steps away» (Maas 2015).
Il rapporto tra Aelin e Arobynn è decisamente ambiguo: quest’ultimo è duro e violento, sia sul piano fisico che psicologico; allo stesso tempo, tuttavia, in alcuni momenti si dimostra affettuoso e benevolo nei confronti della sua allieva preferita, alimentando così dissapori e invidia da parte degli altri assassini. Dal fare discorsivo di Aelin capiamo che ella lo odia profondamente; tuttavia, è cosciente del fatto che senza di lui sarebbe morta dieci anni prima, nella notte in cui il Re di Adarlan sterminò la sua famiglia. Inoltre, grazie ad Arobynn, Aelin ha appreso tecniche di combattimento che le saranno fondamentali per conseguire il suo scopo ultimo, ovvero salvare il mondo dalla tirannia.
Anche lo stesso personaggio di Arobynn è ambiguo. Fin dall’inizio e fino alla sua morte, non capiamo se nutra dei reali sentimenti d’affetto nei confronti di Aelin, o addirittura se ne sia innamorato. Sarebbe interessante analizzare in maniera più approfondita anche questo personaggio, che indubbiamente presenta alcuni tratti tipici del trickster, un archetipo implicato in quello del prometeico, primi tra tutti la propensione all’inganno e l’ambiguità8.
Nel corso della narrazione emerge anche un sentimento di sfida da parte di Aelin nei confronti del suo tutore: la protagonista vuole essere migliore di lui, sia dal punto di vista dell’abilità fisica, sia dal punto di vista intellettuale, e ci riuscirà: prima diventando l’Assassina più famosa di Adarlan e poi battendolo al suo stesso gioco. Infatti, dopo l’ennesimo tradimento, Aelin escogiterà un piano per uccidere Arobynn superandolo in astuzia e, con l’inganno, erediterà tutta la sua fortuna. Anche questo tratto è in linea con il prometeico. Come ha affermato infatti Bachelard (1964: 7-12), la competizione con il padre, quindi con una figura autorevole e autoritaria (rappresentata da Giove nel mito classico), è una caratteristica comportamentale di Prometeo. Questo mito è infatti un mito dell’intelletto, afferma lo studioso, che travalica i confini dell’edipico, in quanto privo del presupposto sessuale di competizione per l’appropriazione del corpo materno. A riprova di questo, è importante fare presente che, nonostante in alcuni punti della storia sembri emergere una sorta di interesse sessuale di Arobynn nei confronti di Aelin, non ne abbiamo mai la conferma e anzi, abbiamo l’impressione che questo faccia piuttosto parte di una strategia che egli adotta per mettere in atto i suoi piani ingannevoli. Inoltre, da parte della protagonista, non esiste alcun interesse di questo tipo nei confronti del Re degli Assassini, che viene piuttosto rappresentato come la distorsione di una figura paterna in senso tirannico e stressogeno.
Conclusioni
Da questa breve analisi della saga di Throne of Glass, è emerso che gli elementi riconducibili al prometeico sono numerosi, soprattutto nel personaggio di Celaena Sardothien/Aelin Galathynius, sul quale ci siamo concentrati.
Indubbiamente, elementi tipici del mitologema e dello psicologema prometeici sono presenti anche nell’intero sistema dei personaggi. L’archetipo del trickster è individuabile in numerose figure, inclusa la stessa Aelin, e si manifesta forse nella sua forma più pura con il Piccolo Popolo. Queste creature fatate, note per essere dispettose nei confronti dei viaggiatori, si rivelano alla protagonista in momenti decisivi, fornendole aiuto proprio nel momento del bisogno, quindi integrando, sul piano attanziale, l’oppositore e l’aiutante. O ancora, sia l’archetipo del trickster che un altro archetipo, quello dell’Ombra, sono presenti negli antagonisti, tutti appartenenti a un reame demoniaco e quindi essi stessi demoni: essi sono rappresentati entro una dimensione negativa e oscura; allo stesso tempo, proprio come il trickster, si manifestano sotto mentite spoglie, essendo spesso celati dietro a una maschera, umana o Fae, per occultare la loro vera identità.
È inoltre di grande interesse critico il fatto che la protagonista prometeica sia una donna. La motivazione alla base di questa scelta da parte dell’autrice è riconducibile, con alta probabilità, al periodo storico in cui ci troviamo, in cui la parità di genere è ben lungi dall’essere stabile, culturalmente e socialmente. Questo fatto si riflette sulla letteratura, dove spesso le opere propongono appunto, per compensazione, protagoniste femminili forti e indipendenti. A partire dagli anni Duemila, infatti, si è sviluppato un filone di romanzi fantasy e young adult, non a caso ad opera di autrici, le cui protagoniste sono giovani donne che, affrontando varie avversità, intraprendono un percorso di Bildung, che a sua volta le condurrà alla realizzazione personale. Ricordiamo, ad esempio, Shadowhunters (2007) di Cassandra Clare, Hunger Games (2008) di Suzanne Collins, il Grishaverse (2012) di Leigh Bardugo. Questa tendenza non si manifesta solo negli Stati Uniti, ma è diffusa anche in Europa, dove numerose autrici raccontano le avventure fantastiche di personaggi femminili (donne e ragazze), come Licia Troisi in Le Cronache del Mondo Emerso (2004), Rubinrot (2009)dell’autrice tedesca Kerstin Gier e La Passe-Miroir (2013)della scrittrice francese Christelle Dabos.
In Sarah J. Maas, come abbiamo visto, i richiami al prometeico sono numerosi, ma è possibile che questi siano presenti anche negli altri romanzi young adult, come sintomo di una tendenza direzionata verso una nuova forma di prometeico contemporaneo femminilizzato che, epurato dalle caratteristiche tipiche dei personaggi maschili young adult, apra una nuova dimensione di questo archetipo in letteratura. Per dare una risposta a questa domanda sarebbe utile e doveroso proseguire con questa indagine, approfondendo lo studio degli altri personaggi della saga e analizzando le descrizioni dei paesaggi, ricche e fondamentali nel genere fantasy, ma tutti fortemente legati al prometeico. Allo stesso modo, sarebbe interessante allargare la ricerca ad altre opere dello stesso genere scritte negli stessi anni, per verificare la presenza del prometeico e confermare questa ipotesi interpretativa così affascinante e, auspicabilmente, criticamente feconda.
Bibliografia / Sitografia
Testi primari
Maas, Sarah J. (2012), Throne of Glass, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2013), Crown of Midnight, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2014), The Assassin’s Blade, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2014), Heir of Fire, Bloomsbury, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2015), Queen of Shadows, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2016), Empire of Storms, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2017), Tower of Dawn, Londra e New York, Bloomsbury.
‒ (2018), Kingdom of Ash, Londra e New York, Bloomsbury.
Shelley, Mary (1996), Frankenstein, dir. Hunter, Londra e New York, Norton.
Shelley, Percy Bysshe (2003), «Prometheus Unbound», in: Leader Z. e O’Neill M. (dir.), Shelley. The Major Works, Oxford, Oxford UP.
Testi secondari
Bachelard, Gaston (1964), Psychoanalysis of Fire, Londra, Routledge e Kegan Paul.
Beccone, Simona (2023), Promethean Mnemotechnics: Memory, Forgetting, Episodic Future Thought and Nonviolent Revolution, «Caietele Echinox», 44, p. 79-96.
Callahan, Tim (1991) Devil, Trickster and Fool, «Mythlore», 4, 17, p. 29-34, 36.
Cameron, Kenneth L. (1942), The Social Philosophy of Shelley, «The Sewanee Review», 50, 4, p. 457-466.
Egoff, Sheila Agnes (1988), Worlds Within: Children’s Fantasy from the Middle Ages to Today, Chicago, American Library Association.
Gates, Pamela S.; Steffel, Susan B.; Molson, Francis J. (2003), Fantasy Literature for Children and Young Adults, Lanham, Md, Scarecrow Press.
Hillman, James (2014), Figure del mito, Milano, Adelphi.
Maurone, Joseph (2002), The Trickster Icon and Objectivism, «The Journal of Ayn Rand Studies», 3, 2.
Ngide, Ewane Ngide (2020), «Ye Are Many, They Are Few»: Nonviolence as Response to Oppression and Repression in the Poetry of Percy Bysshe Shelley, Open Journal of Social Sciences, 8, p. 530-554.
Nikolajeva, Maria (2003), Fairy Tales and Fantasy: From Archaic to Postmodern, «Marvels and Tales» 17, 1, p. 138-156.
Punter, David (2016), «Literature», in Smith, Andrew (dir.), The Cambridge Companion to Frankenstein, Cambridge University Press.
Weiner, Jesse; Eldon, Stevens Benjamin; Rogers, Brett M. (2018), Frankenstein and its Classics. The Modern Prometheus from Antiquity to Science Fiction, Londra e New York, Bloomsbury Academic. Chapter 12 (“The Postmodern Prometheus and Posthuman Reproductions in Science Fiction”), p. 206-227.
Sitografia
Pagan, Amanda (2020), «Hallmarks of Fantasy: A Brief History of the Genre»,In: New York Public Library, consultato il 09/07/2024, URL: <https://www.nypl.org/blog/2020/05/18/hallmarks-fantasy-brief-history-fantasy>.
Note
- Ad esempio, ricordiamo la trilogia di The Lord of The Rings (Tolkien, 1954), o ancora The Chronicles of Narnia (Lewis, 1950).
- Di nuovo, in The Lord of The Rings (Tolkien, 1954) troviamo, ad esempio, gli elfi e i nani, di origine popolare norrena. Anche nella saga di Harry Potter (Rowling, 1997), l’autrice ci propone creature magiche come troll, unicorni, pixies, etc…
- Ricordiamo, ad esempio, La Chanson de Roland (Turoldo, XI sec.), l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (1516), El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (Cervantes Saavedra, 1605).
- Weird Tales è una rivista americana di racconti horror e fantastici, pubblicata per la prima volta nel 1923 e attiva ancora oggi. Il sito ufficiale è consultabile a questo link: https://www.weirdtales.com/
- (Definizione OED 1.† old who: the right man. Obsolete. 2. A person, indefinitely or abstractly; a ‘someone’. 3.With the. (The answer to) the question ‘who?’) In questo contesto i Fae sono creature magiche con sembianze antropomorfe, simili agli elfi. Sono immortali, bellissimi, dotati di poteri magici più o meno potenti, di solito legati agli elementi naturali. I Faeriesi, invece, sono creature fatate con sembianze più bestiali. Nella traduzione italiana, i due termini sono stati resi rispettivamente con Fae Maggiori e Fae Minori, Quando (in italiano) parliamo di Fae in generale ci si rivolge ai primi.
- Aelin ha la capacità di evocare e plasmare il fuoco a suo piacimento.
- Demoni, come Erawan, Maeve, Mantys e Orcus. Streghe, come Manon Blackbeak e le sue Tredici con i loro draghi. Divinità come Mala, la dea del fuoco.
- Il collegamento tra il prometeico e il trickster è stato ampiamente studiato da Maurone nel suo saggio The Trickster Icon and Objectivism del 2002.