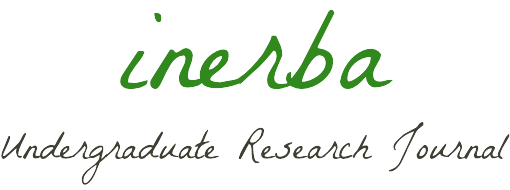Durante le innumerevoli interviste rilasciate in seguito alla pubblicazione dei volumi della trilogia storica che va sotto il nome di As Areias do Imperador, Mia Couto1 – una delle voci mozambicane contemporanee indubbiamente più conosciute nel panorama letterario mondiale – ha ripetutamente insistito sulla necessità di liberare il suo Paese da quella visione unica del passato a cui il Mozambico sembra essere ancora oggi assoggettato – con tutte le conseguenze del caso.
Lo statuto di ex-colonia che il Mozambico ancora riveste, infatti, porta inevitabilmente con sé una serie di congetture sul passato della Nazione che si sedimentano alla base dei discorsi ufficiali prodotti dalla storiografia. In altri termini, l’ideologia che ha dominato il pensiero occidentale durante il processo di colonizzazione ha finito per condizionare la percezione del passato di questa (e delle altre) ex-colonie, descrivendolo da una prospettiva unilaterale e tutt’altro che oggettiva.
Proprio quella oggettività che si suppone caratterizzi la Storia, per via della sua (presunta) scientificità, risulta essere, piuttosto, relativa, considerato il carattere facilmente “controllabile” – o, se vogliamo, falsificabile – per il quale, al contrario, la disciplina si distinguerebbe: come sottolineato da Hayden White nella raccolta di saggi Forme di Storia (White 2020), infatti, la Storia andrebbe considerata come un «artefatto letterario»2 che, proprio perché risultato di un processo trasformativo intenzionale3, finisce, senza grandi sorprese, per essere modellata secondo principi ideologici e politici che ne determinano la “forma” che ci è data, poi, a conoscere.
In questo modo, non sorprende che, nel corso del tempo, siano stati restituiti discorsi storici che appaiono amnestici – anche perché ormai anacronistici4 –, le cui lacune, oggi, esigono a gran voce di essere riempite, specialmente in un contesto come quello dell’Africa post-coloniale. Rivalutare i precetti che si ritrovano alla base del discorso storico ufficiale è, infatti, necessario per l’affermazione di un’identità africana autonoma, fino a questo momento costruita a partire da quelle dicotomie oppositive Europa/Africa, colonizzatore/colonizzato, bianco/nero e tutte le metafore relative al caso. E lo ribadisce lo stesso Mia Couto durante una conferenza per l’Associazione Mozambicana degli Economisti (2003), dal titolo A fronteira da cultura, quando afferma:
Confrontados com as nossas mais fundas fragilidades, cabe-nos criar um novo olhar, inventar outras falas, ensaiar outras escritas. Vamos ficando, cada vez mais, a sós com a nossa própria responsabilidade histórica de criar uma outra História. Nós não podemos mendigar ao mundo uma outra imagem. Não podemos insistir numa atitude apelativa. A nossa única saída é continuar o difícil e longo caminho de conquistar um lugar digno para nos e para a nossa pátria. E esse lugar só pode resultar da nossa própria criação (Couto 2005).
È chiaro che il suo tentativo di lanciare le basi per la genesi di nuovi presupposti storici a partire dai quali ripensare la sua Nazione si concretizza attraverso la sua produzione letteraria, la quale si afferma, di conseguenza, come luogo di libertà e possibilità. Difatti, in un contesto come quello dell’Africa postcoloniale, la Letteratura finisce inevitabilmente per acquisire un carattere rappresentativo che supera la mera esperienza estetica e finzionale: le letterature africane (nel nostro caso, quelle di espressione portoghese), infatti, sono fortemente vincolate alle condizioni storiche nelle quali sono sorte e si sono sviluppate, attestandosi, in primis, come risposta a quell’esigenza da parte del popolo colonizzato di emergere con un’identità (anche culturale) autonoma rispetto a quella del popolo colonizzatore – identità sulla quale costruire, poi, l’unità nazionale.
Questo è il punto di partenza da cui Mia Couto matura l’elaborazione della nuova versione, proposta nella sua trilogia, di un momento storico che è entrato a far parte della mitologia nazionalista sia portoghese che mozambicana: la sconfitta del grande imperatore di Gaza, Ngungunyane (o Gungunhana come è conosciuto nei libri di storia portoghesi). Imperatore del popolo dei nguni – proveniente dall’Africa del Sud e appartenente alla famiglia degli Zulu –, Gungunhana esercita la sua autorità per circa undici anni (1884-1895), portando avanti una politica alquanto aggressiva, basata sui principi di potere assoluto e dispotismo che lo hanno condotto, poi, a governare sulla cosiddetta Provincia di Gaza, ultimo impero africano, in Mozambico, all’epoca non ancora sotto la dominazione diretta dei colonizzatori.
Effettivamente, sul fronte portoghese, la disfatta del “Leone di Gaza” costituisce l’eccellente pretesto per il Portogallo di riscattare il titolo di potenza europea, in un momento storico, quale la fine del XIX secolo, che vede la Nazione in uno stato di assopimento politico, economico e culturale; su quello mozambicano, invece, lo stesso avvenimento viene presentato, anni dopo, come prova della resistenza e resilienza del popolo mozambicano, in quel periodo di costruzione e consolidazione della Nazione post-indipendente. Le due narrazioni, tuttavia, non sembrano rispondere alle esigenze identitarie dell’uomo e della donna mozambicani contemporanei che, in esse, non vi trovano rappresentazione: nel primo caso, è abbastanza intuitivo come il discorso non tenga conto della “prospettiva africana” della Storia, ma tenda a spettacolarizzare – fino a far acquisire alla narrazione storica i toni di una epopea – la vittoria del colonizzatore che riesce a dimostrare, in questo modo, di meritare il titolo di “Prospero”, condizione che era stata messa in dubbio, specialmente in seguito alla grande umiliazione determinata dall’Ultimatum del 1890 da parte dell’Inghilterra5. Nel secondo, invece, si passa all’estremo opposto, ovvero, si cade in un eccesso di nazionalismo volto a “mozambicanizzare” la Storia. Nonostante il proposito apparentemente nobile di voler restituire al popolo mozambicano la voce a lungo taciuta dal colonizzatore, il discorso storico che ne scaturisce risulta, ancora una volta, influenzato dalla politica; i valori nazionalisti che caratterizzano il progetto politico della FRELIMO (Frente de Libertação de Moçambique) – il partito politico che salì al potere in seguito all’ottenimento dell’indipendenza (1975) –, infatti, si insinuano nelle maglie della Storia, determinando l’orientamento della narrazione stessa.
In questo contesto, che appare quindi lacunoso dal punto di vista rappresentativo, si inseriscono le narrative di Mia Couto: la trilogia conduce un processo di revisionismo che ha come obiettivo principale quello di liberare il discorso storico dalle dinamiche di potere che lo hanno sempre controllato, restituendo, così, una versione della Storia che non ha alcuna pretesa di esclusività, ma, al contrario, beneficia del carattere eclettico della realtà6, per proporre un nuovo punto di vista da cui osservare il passato. La Storia che emerge cerca di non essere in alcun modo “elitista” (Said 2002), cioè non si limita a rappresentare un piccolo gruppo ristretto di persone (quelle al potere), e condanna il colonialismo (esogeno o endogeno che sia), rifiutando ogni tipo ideologia che possa influenzarne la narrazione. Quella che Couto vuole rappresentare è, invece, una Storia che possa consentire a uomini e donne “semplici” – che ora si rivalgono del loro ruolo di protagonisti della Storia – di riappropriarsi della loro memoria, senza rinnegare il passato vissuto, ma interiorizzandolo in maniera critica, in modo da trovare il loro spazio nel presente, spazio in cui affermare la propria identità. In qualità di scrittore, Mia Couto riesce, in questo modo, a creare i presupposti di «um pensamento mais nosso para que a avaliação do nosso lugar e do nosso tempo deixe de ser feita a partir de categorias» (Couto 2005) create da altri.
È questa la ragione per cui la Storia, mediata dalla Letteratura, passa ad essere rappresentata nel suo lato più umano, ovvero come una Storia “fatta dagli uomini”. Non a caso, la narrazione muove a partire da una dimensione individuale che la storiografia non ha mai contemplato e affianca alle fonti documentali ufficiali – di cui il nostro autore si serve per garantire verosimiglianza alla sua narrazione – racconti privati, conservati nella memoria di chi ha vissuto la Storia in prima persona, ma non ha mai avuto una voce per raccontarla.
Si prenda ad esempio il volume inaugurale della trilogia, Mulheres de Cinza – o Donne di Cenere come propongo nella mia traduzione, che questo breve testo ha l’obiettivo di introdurre. Ritroviamo, all’interno del romanzo, motivi e strutture formali (che riverberano nei romanzi successivi) che sembrano offrire in germe un esempio delle nuove forme che il romanzo storico contemporaneo sta assumendo in un contesto spaziale “difficile” come l’Africa che cerca di decolonizzarsi, asserendo come necessario l’ampliamento della riflessione critica occidentale, troppo spesso assunta come unico paradigma.
Nel romanzo, vediamo l’alternarsi di voci (e forme) narrative che, in un discorso polifonico (Segre 1991), cercano di restituire una narrazione globale multi-prospettica che ci dà prova concreta della plasticità della realtà. E così ascoltiamo la giovane mozambicana Imani, della famiglia dei Vatxhope – unica tribù ad aver giurato fedeltà alla Corona portoghese – mentre ci racconta la sua storia attraverso le pagine di quello che sembra essere un diario, il quale, a sua volta, si alterna al racconto in forma epistolare di un sergente portoghese degradato, Germano de Melo, relegato nelle calde terre africane con l’obiettivo di svolgere una falsa missione governativa. Le due narrazioni si innestano l’una nell’altra, presentando al lettore due visioni possibili di un’unica realtà, e costruendosi entrambe in un rapporto di intertestualità con la “Storia già conosciuta”7: ed ecco che le imprese del grande hosi (“imperatore” in lingua Tsonga) di Gaza, Gungunhana che si fa strada verso il Sud del Mozambico, passano in secondo piano, o meglio, diventano lo sfondo di una storia d’amore (definita, tra l’altro, molto improbabile dallo stesso Mia Couto) tra due personaggi che, dalla loro posizione di subalternità (Said 2002), ci ricordano come ci siano altre storie all’interno della Storia.
Lasciando parlare il testo in questione, presento allora qualche pagina della mia proposta di traduzione, risultato di un insieme di scelte orientate principalmente a non tradire le particolarità del testo di partenza, considerando la traduzione – in qualche modo coinvolta nel processo di rivalutazione delle dinamiche tra potere e alterità – come momento di arricchimento e celebrazione delle particolarità culturali che il testo contiene. Tra queste, segnalo in particolar modo lo stile inconfondibile dell’autore (molto spesso definito “prosa poetica”) che risulta essere rappresentazione di quel processo di testualizzazione dell’oralità che irrimediabilmente si verifica nella letteratura africana contemporanea: a tal proposito, oltre all’alternarsi di forme narrative quali la estória8 che, in qualche modo, rimanda ai racconti dei griot africani, è possibile inciampare in numerose formule orali come proverbi, frasi sentenziose o apoftegmatiche che rimettono alla saggezza ancestrale di cui la stessa Imani si fa ricettacolo. In questo modo, il processo di lettura diventa un processo di ascolto a cui il lettore partecipa come attore attivo della narrazione stessa.
LIBRO UNO – DONNE DI CENERE
La strada è una spada. La sua lama lacera il corpo della terra. Tra non molto la nostra nazione sarà un groviglio di cicatrici, una mappa fatta di così tanti colpi che saremo più orgogliosi delle ferite che del corpo ancora intatto che riusciremo a salvare.
CAPITOLO 1 – Stelle disseppellite
La mamma dice: la vita è come una corda:
bisogna intrecciarla finché non distinguiamo più i fili dalle dita.
Tutte le mattine, si levavano sette soli sulla pianura di Inharrime. A quei tempi, il firmamento era molto più grande e riusciva a contenere tutti gli astri, quelli vivi e quelli ormai morti. Nuda come aveva dormito, nostra madre usciva di casa con un setaccio in mano. Avrebbe scelto il migliore dei soli. Con il setaccio raccoglieva le sei stelle rimanenti e le portava al villaggio. Le seppelliva vicino al termitaio, dietro casa nostra. Quello era il nostro cimitero di creature celesti. Un giorno, se ne avessimo avuto bisogno, avremmo disseppellito stelle. Grazie a questo patrimonio, non eravamo poveri. Così diceva nostra madre Chikazi Makwakwa, o semplicemente la mame, nella nostra lingua materna.
Chiunque ci facesse visita avrebbe saputo l’altra ragione di questa convinzione. Era nei termitai che si seppellivano le placente dei neonati. Sulla collinetta era cresciuta una mafura, e sul suo tronco annodavamo delle pezze bianche. Lì parlavamo con i nostri defunti.
Il termitaio era, però, il contrario di un cimitero. Custode delle piogge, lì viveva la nostra eternità.
Una volta, dopo aver passato il mattino al setaccio, uno stivale calpestò il Sole, quello che la mamma aveva scelto. Era uno stivale militare, uguale a quelli che usavano i portoghesi. Stavolta, però, a portarlo ai piedi era un soldato nguni. Il soldato veniva per ordine dell’imperatore Ngungunyane.
Gli imperatori sono affamati di terra e i loro soldati sono bocche che divorano nazioni. Quello stivale ruppe il Sole in mille pezzi. E il giorno si fece buio. Così come i giorni a venire. I sette soli morirono sotto gli stivali dei militari. La nostra terra veniva sbranata. Senza stelle ad alimentare i nostri sogni, imparavamo a essere poveri. E ci separavamo dall’eternità. Consapevoli che l’eternità è solo un altro nome della Vita.
*
Mi chiamo Imani. Questo nome che mi hanno dato non è un nome. Nella mia lingua materna «Imani» vuol dire «chi è?». Si bussa a una porta e, dall’altro lato, qualcuno si informa:
― Imani?
Ed è quella indagine che mi hanno dato come identità. Come se fossi un’ombra senza corpo, l’eterna attesa di una risposta.
A Nkokolani, la nostra terra, si dice che il nome del neonato provenga da un sussurro che si sente prima di nascere. Nella pancia della madre, non si genera solo un altro corpo. Si fabbrica l’anima, il moya. Ancora nel buio del ventre, quel moya va a delinearsi a partire dalle voci di chi è ormai morto. Uno di quegli antenati chiede al nuovo essere di adottare il suo nome. Nel mio caso, mi è stato bisbigliato il nome di Layeluane, la mia nonna paterna.
Come vuole la tradizione, nostro padre si rivolse a un indovino. Voleva sapere se avessimo realizzato la genuina volontà di quello spirito. E successe l’inaspettato: il veggente non confermò la legittimità del battesimo. Ci fu bisogno di consultare un secondo indovino che, simpaticamente e dietro pagamento di una sterlina, gli assicurò che era tutto in ordine. Ciononostante, siccome nei primi mesi di vita piangevo in continuazione, la famiglia giunse alla conclusione che mi avevano dato il nome sbagliato. Si interpellò la zia Rosi, l’indovina di famiglia. Dopo aver lanciato gli ossicini magici, nostra zia assicurò: «A questa ragazza non è il nome a essere sbagliato; è la sua vita a dover essere chiarita».
Papà desistette dalle sue incombenze. Che fosse la mamma a occuparsi di me. E fu quello che fece, battezzandomi «Cinza», come la cenere. Nessuno capì come mai quel nome che, in realtà, durò poco. Dopo che le mie sorelle morirono, portate via dalle inondazioni, passai a essere chiamata «la Viva». Non era un nome. Era un modo per non dire che le altre figlie erano morte.
Il resto della storia è ancora più nebuloso. A un certo punto, il mio vecchio ci ripensò e, alla fine, si impose. Avrei avuto per nome, nessun nome: Imani. L’ordine del mondo, finalmente, si era ristabilito. Assegnare un nome è un atto di potere, la prima e più definitiva occupazione di un territorio altrui. Mio padre, che si lamentava tanto dell’impero degli altri, assunse lo statuto di un piccolo imperatore.
Non so perché mi dilungo tanto nelle spiegazioni. Perché non sono nata per essere una persona. Sono una razza, sono una tribù, sono un sesso, sono tutto quello che mi impedisce di essere me stessa. Sono nera, faccio parte dei Vatxhopi, una piccola tribù sulla costa del Mozambico. La mia gente ha avuto il coraggio di opporsi all’invasione dei VaNguni, quei guerrieri che vennero dal sud e si insediarono come se fossero i padroni dell’universo. Si dice a Nkokolani che il mondo è così grande che non gli spetta nessun padrone.
La nostra terrà, però, era contesa tra due aspiranti proprietari: i VaNguni e i portoghesi. Era per questo che si odiavano tanto ed erano in guerra: perché avevano delle intenzioni molto simili. L’esercito dei VaNguni era molto più numeroso e potente. E più forti erano i suoi spiriti, che comandavano su entrambi i lati di quella frontiera che squarciò la nostra terra in due. Da un lato, l’Impero di Gaza, dominato dal capo dei VaNguni, l’imperatore Ngungunyane. Dall’altro, le Terre della Corona, dove governava un monarca che nessun africano avrebbe mai conosciuto: Carlo I, re di Portogallo.
Gli altri popoli, nostri vicini, si adeguarono alla lingua e ai costumi degli invasori neri, quelli che arrivavano dal sud. Noi, i Vatxhopi, facciamo parte di quei pochi che abitano le Terre della Corona e che si sono alleati con i portoghesi nel conflitto contro l’Impero di Gaza. Siamo pochi, murati dall’orgoglio e circondati dai kokholos, quelle mura di legno che costruiamo intorno ai nostri villaggi. Per via di quelle protezioni, il nostro spazio era diventato così piccolo che anche le pietre avevano un nome. A Nkokolani bevevamo tutti dallo stesso pozzo, una sola goccia di veleno sarebbe bastata a uccidere l’intero villaggio.
*
Infinite volte, ci svegliavamo con le urla di nostra madre. Dormiva e urlava, girando per la casa a passi sonnambuli. Durante quei deliri notturni, guidava la famiglia in camminate interminabili, attraversava paludi, ruscelli e chimere. Ritornava al nostro vecchio villaggio, dov’eravamo nati vicino al mare.
A Nkokolani, c’è un proverbio che dice così: se vuoi conoscere un luogo, parla con gli assenti; se vuoi conoscere una persona, ascolta i suoi sogni. E quello era l’unico sogno di nostra madre: ritornare lì, dove eravamo stati felici e avevamo vissuto in pace. Quella nostalgia era infinita. E comunque, esisterà mai una nostalgia che non sia infinita?
La fantasticheria che abita me è ben diversa. Non urlo, né deambulo per la casa. Ma non c’è notte che non sogni di diventare madre. E anche oggi ho sognato di essere incinta. La curva del mio ventre competeva con la rotondità della Luna. Questa volta, però, è successo l’inverso di un parto: era mio figlio a partorirmi. Forse è questo che fanno i nascituri: si liberano delle loro madri, si strappano da quel corpo indistinto e unico. Poi, quel figlio sognato, quella creatura senza volto e senza nome, si sbarazzava di me, in violenti e dolorosi spasmi. Mi sono svegliata in un bagno di sudore e con terribili dolori alla schiena e alle gambe.
Dopo ho capito: non era un sogno. Era una visita dei miei antenati. Portavano un messaggio: mi avvertivano che, con i miei quindici anni, ero già in ritardo per essere madre. A Nkokolani, tutte le ragazze della mia età erano già rimaste incinta. Solo io sembravo condannata a un destino arido. In fondo, non ero solo una donna senza nome. Ero un nome senza persona. Uno scarto. Vuota come il mio ventre.
*
Nella nostra famiglia, ogni volta che nasce un bambino non si chiudono le finestre. È il contrario di quello che fa il resto del villaggio: anche quando fa caldissimo, le altre mamme avvolgono i lattanti in panni spessi, barricandosi nel buio della camera. Non a casa nostra: porte e finestre rimangono spalancate fino al primo bagnetto del neonato. Quella smodata esposizione è, in fondo, una protezione: la nuova creatura si impregna di luci, rumori e ombre. Ed è così dall’alba dei tempi: solo la Vita ci difende dal vivere.
Quella mattina di gennaio del 1895, le finestre che avevo lasciato aperte fecero credere che fosse appena nato un bambino. Di nuovo, sognai che ero madre e un odore di neonato impregnava tutta la casa. A poco a poco, sentivo il sincopato strascinamento di una scopa. Non ero solo io a svegliarmi. Quel dolce rumore destava l’intera casa. Era nostra madre, impegnata a pulire il patio. Raggiunsi la porta e rimasi a vederla, elegante e magra, in un curvo ondeggio come se danzasse e, poi, si trasformasse in polvere.
I portoghesi non capiscono la cura che poniamo a spazzare intorno alla casa. Per loro, ha senso solo spazzare spesso l’interno degli edifici. Non gli passa per la testa di spolverare la sabbia sparsa nel cortile. Gli europei non capiscono: per noi, il fuori è dentro. La casa non è l’edificio. È il luogo benedetto dai morti, quegli abitanti che non conoscono porte e pareti. È per questo che spazziamo il cortile. Mio padre non è mai stato d’accordo con questa spiegazione, secondo lui troppo inverosimile.
― Spazziamo via la sabbia per un altro motivo, molto più pratico: vogliamo sapere chi è entrato e uscito durante la notte.
Quella mattina, l’unica impronta che c’era, era quella di un simba, quei felini che, a notte fonda, seguono l’odore dei nostri pollai. La mamma andò a controllare le galline. Non ne mancava nessuna. L’insuccesso del felino si sommava al nostro fallimento: avvistata la bestiola, gli si sarebbe data subito la caccia. Il pelo a chiazze delle genette era un ambitissimo simbolo di prestigio. Non esisteva regalo migliore per compiacere i grandi capi. Soprattutto i comandanti dell’esercito nemico, che si agghindavano fino a perdere le sembianze umane. A questo servono le uniformi: per allontanare i soldati dalla loro umanità.
La scopa, corresse, risoluta, l’audacia notturna. La memoria del felino venne cancellata in pochi secondi. Dopo, la mamma imboccò la scorciatoia, allontanandosi a raccogliere l’acqua dal fiume. Rimasi a guardarla svanire nella foresta, elegante e irta, nei suoi panni stravaganti. Io e la mamma eravamo le uniche donne a non vestire il sivanyula, i tessuti fatti di corteccia d’albero. I nostri abiti, comprati allo spaccio del portoghese, coprivano il nostro corpo, ma ci esponevano all’invidia delle donne e al desiderio degli uomini.
Quando arrivò al fiume, la mamma batté le mani, chiedendo il permesso di avvicinarsi. I fiumi sono dimore di spiriti. Piegata sul margine, controllò il bordo per evitare l’imboscata di un coccodrillo. Tutti nel villaggio credono che le grandi lucertole abbiano dei «padroni» e obbediscano soltanto ai loro ordini. Chikazi Makwakwa raccolse l’acqua, con la bocca della catinella rivolta verso la foce, per non contraddire la corrente. Mentre si preparava per ritornare a casa, un pescatore le diede un bel pesce che avvolse in un panno che portava annodato alla cintura.
Già vicino casa, successe l’imprevisto. Dal fitto bosco irruppe un gruppo di soldati VaNguni. Chikazi fece alcuni passi indietro mentre pensava: sono scappata dai coccodrilli per cadere nelle grinfie di mostri ancora più feroci. È dalla guerra del 1889 che le truppe di Ngungunyane avevano smesso di girare per le nostre terre. Per cinque o sei anni, abbiamo assaporato la Pace pensando che sarebbe durata per sempre. Ma la Pace è un’ombra in un terreno di miseria: basta l’accadere del Tempo perché scompaia.
I soldati circondarono nostra madre e subito si accorsero che riusciva a capirli quando parlavano in shizulu. Chikazi Makwakwa era nata nelle terre del sud. La lingua della sua infanzia era molto simile a quella degli invasori. La mamma era una mabuingela, quelli che camminano davanti agli altri per pulire la rugiada dall’erba. Quello era il nome che gli invasori davano alle persone che usavano per aprire i sentieri nella savana. Io e i miei fratelli eravamo il prodotto di questa mescolanza di storie e culture.
Dopo anni, gli intrusi ritornavano con la stessa minacciosa arroganza. Ribadendo vecchie paure, quegli uomini accerchiavano mia madre con la stessa strana ebbrezza che sentono gli adolescenti soltanto per il fatto di essere in molti. Le spalle in tensione di Chikazi sostenevano, con vigore ed eleganza, il carico d’acqua sulla testa. Così mostrava la sua dignità contro la minaccia degli sconosciuti. I soldati compresero l’affronto e sentirono, ancora più vivida, l’urgenza di umiliarla. All’istante, rovesciarono la brocca e fecero festa, urlando, per il modo in cui si ruppe contro il pavimento. E risero, vedendo l’acqua inzuppare il corpo magro di quella donna. Dopo, i militari non ebbero bisogno di sforzarsi per strapparle i vestiti, ormai trasparenti e stracciati.
― Non mi fate male, implorò. Sono incinta.
― Incinta? A quest’età?
Scorsero la piccola prominenza sotto i panni, dove segretamente conservava il pesce regalato. E, di nuovo, il dubbio le venne sputato in faccia:
― Incinta? Tu? Di quanti mesi?
― Sono incinta di vent’anni.
Voleva dire che i figli non erano mai usciti da dentro di sé. Che conservava nel ventre tutti e cinque i figli. Ma si trattenne. Invece, infilò le mani tra i panni alla ricerca del pesce impacchettato. I soldati rimasero a guardare il modo in cui, da sotto la capulana, percorreva i luoghi segreti del suo corpo. Senza che nessuno se ne accorgesse, con la mano sinistra afferrò la prominente spina dorsale del pesce e la usò per lacerarsi il polso della mano destra. Aspettò che il sangue fluisse e, dopo, cominciò ad aprire le gambe, come se stesse partorendo. Da sotto i panni, spingeva fuori il pesce come se stesse affiorando dalle sue viscere. Dopo, sollevò il pesce con le braccia coperte di sangue e dichiarò:
― Ecco, mio figlio! È nato il mio bambino!
I soldati VaNguni fecero alcuni passi indietro, atterriti. Quella non era una semplice donna. Era una noyi, una maga. E non esisteva discendenza più sinistra che potesse aver generato. Un pesce era, per gli occupanti, un animale tabu. Alla bestiola proibita si aggiungeva, in un unico istante, la più grave delle impurità: sangue di donna, quella sporcizia che inquina l’Universo. Quell’olio doppio e scuro le colò lungo tutte le gambe fino a ottenebrare l’intera terra attorno a lei.
Il racconto di questo episodio sconvolse schiere dei nemici. Si dice che molti soldati disertarono, impauriti dal potere della maga che partoriva pesci.
*
E fu con gli abiti e l’anima strappati, che mia madre, Chikazi Makwakwa, rientrò a casa intorno a mezzogiorno. Sulla porta raccontò l’accaduto senza lacrime né emozione. Il sangue le gocciolava dal polso come se il racconto fosse sillabato goccia a goccia. Io e mio padre l’ascoltavamo senza sapere come reagire. Alla fine, mentre si lavava le mani, la mamma mormorò, con una voce irriconoscibile:
― Bisogna fare qualcosa.
Mio padre, Katini Nsambe, aggrottò il sopracciglio e sostenne che rimanere zitti e buoni sarebbe stata la miglior risposta. Eravamo una nazione occupata e conveniva passare inosservati. Noi, i Vatxhopi avevamo perso quella terra che era nostra e dei nostri antenati. Non ci sarebbe voluto molto a che i nostri invasori mettessero piede nel cimitero dove seppellivamo placente e stelle.
La mamma reagì con fermezza: Le talpe vivono al buio. Mio padre scosse la testa e replicò in sordina:
― A me piace il buio. Al buio non si notano i difetti del mondo. Ho sempre sognato di essere una talpa. Per come vanno le cose nel mondo, dobbiamo solo ringraziare Dio di essere ciechi.
Furiosa, la mamma sospirò rumorosamente mentre si chinava sul fuoco per rimescolare la ushua. Bagnò la punta del dito a far finta di verificare il calore della pentola.
― Un giorno sarò come le talpe. Avrò il terreno intero sopra di me, bisbigliò papà, con anticipato rammarico di quel preannunciato destino.
― Tutti ce l’avremo, disse la mamma.
― Ci manca poco che parto per le miniere. Farò come mio padre, me ne andrò da qui e mi rifarò una vita nell’Africa del Sud. Questo farò.
Non era un preavviso. Era una minaccia. Tirò fuori dalla tasca un pizzico di tabacco e una vecchia cartina. Con l’attenzione di un chirurgo iniziò lentamente a rollare una sigaretta. Nessun nero in tutto il villaggio poteva vantare di farsi da fumare in quel modo. Solo lui. Con un atteggiamento da re si avvicinò al fuoco e prese un tizzone per accendere la sigaretta. Dopo, molto irto e con il mento all’insù, soffiò il fumo in faccia alla sua indifferente moglie.
― Tu, mia cara Chikazi, insulti le talpe sapendo che in questo modo offendi il mio defunto padre.
Mia madre canticchiò una vecchia canzone, un ngodo tradizionale. Era un pianto di donna, che si lamentava di essere nata già vedova. Risentito, mio padre si discostò rumorosamente.
― Me ne vado da qui, dichiarò.
Voleva far vedere di essere ferito, la moglie non era l’unica che sanguinava. Si separò dalla sua stessa ombra e se ne andò accanto al grande termitaio dove, assentandosi, credeva di diventare più visibile.
Dopo, lo vedemmo fare un giro intorno alla casa, per poi allontanarsi in direzione della valle. La piccola incandescenza della sua sigaretta si esauriva nel buio, come se fosse l’ultima lucciola a questo mondo.
*
Rimanemmo sedute, io e la mamma, in un ordire di silenzi di cui solo le donne sono capaci. Le sue dita magre smuovevano la sabbia come a comprovare una certa intimità con il terreno. La sua voce aveva un accento terroso quando chiese:
― Hai preso del vino dal portoghese?
― Ne sono avanzate ancora alcune bottiglie. Hai paura che papà ti picchi?
― Ormai lo sai com’è: prima beve e poi mi picchia.
Mistero che prescinde da ogni comprensione: il modo in cui papà conciliava in sé anime talmente opposte. Da sobrio, la sua delicatezza era come quella di un angelo. Offuscato dell’alcool, si trasformava nella più malvagia delle creature.
― È incredibile come papà non abbia mai sospettato che fingi.
― Perché, io fingo?
― Certo che lo fai. Quando ti picchia e tu piangi dal dolore. Non fingi?
― Questa malattia è un segreto, tuo padre non lo sospetta neanche. Quando mi picchia pensa che le mie lacrime siano vere.
La malattia era congenita: Chikazi Makwakwa non sentiva dolore. Mani e braccia, segnati da continue ustioni, facevano stranire il marito. Tuttavia, credeva che quella insensibilità derivasse da amuleti commissionati a Rosi, la cognata. Solo io sapevo che si trattava di un difetto di nascita.
― E l’altro dolore, mamma?
― Quale?
― Il mal d’anima.
Si mise a ridere, scrollando le spalle. Quale anima? Quale anima le rimaneva dopo che le erano morte due figlie e dopo che due figli erano andati via di casa?
― Anche tua madre veniva picchiata?
― La nonna, la bisnonna e la trisnonna. È così da quando la donna è donna. Preparati a esserlo anche tu.
Una bambina non mette in dubbio le certezze dei più vecchi. Imitai il suo gesto e nella conca della mano mantenni sospeso un pugno di sabbia che, dopo, lasciai cadere a cascata. Quella sabbia gialla era, secondo l’usanza della nostra gente, alimento delle gestanti. Mi scorreva tra le dita lo spreco della mia esistenza. Chikazi Makwakwa interruppe i miei pensieri:
― Sai com’è morta tua nonna? E non aspettò la risposta. Fulminata. Morì a causa di un fulmine.
― E come mai ti è venuto in mente ora?
― Perché è così che voglio morire anch’io.
Era l’epilogo che pretendeva per sé: senza corpo, senza peso, senza rimasugli da seppellire. Come se una morte non sofferta cancellasse tutta la sofferenza di una vita.
*
Ogni volta che si abbatteva una tempesta, nostra madre usciva di corsa nei campi e rimaneva lì con le braccia alzate, imitando un albero secco. Aspettava la scarica elettrica fatale. Ceneri, polveri e fuliggini: era quello che sognava di diventare. Era questo il destino tanto desiderato: diventare pulviscolo indistinto, leggero, così leggero che il vento l’avrebbe fatto viaggiare per il mondo. Il mio nome trovava giustificazione in quel desiderio della nonna. Questo è quello che la mamma voleva ricordarmi.
― Mi piace il nome Cinza, le dissi. Mi fa venire in mente gli angeli, non so perché.
― Ti ho dato quel nome per proteggerti. Quando si è cenere, niente può far male.
Gli uomini potevano anche picchiarmi, ma non esisteva nessuno capace di ferirmi. Era questo l’intento di quel battesimo.
Le sue mani rastrellavano il terreno: quattro fiumi di sabbia cadevano tra le dita. Rimasi in silenzio, sotterrata da quella polvere che sgorgava dalle sue mani.
― Adesso, vai a cercare tuo padre. È geloso di noi.
― Geloso?
― Di me, perché non gli do tutte le mie attenzioni; di te, perché sei stata educata dai preti. Appartieni a un mondo in cui lui non potrà mai entrare.
Così sono gli uomini, spiegò: hanno paura delle donne quando parlano, e ancora di più quando rimangono in silenzio. Lo dovevo capire: mio padre era un brav’uomo. Aveva solo paura di non essere grande come gli altri uomini.
― Tuo padre è uscito di casa arrabbiato. Impara una cosa, figlia mia. La cosa peggiore che una donna possa dire a un uomo è che lui deve fare qualcosa.
― Vado a cercare papà.
― Non dimenticarti del vino.
― Non ti preoccupare, mamma. Ho già nascosto le bottiglie.
― Giusto il contrario, figlia mia. Porta con te una bottiglia da fargli bere.
― Non hai paura che, poi, ti picchi?
― Quel vecchio testone non può certo dormire nel bosco. Riportalo a casa, sobrio o ubriaco. Il resto poi si vedrà.
Dopo, la mamma rientrò nella tristezza, come un animaletto domestico che ritorna al suo recinto. Quando già camminava, riprese a dire:
― Chiedigli se andiamo a vivere a Makomani, chiedigli di ritornare in riva al mare. A te, ti ascolta. Chiediglielo, Imani, per l’amor del cielo!
Bibliografia
Borges Coelho João Paulo (2015), Abrir a fábula: Questões da política do passado em Moçambique, «Revista Crítica de Ciências Sociais», n. 106, 2015, p. 153-166. “Consultato il 07/04/2022” url: <https://journals.openedition.org/rccs/5926>.
Couto Mia (2005), Pensatempos, Lisboa, Caminho.
― (2015), Mulheres de Cinza, Lisboa, Caminho.
― (2016), Sombras de Água, São Paulo, Companhia das Letras (ed. digitale).
― (2018), O Bebedor de Horizontes, Lisboa, Editorial Caminho (ed. digitale).
Said Edward introduzione a Guha Ranajit e Spivak Gayatri Chakravorty (2002), Subaltern Studies. Modernità e (post)colonialismo, Verona, Ombre corte, p. 19-27.
Segre Cesare (1991), Intrecci di voci, Torino, Einaudi.
White Hayden (2020), Forme di storia, Roma, Carocci Editore.
Note
- Pseudonimo di António Emílio Leite Couto, nato a Beira nel 1955 da genitori portoghesi, è uno dei maggiori rappresentanti della letteratura mozambicana contemporanea nonché biologo di fama nazionale. Comincia la sua carriera di scrittore come giornalista e poeta, sulla scia di suo padre Fernando Leite Couto. Partecipa attivamente alla vita politica del paese, appoggiando, almeno inizialmente, i principi ideologici del Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) nella lotta per l’indipendenza del Mozambico. Inaugura la sua carriera letteraria nel 1983, con la pubblicazione della sua prima e unica raccolta di poesie Raiz de orvalho, a cui segue la pubblicazione di opere di ogni genere, dai racconti – Vozes Anoitecidas (1987), Cada Homem é uma Raça (1990), Estórias Abensonhadas (2003) tra gli altri – alle cronache – Cronicando (1991), Pensatempos (2005), E se Obama fosse Africano? (2009) –, inclusi i romanzi, di cui ricordiamo Terra Sonâmbula (1992) capolavoro indiscusso.
- Corsivo mio.
- Si legga la seconda definizione di artefatto in Treccani, al sito: https://www.treccani.it/vocabolario/artefatto/ (ultima consultazione 07/04/22).
- Mi riferisco, in particolar modo, all’idea di João Paulo Borges Coelho (2015), quando riferisce che «o que nós consideramos como passado é também uma visão que olhos e motivos actuais têm dele – olhos e motivos que se concretizam numa narrativa» (p. 155), che ben spiega come ogni presente produca una visione del passato diversa.
- L’ormai famoso Ultimatum imposto dall’Inghilterra al Portogallo ha lasciato, nella Storia portoghese, un segno indelebile. In un periodo in cui le grandi potenze europee si stavano disputando l’Africa, stabilendone i confini politici, il Portogallo pensò bene di unire i due litorali tra Angola e Mozambico in un unico grande territorio, andando a inglobare altri possedimenti allora sotto il dominio dell’Inghilterra che, a sua volta, aveva già in mente di costruire una linea ferroviaria che attraversasse il territorio africano e unisse il Cairo a Città del Capo. L’audacia portoghese fu punita dall’Ultimatum del 1890 e il Portogallo, sottostando alla volontà inglese, confermò indirettamente il suo ruolo di potenza subalterna.
- Il principio di relatività della realtà è alla base della filosofia postmoderna a cui afferisce l’opera letteraria dello stesso Mia Couto.
- A questo proposito, va ricordato che Mia Couto introduce ogni capitolo narrato da Imani da un’epigrafe che si attesta come una sorta di anticipazione del tema del capitolo: si tratta spesso di un proverbio o detto popolare (reale o inventato), ma che comunque racchiude quella saggezza ancestrale che caratterizza la “mundividência” africana; altre volte, però, Couto si serve di estratti di documenti ufficiali, necessari allo scrittore per lo studio approfondito del “lato reale” della narrazione.
- Con il termine estória rimando all’accezione utilizzata già da João Guimarães Rosa (1908-1967), uno dei maggiori rappresentanti della letteratura brasiliana, di racconto legato al paradigma dell’oralità, caratteristico della cultura popolare brasiliana, fecondata dalle tradizioni indigene e africane.