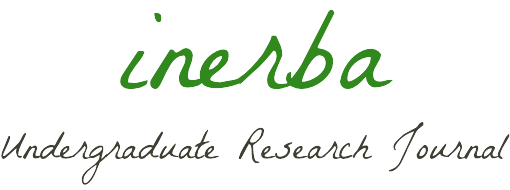Introduzione
La produzione letteraria e saggistica della scrittrice Carmen de Burgos (Almería 1867-Madrid 1932) è rimasta avvolta per decenni nell’oblio. Il suo nome figurò nell’indice degli autori proibiti già nell’immediato dopoguerra, oscurato dalla censura franchista del pensiero libero e riformatore: l’impegno sociale e letterario di Carmen de Burgos vennero irrimediabilmente messi a tacere attraverso la cancellazione della totalità delle sue opere. All’inizio degli anni Novanta, il recupero dei dati biografici e del percorso letterario di Carmen de Burgos rappresentò, nell’opera di Concepción Núñez Rey, quella che a ragione viene definita una «reparación histórica» (Núñez Rey 2005: 11). Negli ultimi decenni, grazie al lavoro sistematico degli accademici europei e statunitensi, Carmen de Burgos ha riacquisito il suo riconoscimento di scrittrice, femminista e attivista. Dal totale oblio, l’eredità ideologica e letteraria di Carmen è divenuta, come ha osservato Anja Louis (2018), uno dei riferimenti obbligati per gli studi di genere in Europa. Anche in Italia, in questi ultimi anni, le opere dell’autrice hanno cominciato a diffondersi in traduzione tra il grande pubblico (Pugnale di garofani, 2005; La donna moderna e i suoi diritti, 2018; Il piano inclinato, 2023; La piscina, la piscina, 2024; Voglio vivere la mia vita, 2024; L’articolo 438, 2024) e l’interesse di critici e lettori per questa figura poliedrica sta senza dubbio crescendo, sebbene alcune sfaccettature dell’opera di Carmen de Burgos restino ancora in ombra.
Carmen de Burgos si impose nel panorama culturale del suo tempo come una personalità che non si limitò a definire i diritti e le peculiarità della «donna nuova», ma incarnò pienamente questa figura anche nella propria vita privata e professionale. Riuscì a percorrere il suo cammino garantendosi l’indipendenza economica dal marito – dal quale si separò alla fine dell’Ottocento, un’epoca in cui il divorzio era tutt’altro che pratica comune – dapprima grazie alla professione di insegnante e, in un secondo momento, grazie al ruolo di giornalista. Dal 1903 Carmen de Burgos fu infatti la prima donna, nel panorama spagnolo, a ottenere un posto fisso nella redazione di un quotidiano con la sua columna «Lecturas para la mujer» e portò avanti la carriera giornalistica per tutta la sua vita, mantenendo sempre il suo primo pseudonimo Colombine. Fu anche la prima corrispondente di guerra donna, visto che si incaricò nel 1909 di riportare le notizie dal fronte di Melilla durante la guerra con il Marocco. Tra le pagine dei quotidiani propose due “plebisciti”, l’uno nel 1904 e l’altro nel 1906, chiedendo a tutti i suoi lettori – dai cittadini comuni agli intellettuali del tempo – di esprimersi riguardo la necessità di una legge di divorzio e la concessione del suffragio femminile, rispettivamente. Ma Carmen de Burgos fu anche traduttrice da più lingue, autrice di romanzi e narrativa di viaggio. Instancabile esploratrice, fondò un suo salotto letterario nel 1908, di ritorno da Parigi, e lo soprannominò la tertulia modernista. Interagì da vicino con le correnti culturali che rapidamente si facevano spazio nel panorama artistico dell’epoca, si legò nella vita letteraria e personale a Ramón Gómez de la Serna, una delle figure di maggiore spicco dell’avanguardia spagnola, fu grande conoscitrice dei grandi maestri della ritrattistica e degli autori stranieri del secolo precedente.
Il nome di Carmen de Burgos si associò al suo tempo anche alla figura di una scrittrice interessata alle occupazioni femminili, non solo nell’ambito politico dell’istruzione, del voto e del lavoro delle donne, ma anche nei temi della vita quotidiana e dei saperi tipicamente femminili. Nei manuali di moda trovarono spazio consigli e riflessioni su un’arte alimentata storicamente da quella metà della popolazione che era stata esclusa dalla cultura e dalla scuola. La narrativa di Colombine, a differenza delle nuove correnti orientate a una forma di cultura elitaria e divisiva, mantenne un rapporto privilegiato con il grande pubblico, pur senza rinunciare a forme peculiari di sperimentazione estetica. Più nello specifico, le opere di Carmen de Burgos rispondevano a due tipi di esigenze diversi: il proposito di interfacciarsi con la cultura di massa attraverso temi della vita quotidiana e quello di elaborare una forma di espressione che rispecchiasse il vigore della ricerca artistica più elevata.
A seguito della riscoperta di un’autrice tanto prolifica quanto eclettica, si può affermare che il processo di recupero progressivo delle opere di Carmen de Burgos ha condotto l’interesse della critica verso la narrativa più esplicitamente impegnata nei temi sociali, tralasciando un’area piuttosto estesa della produzione dell’autrice. Alcuni romanzi, brevi o estesi, hanno pertanto raggiunto un certo livello di fama tra gli studiosi, che hanno in più occasioni analizzato la complessa interazione di stili letterari e temi contemporanei; altre opere, viceversa, risultano ancora oggi poco lette e dibattute. Tra queste ultime dobbiamo sicuramente includere La mujer fantástica, il romanzo pubblicato nel 1924 per l’editrice Sempere su cui si concentra il presente articolo. Il romanzo ripropone le teorie sulla moda e l’osservazione della società più tipiche dei manuali di consigli per donne, e nell’istituire un parallelismo tra la moda e l’arte l’autrice utilizza alcuni strumenti retorici vicini alle avanguardie e alle nuove correnti culturali dell’epoca.
Una prima versione dell’opera va fatta risalire al 1923: i primi sei capitoli del romanzo, infatti, vennero pubblicati sotto lo stesso titolo proprio in quell’anno, all’interno della collana La novela corta. Più tardi, con l’edizione Sempere, la narrazione si estese fino al capitolo XXIV. Il romanzo breve si limitava a raccontare le vicende di una protagonista, scaltra e spregiudicata, originaria della Francia, ma infiltrata nella vita borghese ginevrina. La mujer fantástica nella sua versione estesa, invece, approfondisce la vita della protagonista Elena esplorando anche le nuove avventure e sventure nella capitale francese, dove la donna fa ritorno a seguito di inganni, tranelli e delusioni.
La novela corta e le esigenze editoriali
La produzione narrativa occupò Carmen de Burgos in maniera regolare fino almeno al 1931 e non conobbe battute d’arresto: non a caso, i titoli delle opere reperite e leggibili ammontano a più di cento soltanto tra i romanzi e le novelas cortas. A questi si devono aggiungere anche i racconti, pubblicati nel primo decennio del secolo entro le raccolte Ensayos literarios (1900), Alucinación (1905) e Cuentos de Colombine (1908) e affidati saltuariamente, tra gli anni Dieci e Trenta, ai numeri di giornali e riviste quali Por esos mundos, Nuevo Mundo, Mundial Magazine e, soprattutto, La Esfera.
La fondazione ad opera di Eduardo Zamacois della collana El Cuento Semanal nel 1907 aprì pionieristicamente la strada alle pubblicazioni di novelas cortas che a partire da quel momento trovarono la massima diffusione per i successivi venticinque anni. All’interno di queste collane si riunivano opere inedite tanto dei maestri della letteratura del secolo precedente quanto dei giovani scrittori emergenti; il prezzo modico delle pubblicazioni, oltretutto, rendeva la lettura accessibile a grandi fasce di pubblico: come è prevedibile, l’impulso culturale che ne derivò ebbe portata epocale. Come osserva Kirkpatrick (2003), la modalità di distribuzione, i temi e le forme di questo genere appena nato concorrevano a caratterizzare e promuovere un nuovo concetto di modernità. Ma la novela corta si combinò anche al tasso crescente di alfabetizzazione femminile (che vide un grande aumento nei primi tre decenni del secolo) e si caratterizzò per il ruolo svolto dalle donne sia come pubblico che come autrici. Le collane di romanzi brevi e di racconti, infatti, promossero da un lato la lettura nel consumo di massa, e dall’altro incoraggiarono l’affermazione di una nuova generazione di donne scrittrici: tra queste, naturalmente, Carmen de Burgos, oltre a María Martínez Sierra, Concha Espina, Sofía Pérez Casanova, Blanca de los Ríos. A differenza di queste ultime, tuttavia, Colombine si limitò a pubblicare opere di narrativa solamente nelle collane “popolari”, rifuggendo le forme di diffusione più elitarie della letteratura istituzionale. Certamente, le edizioni per il grande pubblico non erano ispirate dal dogma modernista «l’arte per l’arte», ma l’innovazione estetica era incoraggiata dalla forte attrazione che esercitavano su una varietà così ampia di classi sociali, che necessitava un approccio sempre nuovo e al passo coi tempi. Per questo, nonostante Colombine concentrasse il suo impegno nel raggiungimento di un pubblico vasto e principalmente femminile, nella forma del romanzo breve riscontrò un’opportunità anche per la sperimentazione artistica.
Secondo Kirkpatrick (2003) il genere e il pubblico a cui si rivolgeva Carmen de Burgos richiedevano uno stile narrativo che si concentrasse sullo sviluppo lineare della fabula e che lasciasse spazio alla componente emotiva, aggiungendo un tocco vivido ed elementi sorprendenti per catturare l’attenzione. Le prime opere di Carmen de Burgos nell’ambito della narrativa riflettono una tendenza allo stile del realismo – o più propriamente a una forma di naturalismo tardivo – che, sebbene nel secolo precedente fosse stato associato alla poetica più adatta al progresso culturale, all’inizio del XX secolo era stato superato da nuove ambizioni estetiche dagli scrittori più giovani. Lo stile che caratterizza El tesoro del castillo del 1907 e Los inadaptados del 1909 si orienta all’osservazione distanziata e alla presentazione di dettagli accurati secondo le modalità del naturalismo; la protagonista di questi romanzi è la società rurale andalusa nell’Almería nativa di Carmen. In effetti, poco tempo dopo il suo arrivo a Madrid, l’autrice strinse una durevole amicizia e una proficua collaborazione con Vicente Blasco Ibáñez: l’adesione a una forma tardiva di naturalismo sembra in linea con la produzione dell’intellettuale con cui Colombine collaborò per diversi anni nella casa editrice Sempere. Di ritorno da un viaggio finanziato dal Ministero dell’Istruzione, oltretutto – lo stesso che guidò la stesura di Por Europa (1906) – Carmen de Burgos fondò il suo salotto letterario, sulla spinta dell’atmosfera culturale parigina, soprannominato la tertulia modernista. Seppur costretta a continui spostamenti tra Toledo e Madrid – sede ufficiale di queste riunioni culturali ed artistiche – Carmen de Burgos divenne un’ospite di primo piano nella vita culturale madrilena e i mercoledì presso il suo salotto divennero presto un’istituzione per i giovani intellettuali della capitale.
Alcune tendenze dello stile realista non furono mai completamente abbandonate dall’autrice, né fu mai totale l’adesione alla poetica decadente e simbolista che caratterizzava il modernismo, il cui slancio vitale, già partire dal 1910, sembrava essersi esaurito. A divenire portavoce della modernità fu l’avanguardia nelle sue diverse declinazioni, con la quale Colombine, ancora una volta, ebbe contatti molto ravvicinati. Infatti, la lunga relazione sentimentale che l’autrice intrattenne con Ramón Gómez de la Serna mantenne vivo il confronto con il mondo delle avanguardie, di cui il giovanissimo scrittore fu uno dei maggiori esponenti e promotori in Spagna. Tuttavia, Burgos interagì con le nuove correnti in maniera inevitabilmente superficiale. L’autrice dipendeva economicamente dalla propria attività di scrittura, che era il mezzo di sostentamento per lei stessa e parte della sua famiglia: le grandi sperimentazioni avanguardiste costituivano per gli interessi dell’autrice un enorme rischio, dato che la comprensione e il favore del pubblico erano prerequisiti fondamentali per le sue pubblicazioni, generalmente orientate alla letteratura di consumo. In conclusione, la ricerca avanguardista si sviluppò suscitando la curiosità dell’autrice e implicandola nel dibattito culturale, ma non costituì l’elemento centrale delle aspirazioni di Colombine. Per queste ragioni, la sua produzione narrativa non fu mai impermeabile all’influsso dei nuovi movimenti culturali ma seppe inglobare i soli elementi che risultassero più favorevoli al suo stile.
La mujer fantástica, l’altra faccia della narrativa
Sullo sfondo di un’ambientazione estera e cosmopolita, La mujer fantástica si configura come una narrazione in grado di fondere le strategie tradizionali per la letteratura popolare e le più moderne – ed elitarie – tecniche e aspirazioni proprie della ricerca avanguardistica di quell’epoca. In particolare, il romanzo si occupa di presentare la femminilità moderna e le sue contraddizioni, facendo comunque riferimento a una serie di questioni sociali eternamente care a Carmen de Burgos: al fianco della storia di una protagonista che gira le grandi capitali dell’Europa centrale alla ricerca dell’amore, dell’ammirazione e dell’eterna giovinezza, si colloca la narrativizzazione di tabù quali la prostituzione, l’aborto e il divorzio. La fusione stilistica e tematica determina la natura irriducibilmente ibrida di quest’opera, che Bender (2017) ha giustamente definito «both playful and erudite; popular and exclusive; superficial and serious».
Il testo in questione si occupa di celebrare gli aspetti materiali della cultura contemporanea più strettamente collegati alla modernità, all’innovazione e alla frenesia della metropoli, secondo l’entusiasmo tipico delle avanguardie di fronte a tutto ciò che rompeva con il passato e con il tradizionalismo della società borghese. Il personaggio principale non rappresenta un esempio di moralità positiva, ma è modellato in conformità con quella che nello studio sistematico di Establier Pérez (2000) viene riconosciuta come la categoria delle «donne avvelenate» della narrativa di Burgos. Oltre a questo, l’arte attraversa le pagine del romanzo inserendosi in una trama di riferimenti storici che si configurano come una meditazione ludica sulla cultura europea. Bender (2017) pensa infatti che questo approccio giocoso della letteratura nei confronti della pittura, la mitologia e la storia rifletta le caratteristiche messe in luce da Ortega y Gasset nel 1925 nel suo saggio La deshumanización del arte, tra cui, maggiormente, possiamo individuare la «esencial ironía» (Ortega y Gasset 2017: 62) che l’intellettuale attribuiva all’«arte nuova» dei giovani avanguardisti.
La mujer fantástica innesta su una trama apparentemente semplice e frivola – completamente focalizzata sulle vicende della sua protagonista Elena – la descrizione della vita metropolitana nelle città d’Europa in cui la modernità si stava affermando. Se quest’ultima componente mette in luce il rapporto con l’avanguardia, è opportuno notare come l’essenza della narrativa di Colombine venga conservata, e al contempo rielaborata in osservanza delle tecniche stilistiche più care all’«arte nuova». In questo senso, l’attenzione alle caratteristiche della donna moderna viene affidata a un parallelismo tra le arti figurative e la moda: l’interazione e la fusione delle due entità viene formalizzata nella mujer fantástica grazie al peculiare strumento retorico dell’ecfrasi.
Un’opera come La mujer fantástica risulta ancora oggi d’interesse proprio in virtù di una storia che ci appare tanto controversa quanto contemporanea; nemmeno le obiezioni etiche attraverso cui Carmen de Burgos elabora un personaggio sfaccettato e ambivalente come Elena risultano anacronistiche rispetto ad alcuni valori condivisi, almeno parzialmente, dal lettore di oggi. Se si accetta l’idea che il pubblico più esteso a cui si rivolgeva Colombine fossero delle donne della classe media e di quelle più basse, che progressivamente erano diventate una parte del mercato letterario, possiamo concludere che l’intento principale del romanzo fosse quello di intrattenere il lettore (o, soprattutto, la lettrice) mostrando tutte le nuove possibilità della donna e proiettando un inventario aggiornato di modelli femminili che rispecchiavano la nuova epoca. Alcune delle loro caratteristiche suscitavano ammirazione, altre mettevano in luce la nocività di alcuni comportamenti, anche quando questi ultimi erano un tentativo di sovvertire la morale borghese. Certamente, l’autrice si incaricava di trasmettere la consapevolezza su un inventario di temi che spaziavano dai tabù sociali e legali all’applicazione di modalità espressive ormai pienamente dotate di una propria dignità (l’eleganza e la moda); nell’insieme, comunque, l’intento ancora lievemente didattico dell’opera di Colombine si inseriva entro la cornice di un romanzo semplice e alla portata di tutti.
Le narrazioni ambientate in società cosmopolite, tipiche della fase tarda della produzione di Burgos, non offrono modelli di femminilità esemplare, come avviene nel caso di Elena. Tuttavia, esse svolgono un ruolo di contrappunto rispetto all’opprimente oscurantismo spagnolo, in quanto ritraggono un clima di libertà e tolleranza morale di cui le donne, in particolare per quanto concerne la sfera affettivo-sessuale, possono beneficiare. Il personaggio di Elena poneva di fronte agli occhi del pubblico la possibilità di emancipazione e, parallelamente, nobilitava la moda, il portamento e la cura dell’immagine e usava il loro potenziale per accattivare dei lettori che, nella società del tempo, si confrontavano quotidianamente con queste entità. Ma metteva anche in guardia dall’indifferenza e dalla superficialità, dal “bovarismo” e dalla cieca frivolezza; invitava, in altre parole, pur indirettamente, alla misura e alla consapevolezza per la salvaguardia di valori umani fondamentali. Il lettore contemporaneo, d’altra parte, leggendo oggi La mujer fantástica, sarà pienamente in grado di comprendere il dramma di una protagonista che, tanto abituata a fare affidamento sul fulgore della propria immagine, firmerà la propria condanna rifiutandosi di conformarsi all’inesorabile scorrere del tempo. In Elena, dunque, riscontriamo oggi una tendenza affatto sfatata dal nuovo millennio, ma piuttosto incoraggiata e alimentata dalla cultura mediatica e dalla forza dell’immaginario visuale.
Il romanzo, come ha ampiamente evidenziato Bender, autorizzava più livelli di lettura. A questo proposito, l’ampia schiera di riferimenti intertestuali e «interartistici» (Bender 2017) rendeva in più casi il testo trasparente solamente al lettore che avesse una completa familiarità con la cultura e le arti figurative europee. Come aveva teorizzato Ortega y Gasset, uno dei maggiori dispositivi attribuibili all’«arte nuova» era quello della metafora, che abbandonava le percezioni standardizzate della realtà per esprimere nella narrazione significati più complessi; si distingueva infatti per la sua tendenza a dividere in due gruppi il pubblico: l’uno comprendeva appieno l’opera d’arte, l’altro, invece, non la comprendeva1. La natura divisiva dell’avanguardia scaturiva dunque, in ultima analisi, dal necessario sforzo di decodifica che i fruitori dell’arte dovevano affrontare; soltanto una parte degli spettatori poteva disporre pienamente dei mezzi per la decodifica (l’istruzione o la padronanza del linguaggio artistico, per esempio), ma un’altra parte rimaneva necessariamente esclusa da questa elaborazione strutturata.
Ciò che nell’opera di Colombine necessita di una decodifica più sofisticata è da ricercarsi nei vari riferimenti a personaggi storici, a tecniche e prodotti per la toeletta, nonché ad opere d’arte e pittori. In generale, lo stile di Carmen de Burgos tendeva sempre a costellare gli scritti (che si trattasse di un trattato come La mujer moderna y sus derechos o di una novela corta, di una conferenza o di un articolo di giornale) di nozioni e figure antiche e contemporanee che venivano solamente alluse o prese a paragone: la maggior parte delle volte non venivano fatte digressioni che fornissero informazioni sul referente; piuttosto, l’autrice si affidava alla conoscenza del suo pubblico circa gli argomenti di cui parlava. In generale, elogiava per il romanzo uno stile che privilegiasse la concisione della narrazione ed evitasse lunghe descrizioni; nel arte de ser mujer, infatti, formula questa preferenza sottolineando la maggiore forza del teatro in virtù della dimensione visiva: «en la novela la descripción es enojosa; pero en la escena todo ese mundo vive» (Burgos 1916b: 106).
Bender (2017) si è occupata di analizzare i riferimenti alla pittura contenuti ne La mujer fantástica e le modalità in cui questi istituiscono una connessione tra le belle arti e la moda. Come evidenzia la studiosa, in questo romanzo l’ecfrasi svolge la stessa funzione che aveva la metafora nella teorizzazione di Ortega y Gasset; se, però, la tecnica dei riferimenti intertestuali dimostra una vicinanza con l’avanguardia, la fase della produzione artistica europea che Carmen de Burgos cita più spesso (ovvero, i ritratti dell’aristocrazia) rientra in una delle forme pittoriche più largamente disconosciute dall’«arte nuova» e dal modernismo, come evidenziato dalla stessa Bender (2017).
Innanzitutto, è opportuno definire l’ecfrasi come la rappresentazione letteraria di un oggetto appartenente all’arte figurativa (e alla sfera visiva). Nel linguaggio viene trasposto ciò che normalmente viene osservato, ovvero percepito e valutato attraverso la vista. Dato che l’ecfrasi consiste puramente nella descrizione di ciò che viene catturato con gli occhi, come osserva Frederick de Armas (2005), un riferimento all’opera artistica, al suo autore o a un dettaglio che non comprenda la formulazione esplicita (a livello linguistico) di ciò che viene osservato costituisce una trasgressione dell’ecfrasi stessa. Questa tecnica viene denominata ecfrasi allusiva e fa leva sull’effetto mnemonico che le parole devono essere in grado di evocare; l’ecfrasi vera e propria, in ultima analisi, si dispiega non nel testo ma nella mente del lettore, purché questo abbia familiarità con l’opera (che non viene descritta ma solamente nominata o allusa).
La mujer fantástica fa ampio uso di questa tecnica fin dalla prima pagina del romanzo, dove le tre sorelle che accolgono lo zio Andrés vengono presentate come «bonitas, graciosas; parecían tres damitas del Segundo Imperio, escapadas de un cuadro de Winterhalter» (Burgos 1924a: 5). Seguono almeno altri quattro momenti ecfrastici: Elena nomina il pittore svizzero Böcklin di fronte alle cascate del Reno, riferendosi a un’opera osservata a Basilea2 (Burgos 1924a: 46); Elena si riferisce a un uomo che vede passare dicendo che sembra un ritratto di Richelieu (Burgos 1924a: 102); il narratore colloca nell’antico castello dove alloggia Elena in Normandia dei ritratti e delle incisioni del pittore francese Isabey (Burgos 1924a: 200); la descrizione dell’albergo del XVIII secolo dove Elena incontra il medico degli innesti comprende una parete occupata da un ritratto equestre di Luigi XIV (Burgos 1924a: 220). Alcuni tra questi riferimenti evocano delle immagini che non vengono tuttavia descritte (è il caso, per esempio, del quadro di Böcklin e del ritratto di Luigi XIV), in altri casi il dipinto evocato fornisce senso alla comparazione con la realtà e dunque, perché il lettore comprenda la similitudine, è necessario che abbia familiarità col quadro (è il caso del ritratto di Richelieu e dei quadri di Winterhalter). Le opere di Jean-Baptiste Isabey, nel capitolo XX, non vengono descritte nel dettaglio, né si esplicita il soggetto ritratto; il narratore si sofferma brevemente sulle pettinature e gli accessori messi in mostra dalle donne raffigurate. L’allusione iniziale alle «damitas del Segundo Imperio» (Burgos 1924a: 5), anch’essa legata all’immaginario della moda femminile, è fondamentale nel creare un sistema di riferimenti che si intersecano su più piani e si ripresentano nel corso del romanzo.
Franz Xaver Winterhalter fu uno dei più celebri pittori della nobiltà europea e fu uno dei ritrattisti della corte di Napoleone III; uno dei suoi dipinti più famosi è proprio Ritratto dell’Imperatrice Eugenia con le sue dame di corte del 1855. Carmen de Burgos era una grande ammiratrice di Eugenia de Montijo, tanto che scrisse una biografia per La Novela Corta nel 1920 (La emperatriz Eugenia) e, in più occasioni, nei manuali di moda inserì aneddoti sulle mode introdotte dalla sovrana o sui vestiti indossati (ad esempio, il suo vestito da sposa viene descritto nel arte de ser mujer3). Nel romanzo, se le tre sorelle vengono associate alle dame di corte, due menzioni esplicite di Eugenia servono a creare un parallelismo con il personaggio di Elena: il primo esempio è quando la protagonista dice a Renée «me gustan las cejas a lo emperatriz Eugenia» (Burgos 1924a: 92), il secondo è quando Elena ripercorre di fronte a Luisa i suoi successi di gioventù e il narratore lo riporta commentando «se diría que hablaba de otra mujer, de una especie de Emperatriz Eugenia» (Burgos 1924a: 215). Come ha evidenziato Bender (2017), almeno il primo caso costituisce una citazione simile all’ecfrasi allusiva per il fatto che l’immagine di Eugenia evocata fa riferimento ai ritratti che circolavano dell’imperatrice, piuttosto che a una figura conosciuta attraverso le fotografie (che, nel caso di Eugenia, circolavano molto meno dei dipinti che la rappresentavano).
Florek ha esaminato la cultura visiva della femminilità nella corte austriaca di Elisabetta (Sissi); il suo studio ha messo in luce come la principessa d’Austria abbia acquisito influenza nella sfera pubblica guadagnando dapprima la celebrità attraverso«the visual space of the Winterhalter commission, a project in which Elisabeth possessed greater agency» (Florek 2023: 12). Le regnanti come Elisabetta (ma anche come Eugenia), in altre parole, attraverso i loro ritratti plasmavano attivamente la loro immagine, che era il primo mezzo con cui si proiettavano nella società su cui dovevano regnare. Florek ha anche messo in evidenza la confusione che si produceva tra la cultura di massa e la cultura elitaria all’interno di alcuni album personali di Sissi, dove si assiste a una giustapposizione di ritratti delle grandi aristocratiche del tempo (tra cui anche Eugenia) e le foto di attrici e ballerine4. Nel progetto di Elisabetta, in sintesi, la moda e l’immagine avevano un preciso ruolo e un preciso mezzo attraverso cui imporsi nella mentalità comune; in linea con i suoi piani, i dipinti di Winterhalter, mezzo di diffusione di un’immagine ben studiata della nobildonna, vennero riconosciuti come la modalità più favorevole per plasmare e alimentare la celebrità dell’imperatrice d’Austria.
Carmen de Burgos, nonostante la sua formazione da autodidatta, fu una grande conoscitrice dell’arte. Nell’autobiografia inserita nelle prime pagine di Al balcón, in effetti, diceva «mis placeres más grandes los hallo en el Arte» (Burgos 1909a: XIII). Inserì nelle proprie opere di ogni genere riferimenti all’arte classica e moderna di tutta Europa, fu insegnante di elementi di storia dell’arte e tenne conferenze sui pittori spagnoli e sui maestros de la elegancia (a Buenos Aires e a Las Palmas); in ultima istanza, l’autrice aveva ben chiare le modalità di rappresentazione delle donne in pittura e il ruolo che le sovrane ritratte da Winterhalter avevano nel diffondere le mode, come evidenzia anche in alcuni dei suoi manuali pratici per donne. Carmen de Burgos aveva ben chiaro, viceversa, il ruolo della moda nelle scelte di autorappresentazione di queste donne dell’aristocrazia. Il fatto che Eugenia, ricordata per la sua chioma bionda5 che la accomuna a una delle caratteristiche di Elena più sottolineate nel corso del romanzo, venga usata come immagine parallela alla protagonista, conferisce al personaggio di Elena lo stesso potere di autodefinizione che Colombine associava alla grande imperatrice dei francesi.
Bender (2017) ha messo in luce come Elena diventi effettivamente cosciente della sua femminilità come performance: nonostante la protagonista fallisca nell’arte del teatro, è in grado di perfezionarsi e sublimare la propria arte della toeletta, che diviene il suo processo costante di autocreazione. La cura della propria immagine è parte integrante dell’identità di Elena, e il suo lavoro continuo viene descritto nel romanzo con dei sintagmi quali «fatigosa ocupación», «inmenso trabajo» (Burgos 1924a: 68), «secretos de tocador» (Burgos 1924a: 165), finché negli ultimi capitoli si arriva a sottolineare che «aquella belleza y aquella frescura eran obra suya, hijas del perseverante cuidado de toda su vida» (Burgos 1924a: 223). Se queste definizioni sottendono un tono ironico, per cui queste attività di natura frivola potrebbero non risultare effettivamente come dei lavori faticosi o delle occupazioni serie, è pur sempre vero che nella produzione generale dell’autrice, e non soltanto in questo romanzo, la cura estetica e la moda vengono esaltate nella loro perseveranza tecnica e nel loro ruolo di presentazione della donna.
La precisione e la cura con cui Carmen de Burgos si occupa di moda, cosmetica, eleganza e bellezza non sono frutto del caso, ma si legano alle conoscenze maturate dall’autrice nell’ambito di pubblicazioni attinenti a diversi generi. In un periodo di tempo che si estende dal 1904 al 1918 (pubblicazione di Arte de la elegancia), Carmen de Burgos ampliò il suo interesse di scrittrice a un genere letterario considerato poco prestigioso e fortemente plasmato sulle logiche del mercato di massa: i libri di consigli per le donne. La stessa rubrica «Lecturas para la mujer» sul quotidiano Diario Universal, d’altronde, segnò l’esordio giornalistico di Carmen de Burgos come cronista dei saperi squisitamente femminili (anche se, ben presto, i temi sociali divennero il contenuto più innovativo del contributo dell’autrice). Sebbene i manuali pratici fossero essenzialmente delle libere traduzioni di opere straniere, si registrava in questi adattamenti di Colombine una proposta audace e moderna quale quella di presentare tutte le donne come soggetti estetici. Questa potenzialità si affermava, come ha sottolineato Kirkpatrick (2003), non malgrado l’identità femminile, ma, piuttosto, proprio in virtù di questa.
Persino nei titoli più provocatori (come El arte de seducir o El arte de ser mujer), comparsi a partire dal 1909, l’impegno della donna viene sempre associato a una forma d’arte. La continua allusione all’arte trasmette l’idea secondo la quale l’identità della donna non si esaurisce nella sua natura femminile, ma si combina anche all’abilità di apprendere e gestire determinate pratiche estetiche e sociali: il ruolo della donna va ben oltre l’ideale di angelo del focolare del XIX secolo, che si limitava a mettere a frutto la sua inclinazione tipicamente femminile dell’amore materno e coniugale; le donne di Carmen de Burgos, piuttosto, sono individui complessi che devono gestire un ampio spettro di attitudini e capacità. La proposta di Burgos, in generale, pur apportando componenti innovative – quali, ad esempio, il ricollocamento dell’abilità dell’essere donna entro una serie di pratiche che possono acquisirsi tramite l’istruzione e la consapevolezza – conserva parte di un’ideologia più tradizionale: la donna che affina le proprie capacità nella presentazione di sé stessa è il soggetto creatore della sua arte, ma è anche l’oggetto, dato che assume il ruolo dell’opera che deve essere apprezzata dagli altri. Secondo l’autrice, l’eleganza non si configura come una dote, ma è una materia che in larga parte si apprende; l’istruzione e la cultura, peraltro, non possono far altro che concorrere alla riuscita del buon gusto. Le «scuole di bellezza» vengono presentate come un’innovazione estera per educare la donna a raggiungere la grazia desiderata. Imparando come presentarsi, dunque, la donna riesce a compensare una scarsa avvenenza naturale; in questo modo, si può dedurre, qualsiasi donna può divenire bella, purché impari come valorizzarsi. La donna che modella la propria immagine diviene un motore della modernizzazione economica e sociale. Infatti, la frivolezza attribuita dai moralisti alla moda non rappresenta altro che un’interpretazione erronea della necessità di rinnovarsi, non per vezzo, ma per riuscire a rispecchiare le abitudini e i sentimenti del suo tempo. Secondo i manuali di Burgos, la donna è in grado di mostrare tutte le proprie potenzialità quando si tiene al passo con una variabilità della moda che è sempre maggiore, e il merito della donna moderna risiede nel sapere accettare il cambiamento e la molteplicità.
All’ecfrasi artistica, dunque, nel romanzo si affianca un’altra tipologia di arte, alle cui tecniche si allude per tutta l’estensione del testo. La femminilità di Elena come performance – si diceva – è lo specchio di attività strutturate e complesse in cui la donna ha acquisito pratica e conoscenza. I saperi di Carmen de Burgos circa la moda, i belletti e l’eleganza, ampiamente discussi con fini più apertamente didattici nei manuali pratici, vengono nel corso del romanzo toccati in qualità di brevi riferimenti che si inseriscono quasi mimeticamente nella narrativa. Nella mujer fantástica, quindi, l’intertestualità con altre opere di Carmen de Burgos si registra anche nell’accenno a questioni più estesamente analizzate nei manuali di moda, e il linguaggio succintamente evocativo che forniva riferimenti artistici si impiega anche per prodotti e personaggi reali legati al mondo della moda di quegli anni.
Alcuni esempi per chiarire queste affermazioni sono da riscontrare, per esempio, nei riferimenti ai profumi di Coty e Houbigant6 (Burgos 1924a: 165), agli stilisti con cui interagisce Elena – Poiret ad esempio – che coincidono con figure reali della moda del XX secolo (Burgos 1924a: 119), alle tecniche per le pettinature più alla moda – la «ondulación Marcel» (Burgos 1924a: 79), dal nome del suo creatore – non senza definizioni creative dell’autrice, come «peinado radio» (Burgos 1924a: 107), a prodotti cosmetici come la Crema Divina nominata da Renée7 (Burgos 1924a: 96) o la Crema Novena che compare nelle lezioni registrate dall’Istituto di Bellezza che Elena ascolta davanti allo specchio8 (Burgos 1924a: 192). Le riflessioni formulate nel manuale El arte de ser mujer vengono brevemente riportate nel romanzo; si commentano, per esempio, i colori del vestiario che più si addicono alla capigliatura e all’incarnato delle bionde e delle brune: «es la última moda. Las rubias necesitan esos tonos fuertes que las animen. Las morenas resultan muy ordinarias con ellos. Están mejor de azul» (Burgos 1924a: 107)9. Sull’uso del blu, ulteriormente, si fa riferimento a un «kimono azul Sarah» (Burgos 1924a: 191) indossato da Elena che appare di una tonalità misteriosa se non si conosce il collegamento all’attrice Sarah Bernhardt, messo in luce da un articolo di Carmen per Elegancias10. Le nuove mode legate all’abbigliamento tradizionalmente maschile, osservate anche nella mujer moderna y sus derechos, trovano spazio nel romanzo attraverso il personaggio di Renée: «aborrezco el traje tailleur porque obliga a llevar corsé. Con el corsé todo se sale de su sitio. No hay flexibilidad» (Burgos 1924a: 151). È evidente, da questi esempi, la difficoltà odierna di discernere tra oggetti e personaggi fittizi ed entità reali degli anni Venti. L’opera, che era divisiva al suo tempo soprattutto in rapporto a nozioni di letteratura, arte e storia, a un secolo dalla sua pubblicazione accresce la difficoltà di lettura per la necessità di dare ordine all’alternanza tra realia e creazioni narrative. In questo senso, lo studio dell’opera richiede una grande minuzia ricostruttiva, e la traduzione, a maggior ragione, si complica di fronte all’obiettivo di compiere scelte precise e uniformi.
Conclusioni
Tra i romanzi pubblicati da Carmen de Burgos, di cui si contano numerose opere, La mujer fantástica si distingue come uno dei meno esplorati e approfonditi dalla critica. Nato inizialmente come una novela corta nel 1923, venne ampliato e nel 1924 assunse la forma di un vero e proprio romanzo in ventiquattro capitoli. Questa opera riflette le esigenze tipiche della letteratura di consumo, offrendo una narrazione d’intrattenimento accessibile a un ampio pubblico. Tuttavia, l’ironia sottile che attraversa il testo lascia spazio, in molti punti, a elementi che richiedono una decodifica più complessa e sofisticata, facendo emergere livelli di lettura meno immediati.
Un tema centrale del romanzo è la moda, strettamente legata all’ambientazione cosmopolita delle capitali europee dell’epoca. Il testo esplora le opportunità e i rischi associati al culto dell’apparenza: nonostante la minuziosa descrizione delle tecniche cosmetiche, degli abiti delle donne dell’alta società e della borghesia, e dell’ossessione della protagonista per la propria immagine, la narrazione è affidata a una voce onnisciente che formalizza il distanziamento attraverso l’ironia. È proprio l’ironia con cui il narratore esterno riporta certi dettagli a mettere in discussione il valore assoluto dell’eleganza, pur lasciando a quest’ultima un ruolo centrale nelle vicende. La protagonista, Elena, nel corso della storia acquisisce una crescente consapevolezza della propria bellezza, imparando a sfruttarla come strumento di autoaffermazione. La cura della propria persona diviene per lei un mezzo per ottenere l’approvazione altrui e per affermarsi nella società, ma si trasforma in un’ossessione che, al termine della narrazione, la conduce irrimediabilmente alla solitudine.
Carmen de Burgos, autrice nota per la sua profonda conoscenza dei saperi femminili, attinge a una vasta gamma di competenze maturate nel corso dei suoi viaggi e grazie all’assiduo lavoro di redazione e traduzione di manuali pratici dedicati alla moda e all’eleganza. In tali pubblicazioni, l’universo femminile è celebrato per la sua abilità nel coltivare, nei secoli, un complesso sistema di tecniche e competenze non inferiori a quelle di altri ambiti della cultura e dell’arte. Anche nella mujer fantástica l’abbigliamento e il trucco assumono una funzione chiave, rappresentando punti di osservazione privilegiati per cogliere le trasformazioni sociali e culturali degli anni Venti. L’importanza della moda come strumento di emancipazione femminile, non a caso, sarebbe stata ripresa dall’autrice nel 1927, con uno specifico capitolo (il XII) dedicato all’argomento tra le pagine del trattato La mujer moderna y sus derechos.
Il romanzo risulta inoltre interessante per la sua intertestualità con i diari di viaggio scritti da Burgos sotto lo pseudonimo di Colombine. Questi diari costituiscono una fonte preziosa di descrizioni dettagliate di paesaggi, persone e costumi che l’autrice ebbe modo di conoscere personalmente durante i suoi spostamenti. Grazie a questa esperienza diretta, Burgos fu in grado di rappresentare in modo vivido e accurato la società parigina e la borghesia ginevrina, offrendoci un’immagine fedele della frenesia e del dinamismo delle grandi metropoli europee, in linea con le correnti artistiche e letterarie del primo Novecento. Questo fervore per la modernità tipico delle avanguardie viene rielaborato nel romanzo e viene equilibrato dalla fedeltà dell’autrice al proprio stile personale e alle esigenze della narrativa di consumo.
Sebbene La mujer fantástica presenti implicazioni sociali e politiche meno esplicite rispetto ad altre opere di Burgos, più focalizzate sulla condizione femminile, resta un contributo significativo alla produzione letteraria della scrittrice. Il romanzo mette in luce la rete di connessioni tra i diversi generi esplorati da Colombine: dalla rielaborazione delle tecniche contenute nei manuali, alla trasposizione narrativa delle sue esperienze di viaggio, fino all’adozione di elementi avanguardistici nella letteratura popolare. L’auspicio per il futuro, nell’ottica di uno studio esaustivo della produzione di un’autrice tanto prolifica, è che opere come La mujer fantástica suscitino l’attenzione della critica e divengano oggetto di approfondimento. Proprio in virtù della sua complessità, la disamina di quest’opera rivela vari punti di difficoltà: proporre oggi un’edizione critica significa ricostruire l’intreccio tra personaggi fittizi e figure reali dell’epoca, tra opere d’arte autentiche e creazioni immaginarie, tra paesaggi concreti e luoghi inventati, tra le mode del tempo e gli artifici della finzione letteraria. La traduzione della mujer fantástica rappresenterebbe una sfida ulteriore: il tentativo di trasmettere a un pubblico contemporaneo un testo dalla natura ibrida, in cui ironia ed erudizione si intrecciano. Un lettore moderno potrebbe avere difficoltà a cogliere appieno i riferimenti ai realia degli anni Venti, ma lo studio di quest’opera, così come di altre produzioni di Carmen de Burgos, permette di ampliare la comprensione delle sue ambizioni intellettuali e del suo ruolo come cronista della condizione femminile. Burgos affrontò con notevole profondità temi come la moda, la condizione giuridica delle donne e la loro emancipazione attraverso l’eleganza. Vista l’autorevolezza degli studi sistematici che hanno ricomposto la biografia di Carmen de Burgos e che stanno restituendo analisi approfondite delle tematiche sociali care all’autrice, l’auspicio è che in futuro l’attenzione critica si estenda allo studio esaustivo dell’intero corpus delle sue opere.
Bibliografia
Testi primari
Burgos, Carmen de (2001), «Misión social de la mujer», In: Sociedad el Sitio (ed.), La Tribuna de “El Sitio”. 125 años de expresión libre en Bilbao (1875-2000), p. 187-201.
― (1934), ¿Quiere usted conocer los secretos del tocador?, Barcelona, Sopena.
― (1931a), Puñal de claveles, «La Novela de Hoy», 495, X.
― (1931b), Quiero vivir mi vida, Madrid, Biblioteca Nueva.
― (1930), ¡…La piscina, la piscina!, «La Novela de Hoy», 417, IX.
― (1927), La mujer moderna y sus derechos, Valencia, Sempere.
― (1924a), La mujer fantástica, Valencia, Sempere.
― (1924b), Hasta renacer, «La Novela Corta», 422, IX.
― (1923a, marzo 10), La amiga y el gato de Barbey d’Aurevilly, «La Esfera», 479, X.
― (1923b, febbraio), Azul Sarah, «Elegancias», 2, 1.
― (1923c), La mujer fantástica, «La Novela Corta», 398, VIII.
― (1921), El artículo 438, «La Novela Semanal», 15, I.
― (1918), Arte de la elegancia, Valencia, Sempere.
― (1917), Mis viajes por Europa (Tomo primero), Madrid, Sanz Calleja.
― (1916a [s.a.]), Confidencias de artistas, Madrid, Sociedad Española de Librería.
― (1916b), El arte de ser mujer, Madrid, Sociedad Española de Librería.
― (1912), Influencias recíprocas entre la mujer y la literatura, Logroño, Imprenta y librería de “La Rioja”.
― (1910), Las mujeres y la Literatura, «Prometeo», 18, III, p. 366-370.
― (1909a), Al balcón, Valencia, Sempere.
― (1909b [s.a.]), Los inadaptados, Valencia, Sempere.
― (1909c), Auto-biografía, «Prometeo», 10, II, p. 40-46.
― (1907, maggio 29), Conferencia de “Colombine”, «El Pueblo», 5.465, XV.
― (1906a), Por Europa, Barcelona, Maucci.
― (1906b), La mujer en España, Valencia, Sempere.
― (1904), El divorcio en España, Madrid, Romero.
― (1900), Ensayos Literarios, Almería.
Testi secondari
Abellán, José Luis (2010), Carmen de Burgos y el divorcio en España, «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXVI (junio extra), p. 55-57.
Arbona Abascal, Guadalupe (2010), Los cuentos de Carmen de Burgos publicados en La Esfera. Ilustración Mundial (1914-1930), «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXVI (junio extra), p. 85-93.
Armas, Frederick de (2005), Ekphrasis in the Age of Cervantes, Cranbury, Bucknell University Press.
Bender, Rebecca M. (2017), «Fashion, Ekphrasis, and the Avant-Garde Novel: Carmen de Burgos’s La mujer Fantástica (1924)», In: Ciberletras, consultato il 15/01/24, URL: <https://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v39/bender.html>.
Burgos, Carmen de (2018), «La donna moderna e i suoi diritti», In: Carpi E. & Pano Alamán A. (a cura di), Genere, soggettività, diritti 4, Pisa. Pisa University Press.
Burgos, Carmen de; González Fiol, Enrique (1922, giugno 24), Domadores del éxito, «La Esfera», 442, 1.
Cabanillas Casafranca, África (2006), Carmen de Burgos “Colombine”, crítica feminista de arte, «Espacio, Tiempo y Forma», Serie VII, p. 385-406.
Cansinos-Assens, Rafael (1982a), La novela de un literato (Vol. 1), Madrid, Alianza Tres.
Cibreiro, Estrella (2005), De “ángel del hogar” a “mujer moderna”: las tensiones filosóficas y textuales en el sujeto femenino de Carmen de Burgos, «Letras Femeninas», 31, 2, p. 49-74.
Díaz Marcos, Ana María (2012), ¿Esclavas del figurín?: moda, educación y emancipación en la obra de Concepción Arenal, Rosario de Acuña y Carmen de Burgos, Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
Espino Bravo, Chita (2017), Emilia Pardo Bazán y Carmen de Burgos, Resistencia al matrimonio desde la novela de la Restauración, Saragozza, Prensa de la Universidad de Zaragoza.
Establier Pérez, Helena (2000), Mujer y Feminismo en la narrativa de Carmen de Burgos “Colombine”, Almería, Instituto de Estudios Almerienses.
Florek, Olivia G. (2023), The Celebrity Monarch, Newark, University of Delaware Press.
Hernando, Bernardino M. (2010), Carmen de Burgos, la APM y aquellas admirables chicas del 98, «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXVI (junio extra), p. 37-41.
Huyssen, Andreas (1986), After the Great Divide, Bloomington, Indiana University Press.
Johnson, Roberta (2001), Carmen de Burgos and Spanish Modernism, «South Central Review», 18, 1/2, p. 66-77.
Kirkpatrick, Susan (2003), Mujer, modernismo y vanguardia en España (1898-1931), Cruz J. (trad.), Madrid, Cátedra – Universidad de Valencia.
Krauel, Ricardo (2003), Hacia una redefinición de la sensualidad femenina en la modernidad: La mujer fría de Carmen de Burgos, «BHS», 80, 1, p. 525-536.
Lerner, Gerda (1993), The Creation of Feminist Consciousness, New York, Oxford, Oxford University Press.
Louis, Anja (2018), La identidad feminista en la obra de Carmen de Burgos, «Estudios Románicos», 27, 1, p. 33-48.
― (2005a), Women and the Law: Carmen de Burgos, an Early Feminist, Woodbridge, Tamesis.
― (2005b), Inferior, Superior or Just Different? A Woman’s Sense of Justice in Carmen de Burgos’s El abogado, «Hispanic Research Journal», 6, 1, p. 13-27.
― (2004), Whose Melodrama is it Anyway? Women and the Law in the Work of Carmen de Burgos, «Bulletin of Spanish Studies», LXXXI,6, p. 765-783.
Marinetti, Filippo Tommaso (1910), Proclama futurista a los españoles, «Prometeo», 20, III, p. 517-531.
Nead, Lynda (2013), The Layering of Pleasure: Women, Fashionable Dress and Visual Culture in the mid-Nineteenth Century, «Nineteenth-Century Contexts», 35,5, p. 489 509.
Núñez Rey, Concepción (2018), El ensayismo de Carmen de Burgos, Colombine, en defensa de la igualdad de la mujer, «Estudios Románicos», 27, 1, p. 61-74.
― (2010), Espacios y viajes en la vida y en la obra de Carmen de Burgos Colombine, «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXVI (junio extra), p. 5-19.
― (2006), La narrativa de Carmen de Burgos, Colombine. El universo humano y los lenguajes, «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXII, 719, p. 347-361.
― (2005), Carmen de Burgos Colombine en la Edad de Plata de la literatura española, Siviglia, Fundación José Manuel Lara.
Ortega y Gasset, José (2017), La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Barcelona, Austral.
Paredes Méndez, Francisca (2009), Elisa se ha comprado zapatos de tacón: moda, género y clase social en La flor de la playa de Carmen de Burgos, «Anales de la literatura española contemporánea», 34, 1, p. 203-228.
Sánchez Álvarez-Insúa, Alberto (2010), Carmen de Burgos y las colecciones de novela corta, «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXVI (junio extra), p. 65-70.
Simón Palmer, María del Carmen (2010), Carmen de Burgos, Traductora, «ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura», CLXXXVI (junio extra), p. 157-168.
― (1991), Escritoras españolas del siglo XIX, Madrid, Castalia
Utrera, Federico (1998), Memorias de Colombine, la primera periodista, Majadahonda, HMR.
Note
- «A mi juicio, lo característico del arte nuevo, “desde el punto de vista sociológico”, es que divide al público en estas dos clases de hombres: los que lo entienden y los que no lo entienden» (Ortega y Gasset 2017: 54).
- Si tratta, con ogni probabilità, del dipinto L’isola dei morti, di cui Colombine aveva già parlato in Mis viajes por Europa nel cap. VIII: «Son paisajes reales, paisajes que ofrecen las orillas del río y de los lagos en esta tierra privilegiada; paisajes con los que he familiarizado los ojos en estos días; pero Bócklin ha visto más que el paisaje, ha visto el ensueño que inspira y lo ha traducido en el misterio de las figuras que cruzan la barca hacia la quietud inefable de su isla de los Muertos» (Burgos 1917: 64). Il pittore simbolista aveva dipinto cinque versioni del quadro; la prima, del 1880, è tutt’oggi conservata a Basilea. Elena nel romanzo dice «Boeklin debió pintar aquí ese cuadro que hemos admirado en Basilea. Es el pintor del Rhin» (Burgos 1924a: 46).
- «El traje de boda de la emperatriz Eugenia: Era de cola de terciopelo blanco rizado, cuerpo alto con pedrería y falda cubierta de punto de Inglaterra. Peinado en bandas por delante y levantado de un lado y del otro cayendo sobre el cuello en pequeños bucles; aparece el matiz teba, amarillo, tirando á marrón, que tenía la preferencia de la soberana. En 1855, para ocultar su embarazo, aparecen la crinolina, los volantes y los chales» (Burgos 1916b: 98).
- Florek (2023) include anche delle immagini di questi album, dove venivano combinate illustrazioni, foto, riproduzioni di quadri.
- «La reina Elisabeth, las Médicis, Catalina y María, Ana de Austria, […] y la emperatriz Eugenia, por no citar más, unían a sus encantos el de los rubios cabellos» (Burgos 1934: 180).
- Vengono riportati i nomi reali di profumi anche di altre marche, come Guerlain e Lydès, nella loro traduzione spagnola. Tra questi si riconoscono certamente i profumi di Guerlain Au Bon Vieux Temps, L’Heure Bleue, il profumo di Coty La Rose Jacqueminot; oltre a La Rose France di Houbigant e L’Ambré des Pagodes di Lydès.
- Una “ricetta” per la Crema Divina viene proposta in un manuale da Colombine stessa (Burgos 1934: 279). Questo prodotto compare anche in riviste dell’epoca come El Eco de la Moda: «use la Crema Divina, que se vende en las buenas perfumerías» («Secretaria» 19-3-1899: 95). La rivista era un’edizione spagnola della petite écho de la mode di Parigi.
- Si tratta di una linea cosmetica firmata da Helena Rubinstein, che sotto il nome di Novena riunì un set di detergenti, astringenti e creme già a partire dai primi anni del XX secolo. Rubinstein creò anche delle tecnologie per l’elettrolisi depilatoria, di cui si parla nel romanzo nel capitolo XVI.
- Questo argomento viene analizzato in più sezioni del arte de ser mujer, dove vengono addirittura elencati i colori più adeguati secondo il colore dei capelli. Sul blu, specificamente, si dice: «El azul es un color dulce y plácido que corresponde á las gentes irritables y nerviosas, pues les inspira sentimientos tiernos y afectuosos. Se cree que conviene á las rubias, pero no les está bien, á no tener el cutis muy rosado. Sienta mejor con los cabellos negros y el color vivo de las morenas» (Burgos 1916b: 134).
- Nell’articolo, intitolato proprio «Azul Sarah», si legge: «Ahora una gran artista viene á aumentar y renovar la gama del favorecido color. Sarah Bernhard, la eterna Sarah, que parece desecada y galvanizada para continuar una vida sin fin, lanza un nuevo azul, blando, delicado, que usa en todo lo que le pertenece» (Burgos 1923b: 71).