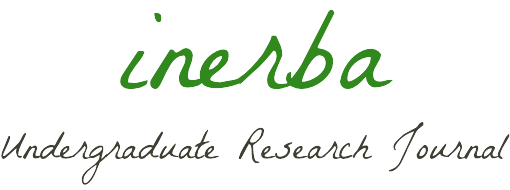C’era stato un periodo, disse Nadia, prima di noi, prima del dottorato, prima di tutto, in cui aveva voluto morire. Disse proprio così, disse che non vedeva l’ora di mettere fine a questa vita del cazzo che era insufficiente e miserevole e a ogni occasione era buona solo ad aumentare il voltaggio della sofferenza, le uniche scosse erano dolore, dolore, dolore. Ma poi basta, mi sono svegliata una mattina ed era passato tutto, ho capito che il mio compito era assorbirmi nelle mie cose, stordirmi di qualche piacere, anche se gramo, non scavare sotto la superficie per scoprire che un sotto non esiste.
La ascoltai a disagio, come spesso accadeva ultimamente, e forse anche un po’ indispettita perché, se mi aveva parlato di brutti periodi trascorsi prima che ci conoscessimo, certo non si era mai attribuita il desiderio di morire con le parole di adesso, parole che tra l’altro ornava di «lo sai», «te l’ho detto». No, avrei voluto ribatterle, non lo so, non me l’hai detto, ma non lo feci, temetti per un attimo che avesse ragione lei, che avesse creduto già da tempo di avermi affidato una confidenza di rilievo e che io l’avessi mandata allegramente al macero in qualche parte di me, dove tutto s’annerisce, anche lei. Non attribuì alla nostra relazione, comunque, alcun potere salutifero, neanche per finta, per farmi contenta – non ci pensò nemmeno e che si scordasse di compiacermi, o almeno non cercasse di farlo, in quell’occasione mi rasserenò, ne traevo la conferma che era sincera. Ma non sapevo più che cosa fosse la sincerità, dov’era l’artificio che essa di necessità implicava, se in quel «te l’ho detto» che aveva il retrogusto del falso ma consistenza inspiegabilmente vera, smarrivo i significati di ciò che mi diceva prima ancora che essi potessero raggiungermi. Soccombevo all’evidenza, insomma, che Nadia non fosse Nadia e non lo fosse mai stata, era una mia coetanea trentasettenne che conoscevo poco.
Forse la bugia era quel «ma poi basta», era la sua capacità titanica di reagire alle cose, di uscirne indenne e gloriosa. Di vivere insomma, la sua capacità intrinseca di vivere che bastava l’ammissione di qualche debolezza, o che io stessa ne scoprissi una crepa, per riconfermarsi con potenza aumentata. Forse, sì, era quella la bugia, era ora che smettessi di crederci; ma proprio nel momento della mia abiura, ecco che lei tornava a sfolgorare, e io volentieri mi riconsegnavo ai ceppi. No, nessuna menzogna, nessun segno d’inattendibilità che, sconfermando la realtà, diminuisse l’artificio. Nella mia testa il bianco, l’interferenza di un aereo sopra le case mi fece temere di perdere anche la fisicità delle parole, non solo la loro colata teoretica; e l’unica cosa che, in quel momento, riuscissi a percepire, l’unica cosa che poteva delinearmisi in maniera precisa, era un dolore mio di adesso forse simile a quello che era stato suo (da quanto aveva detto) di anni e anni prima; eppure la mia incapacità – perché quello era – di risolverlo, e la mia abilità inutile a perdurare nell’esistenza sperando che passi, con in faccia la prova schiacciante della mia inadeguatezza, senza neppure un attimo pensare di risolverla, provare in qualche modo a star meglio.
Sotto i portici dove ci trovavamo faceva già buio, mentre il resto dei palazzi si arrossava ancora sotto l’incendio del tramonto. La luce non raggiungeva neppure la sua bella faccia, che al buio dovevo indovinare. Ma mentre nel mondo attorno erano appena le sette, lì sotto era scoccata mezzanotte e io di lei non vedevo niente, tutto sprofondava in un fondo scuro dal quale era difficile ora risalire insieme. Per me, in quel momento, non c’era alcun insieme: faticavo già a tirare una gamba avanti all’altra, mentre lei dettava un’andatura sostenuta che mi sfiancava, e io dovevo stare attentissima a non sgusciare, non rimanere sganciata dal suo corpo a fluttuare in quell’oscuro nulla, finirne risucchiata come dallo scarico dell’universo. Figuriamoci se avevo le forze perché qualcosa si mantenesse aggregato a qualcos’altro, se avevo le forze per mettere in ponte un insieme. Lei non so, più di me di sicuro; quel discorso forse l’aveva rivitalizzata, mi fermò di fronte alla vetrina di una pizzeria a taglio e mi disse: ho fame, mangiamo qualcosa insieme?
Sì. Ordinammo due spicchi per uno e un etto di farinata che mangiammo sedute su uno scalino, Nadia all’ultimo aveva preso una birra col limone che ora mi offriva da smezzare. Ci eravamo tolte dai portici, era tornata la clemenza di un po’ di luce, gli ultimi raggi, anche se scaldava poco. Forse anch’io avevo fame, pensavo, forse quando mi sento più avvilita e in odio a me stessa non è altro che lo stimolo corporeo ad ingurgitare nutrimento. Non ho bisogno di niente, solo di grassi e carboidrati. E anche Nadia se ne stava in silenzio, pensava a qualcosa che io di sicuro non conoscevo, qualcosa che somigliava a qualcos’altro e qualcos’altro ancora ma aveva l’aspetto informe, mobile, senza complimenti del grasso strutto, dei salumi fritti. Forse anche lei s’interrogava senza sbocchi su che cosa pensassi io, forse desiderava parlarmi ma non adesso, magari poi. O forse io ero lontana da lei come lei da me era lontana, di nuovo lontana. Il mio pensiero tornato finalmente all’unico punto in cui sa stare, a sé stesso. E io ancora seguitavo a ruminare, ma con meno convinzione, in quel dolore di prima.
Fare come lei, che in un attimo si era dimenticata di voler morire, e pareva riuscire a vivere con un’intensità che mi spaventava. Per rivedere la luce sotto i portici avremmo dovuto aspettare la mattina. Tutto è blu la mattina, uguale al resto, tutto perde i propri connotati dentro il sole celeste-argento che lo inghiotte. Essere lei, diventare lei una mattina d’argento sotto i portici dove abbiamo camminato tutta la notte. Guadagnare finalmente il suo passo, tornare a vederla. Se avessimo passato tutta la notte fuori, forse, se avessimo provato di nuovo a fonderci l’una nell’altra, se avesse voluto lei anche con violenza spingermi dentro, trasformarmi, allora l’avrei assecondata, non mi sarei opposta al suo fare. Ma la luce è ladra, questa città ci ingabbia sotto i suoi portici-prigione e io sono troppo stanca per superare sveglia la notte.
Non parlammo più di nulla. Sbirciammo qualche cappotto dalle serrande abbassate dei negozi che chiudevano presto, a quelli ancora aperti non ci facemmo caso. Avevo ancora in testa le parole di Nadia, anche se ora a stomaco pieno le digerivo meglio, e le sentivo come una febbriciattola leggera che mi era rimasta nelle ossa ma era innocua. Tempo addietro, quando fingevo di volermi annegare nella vasca per farla venire a tirarmi su, m’inventavo che era questione di vita o di morte, ne ero pure convinta. Ma in fondo se non fosse venuta sarebbe stato lo stesso. Ogni mio pensiero, ogni mio gesto, brutto o bello, dovevo recitarlo per crederci davvero. La verità è il riflesso nello specchio, è la finzione a risoluzione aumentata. Devo stare al di sotto della tensione superficiale, dove la realtà sopra è nient’altro che la melma ondosa dell’acqua. Mantenersi giù, non avere neppure un attimo per emergere. Guardare sempre dal basso, per non impazzire.
Quando il sole è tramontato ed è buio, le colonne dei portici spariscono e con loro i soffitti bassi, le arcate a tutto sesto. E questa strada stretta e larga che taglia in due la città, che curvando percorre dalla porta al fiume, dal fiume alla stazione, cancella le sue forme regolari e irregolari, non esiste. Tutta la città non esiste. Il centro si spiana, si scioglie in migliaia di chilometri quadrati di periferia. E poi sconfina nel mare anch’esso nero, nero come l’umidità che impregna tutto, anche i capelli e i vestiti.