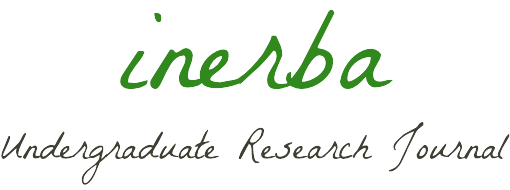Il presente contributo nasce dall’indagine che l’autrice ha svolto in sede di tesi magistrale sui paralleli isidoriani presenti in una dozzina di trattati grammaticali proto- e precarolingi riferibili ad ambienti insulari oltremanica e sul continente.
L’Ars Bernensis: questioni di collocazione cronologica e geografica
Tra le artes grammaticae compilate in ambito insulare tra la fine del VII e gli inizi del IX secolo, un posto di rilievo è sicuramente occupato dall’Ars Bernensis (d’ora in avanti Bern.)1. Fino alla fine del secolo scorso il testo era considerato trasmesso da un codex unicus, ossia Bern, Burgerbibliothek, MS 123, ff. 78v-117r, scritto a Fleury nella prima metà del IX secolo, codice che Hagen utilizzò per l’edizione del testo, pubblicata nel supplemento ai sette volumi dei Grammatici Latini curati da Keil (Hagen 1870: 62-142). Un nuovo testimone della grammatica è stato scoperto da Holtz nel manoscritto Barcelona, Arxiu de la Corona d’Aragó, Ripoll 46, ff. 57r-57v; 58v-61v (Catalogna, X secolo): esso consiste in un estratto di Bern. che si presenta sotto forma di un commento continuo a margine dei capitoli de nomine e de pronomine dell’Ars maior di Donato2. Holtz ritiene che il codice rivipullense non sia stato copiato dal bernese, in quanto esso presenta un testo molto più completo e corretto, tant’è che è stato possibile usarlo per sanare passi che nel manoscritto di Berna presentano errori grossolani o aplografie (Holtz 1992: 11).
Per quanto riguarda la datazione dell’Ars, l’unico dato certo è il terminus ante quem all’inizio del IX secolo stabilito dal codice bernese. Da un’indagine sulle fonti e sui paralleli che troviamo nel testo, risultano numerose le citazioni, alle volte nominatim, di Virgilio Marone grammatico, la cui attività si colloca intorno alla metà del VII secolo3. Passalacqua (2005: 516) ricorda l’uso da parte del compilatore dell’Institutio de nomine et pronomine et verbo di Prisciano, le cui prime attestazioni risalgono all’VIII secolo. Holtz (1995: 119) propone di collocare la composizione dell’Ars Bernensis nella seconda metà o alla fine dell’VIII secolo, data «l’utilisation massive des Institutions Grammaticales»4. Secondo O’ Rorke (2020: 82-83), il termine post quem può essere individuato nella seconda metà del VII secolo, in quanto il compilatore di Bern.avrebbe usato un antico manuale irlandese oggi perduto risalente a quell’epoca, le cui tracce sarebbero reperibili anche nell’Ars Ambrosiana e nell’Anonymus ad Cuimnanum.
Per quanto riguarda la collocazione geografica dell’origine di Bern., sono state molte le posizioni degli studiosi al riguardo. Löfstedt (1965: 20) riteneva che, data la somiglianza tra Bern. e i manuali di Malsachanus e Clemente Scoto, la sua origine fosse da ricercarsi in un milieu irlandese. Tale ipotesi è stata ridimensionata da Law (1982: 74), la quale riconduceva questa vicinanza all’uso di una fonte comune e suggeriva che, per via di elementi interni al testo, l’origine del trattato potesse essere collocata in un centro anglosassone sul continente.
Un’ipotesi diversa è quella avanzata da Holtz (1995: 120-126), che analizza il materiale bibliografico impiegato in Bern. per cercare di localizzare con maggiore sicurezza lo scriptorium in cui il testo fu compilato. Come accennavamo, nel trattato troviamo paralleli con le opere di Prisciano (per cui vd. anche Biondi 2022: 60-63) e di Virgilio Marone grammatico, con l’Ars Maior di Donato, i manuali di Consenzio, di Eutiche e dello ps. Cassiodoro, con le Etymologiae di Isidoro e i capitoli del I libro della grammatica di Sacerdote, ormai perduti; sono anche molte le citazioni da autori classici e cristiani. Jeudy (1972: 116) ha segnalato tra i testi utilizzati dall’artigrafo anche la raccolta anonima di Declinationes nominum trasmessa dal manoscritto Orléans, Bibliothèque municipale, 297, p. 120-129. Sono poi numerosi i punti di contatto con le Artes attribuite a Clemente Scoto e al cosiddetto Donatus Ortigraphus (DO), ma è probabile che in questo caso la fonte comune sia una versione più completa dell’Ars Bernensis stessa (Chittenden 1982: XXI; XXXIV)5.
Nel suo studio Holtz si sofferma in particolare sulla grammatica di Sacerdote, trasmessa da un codex unicus (Napoli, Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III, ex Vind. lat. 2) risalente al VII-VIII secolo e mancante dei quaternioni iniziali (vd. anche De Paolis 2022: 330 n. 39). Analizzando le cinque citazioni che in Bern. sono attribuite a Sacerdote, Holtz conclude che l’artigrafo non guardava a una versione migliore del libro II della grammatica di Sacerdote (a noi pervenuto) come riteneva Hagen (1870: LXXXVII), ma aveva a disposizione il I libro, che andò perduto alla fine del XV secolo, quando fu scoperto il manoscritto (Holtz 1995: 122-124)6. Considerata la grande quantità di citazioni da diversi autori e testi e il fatto che la loro modalità d’impiego parrebbe indicare una fruizione avvenuta di prima mano e non tramite compilazioni come i florilegi, Holtz propende per collocare l’origine di Bern. a Bobbio, che, con il suo scriptorium ben fornito e con i suoi interessi grammaticali, pare essere un contesto appropriato alla redazione dell’opera (Holtz 1995: 124-126). Tale ipotesi è accettata e condivisa ancora oggi (Biondi 2022: 106-110) e su di essa si basa il presente contributo.
Bobbio e le Etymologiae di Isidoro di Siviglia
In queste pagine intendiamo focalizzarci su un’altra fonte utilizzata dal compilatore dell’Ars Bernensis: le Etymologiae di Isidoro di Siviglia7. Nella tradizione manoscritta dell’opera isidoriana, che ebbe una vastissima diffusione sin dalla prima metà del VII secolo, abitualmente si accetta la suddivisione suggerita da Lindsay in tre famiglie, α β γ, rispettivamente dette anche franca, italiana e spagnola8. Sappiamo che a Bobbio fu sicuramente scritto il cod. A delle Etym., riconducibile alla famiglia α, ma molto vicino in alcune sue lezioni a due codici di β, segnatamente K e L9.
Per lungo tempo si è pensato che K e L fossero di produzione bobbiese, ma studi più recenti hanno dimostrato che la loro compilazione è da collocarsi con ogni verosimiglianza in un altro centro dell’Italia settentrionale10. Prendendo in considerazione la pergamena di VI secolo contenente il De alimentorum facultatibus di Galeno, i cui fogli sono stati utilizzati, dopo essere stati opportunamente raschiati e riscritti, nella confezione di K e di L, si è dimostrato (vd. ad es. Zironi 2004: 53-56) che questi provenivano con estrema probabilità da Ravenna, unica città nell’Italia del VI secolo dove l’opera di Galeno in lingua originale sarebbe stata di qualche interesse. Inoltre, Ravenna risulta avere forti legami con Verona, centro che a partire dal VI secolo si caratterizza per la massiccia produzione di codici palinsesti formati da fogli di manoscritti tardoantichi, per alcuni dei quali è praticamente certa l’origine ravennate (Bassetti 2018: 23-26). A ciò si aggiunga che Zironi (2004: 56; ma vd. anche De Paolis 2022: 318 n.17; 339-340 sulla provenienza dei manoscritti di Bobbio) afferma che la maggior parte dei codici bobbiesi contenenti opere isidoriane presentano un legame con Verona. Risulta dunque legittima l’ipotesi di una sorta di linea di trasmissione culturale che da Ravenna passa per Verona, fino ad arrivare a Bobbio, come suggerisce ancora Zironi (2004: 56). Ma al di là della provenienza, appare provato almeno per L un arrivo a Bobbio solo in un secondo tempo: nel margine inferiore del f. 3r si trova infatti una nota datata alla prima metà del IX secolo che recita: «Obtulit hunc librum Boniprandus mente libenti / Columbae eximio patri […]»11.
Le Etymologiae nell’Ars Bernensis: un’analisi dei passi significativi
L’Ars Bernensis presenta quattordici brani tratti dalle Etymologiae, soprattutto dai capitoli 6-7 del I libro, a parte un unico brano da Etym. 11, 1, 2 (i paralleli considerati sono quelli segnalati da Hagen 1870 e da Holtz 1992)12. Ho collazionato tutti questi luoghi in manoscritti delle famiglie α e β con il fine di cercare la presenza di accordi significativi tra il trattato e i testimoni di uno dei due rami di tradizione13. Di questi quattordici brani, solo cinque sono utili ai fini della nostra trattazione: nei restanti nove non si notano punti in cui Bern. sia in accordo in errori realmente significativi con uno o più codici o eviti lezioni di una famiglia in particolare e, per questo, non sono stati presi in considerazione nell’esposizione. Per la discussione dei passi ci avvarremo di tabelle nella cui prima colonna è riportato il testo di Bern., nella seconda quello delle Etymologiae nell’ed. Spevak 2020 e, a seguire, il testo riportato dai manoscritti di β che presentano lezioni proprie di quella famiglia (segnatamente KLt Par.Lat.7530 Vat.Lat.5873) e da A, appartenente alla famiglia α e sicuramente compilato a Bobbio14.
Tabella 1
| Bern. 64, 6-7 Sed etiam nomen definitur: “nomen dictum est, quasi notamen, eo quod nobis vocabulo suo res notas efficiat”. efficiat Hag.] efficiet | Etym. 1, 7, 1 Nomen dictum quasi notamen, quod nobis vocabulo suo res notas efficiat. dictum : dictum est AC2K : dicte C1 | efficiat : faciat K1 | K Nomen dictum est quasi notamen quod nobis vocabolo suo faciat faciat] efficiat K2 | L Nomen dictum est quasi notamen quod nobis vocabulo suo res notas faciat |
| Par.Lat.7530 Nomen dictum est quasi notamen quod nobis vocabulo suo res notas faciat | Vat.Lat.5873 Nomen dictum quasi notamen quod nobis vocabulo suo res notas faciat | A Nomen dictum est quasi notamen quod nobis vocabulo suo res notas efficiat |
Il brano di Etym. 1, 7, 1 nei manoscritti più antichi della famiglia β presenta la lezione faciat laddove il resto della tradizione riporta efficiat (vd. Tabella 1). Il testo di t non è leggibile, in quanto è andata perduta la porzione di foglio in cui continuava la frase dopo notamen. Per quanto invece riguarda la famiglia α, nessuno dei codici collazionati riporta la lezione faciat. L’esclusività della presenza di faciat in testimoni della famiglia β porta a considerare che tale lezione sia propria di quel ramo specifico, come parrebbe suggerire anche la correzione adoperata da K2, in quanto essa non sarebbe stata necessaria se la lezione di partenza non fosse stata percepita come errata. Risulta dunque rilevante il fatto che Bern. riporti efficiet, che, per quanto errato, è molto più vicino a efficiat che al faciat trasmesso dai testimoni di VIII sec. di β.
Tabella 2
| Bern. 67, 2-4 Isidorus ostendit, cum dicit: “Appellativa nomina inde vocantur, quod communia sunt et in multorum significatione consistunt”. | Etym. 1, 7, 3 Appellativa nomina inde vocantur, quia communia sunt et in multorum significatione consistunt. quia : quod K1 | sunt : sint K1 | K appellativa nomina inde vocantur quod communia sint et in multorum significatione consistunt quod] quia K2 | sint] sunt K2 | t appellativa nomina inde vocantur quod communia sint et in multorum significatione consistunt |
| L appellativa nomina inde vocantur quia communia sunt et in multorum significatione consistunt | Par.Lat.7530 appellativa nomina inde vocantur quod communia sint et in multorum significatione consistunt | A appellativa nomina inde vocantur quia communia sunt et in multorum signification consistunt |
Nella citazione isidoriana di Bern. leggiamo quod communia sunt, dove la maggior parte dei testimoni isidoriani trasmette quia communia sunt (vd. Tabella 2). Dalle collazioni è emerso che tra i testimoni di β, K1t e Par.Lat.7530 concordano nel riportare quod communia sint; L, invece, così come A e il resto della tradizione, presenta quia communia sunt. Spicca il fatto che Bern. concordi per il quod con i più antichi codici di β, ma allo stesso tempo eviti la lezione sint che quelli trasmettono quasi unanimemente, eccezion fatta per L, che non ha nemmeno quod, ma quia. Ad ogni modo, queste sono oscillazioni minime e soggette a ripetersi poligeneticamente in qualsiasi tradizione.
Tabella 3
| ***Bern. 82, 5-8 Genera dicta sunt, quod generant vel generantur, ut masculinum et femininum. Cetera nomina non sunt genera, sed hoc nominum ratio et auctoritas voluit. quod Hagen : eo quod R : que B | generant BR Hagen : generent Isid. | vel B Hagen : et R | vel generantur BR Hagen : om. Isid. cuius codices alii generent, alii generentur tantum habent | Etym. 1, 7, 28 Genera dicta sunt quod generent, ut masculinum et femininum. Cetera non sunt genera, sed hoc nominum ratio et auctoritas voluit. Generent : generant XK2 : generantur AK1 | ante cetera leg. nomina A | cetera non TUWX Par.Lat. : cetera nomina non ABC Linds. : cetera nomina KL | non sunt … voluit non hab. K1L1 | ratio om. I | et : ut C1 | voluit : instituit Par.Lat. | K genera dicta sunt quod generantur ut masculinum et femininum cetera nomina generantur] generant K2p.c. | post nomina add. non sunt genera sed hoc nominum ratio et auctoritas voluit K2 : spatium vacuum hab. K | t genera dicta sunt quod generantur ut masculinum et femininum cetera nomina |
| L genera dicta sunt quod generent ut masculinum et femeninum cetera nomina post nomina add. non sunt genera sed hoc nominum ratio et auctoritas voluit L2 | Par.Lat.7530 genera dicta sunt quos generantur ut masculinum et femininum cetera non sunt genera sed haec nominum ratio et auctoritas instituit | A genera dicta sunt quod generantur ut masculinum et femininum nam cetera nomina non sunt genera sed hoc omnium ratio et auctoritas voluit |
Considerando il brano di Bern. possiamo anzitutto notare come il trattato riporti generant vel generantur. Alla luce delle collazioni svolte (vd. Tabella 3), possiamo confermare che in nessuno dei testimoni isidoriani è presente una lezione di questo tipo e anche dall’edizione digitale delle glosse a Etym. I reperibile sul sito Innovating Knowledge (vd. sopra n. 13) non risultano annotazioni su generent volte a presentare una lezione alternativa. Per quanto riguarda i verbi (generant/generantur laddove troviamo generent in Isidoro), vediamo che K1 e t concordano nel riportare generantur, lezione che troviamo anche nel Par.Lat.7530 e in A, mentre il generant di K2 è condiviso anche da dFnq, appartenenti alla famiglia α. La presenza di generant vel generantur in Bern. potrebbe forse essere indicativa del fatto che il modello da cui il compilatore trasse il materiale aveva un’annotazione in cui era segnalata la variante generantur; non va nemmeno escluso che il compilatore avesse accesso al testo isidoriano grazie a più tramiti e che, trovando (vel) generantur, abbia deciso di annotare la variante. Rimane comunque il fatto che in Bern. troviamo delle forme all’indicativo presente come in Kt Par.Lat.7530 AdFnq e non al congiuntivo presente come in L e nel resto della tradizione. Per quanto si possano trovare qui dei contatti tra Bern. e alcuni dei più antichi testimoni di β, non va escluso che questi possano essere ricondotti a un processo di banalizzazione dal congiuntivo all’indicativo, a un’errata lettura dell’antigrafo, per quanto riguarda le forme al passivo, o, appunto, al confronto con un altro testo delle Etym. in cui si leggeva una forma alternativa.
Nella seconda parte del passo la frase non sunt genera, sed hoc nominum ratio et auctoritas voluit è trasmessa da Bern. e dalla maggior parte dei testimoni isidoriani, ma non è riportata da K1L1t. Colpisce subito che in Bern. sia presente ciò che omettono i più antichi manoscritti di β, che, nel caso di K e L, vedranno supplita la lacuna soltanto nel X (L2) e XI secolo (K2). Si noti comunque che il brano compare nel Par.Lat.7530, composto a Montecassino nella seconda metà dell’VIII secolo15.
Possiamo poi soffermarci sul fatto che Bern. presenta cetera nomina laddove i codici di γ concordano nel riportare il solo cetera. L’aggiunta di nomina è trasmessa da KLt nella famiglia β, da AbcFfINnqyZ nella famiglia α; Spevak nella sua edizione non stampa il sostantivo, a differenza di quanto faceva Lindsay. Nel commentare il passo, l’editrice afferma che il testo trasmesso dai manoscritti di γ è migliore, «tout en restant imprécis» (Spevak 2020: 252-253). Per quel che riguarda i nostri fini, la discrepanza cetera / cetera nomina non può essere seriamente presa in considerazione per far luce sulla famiglia del modello utilizzato dal compilatore, perché la presenza del termine non risulta essere lezione particolare né di α né di β, e nemmeno è da escludersi che si tratti di un’innovazione poligenetica, in quanto può essere facilmente spiegata l’aggiunta del termine nomina in una sezione che appunto tratta de nomine.
Tabella 4
| ***Bern. 87, 13-17 De his autem sex casibus Hesidorus dicit: “Nominativus casus dictus est, quia per eum aliquem nominamus, ut hic magister; genetivus, quia per eum genus cuiuscumque quaerimus, ut huius magistri; dativus, quia per eum nos dare alicui aliquid demonstramus, ut ‘da huic magistro’. | Etym. 1, 7, 31-32 Nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus, ut hic magister. Genetivus, quia per eum genus cuiuscumque quaerimus, ut huius magistri filius, vel quod rem significamus, ut huius magistri liber. Dativus, quia per eum nos dare alicui aliquid demonstramus, ut da huic magistro. Post genetivus leg. casus A | vel … magistri (liber) non hab. A1K1L1 | ut om. C | liber TU : rell. non hab. | alicui om. X | demonstramus : significamus K1L : vel demonstramus add. K2 | da om. X | K Nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus ut hic magister genetivus quia per eum genus cuiuscumque querimus ut huius magistri filius dativus quia per eum nos dare alicui aliquid significamus ut da huic magistro post filius add. vel quod rem significamus ut huius magistri in marg. K2 | post aliquid2 add. vel demonstramus K2 | L Nominativus casus dictus quia per eum aliquem nominamus ut hic magister genetivus quia per eum genus cuiuscumque querimus ut huius magistri filius dativus quia per eum nos dare alicui aliquid significamus ut da huic magistro post filius add. vel quod rem significamus ut huius magistri add. in marg. L2 |
| Par.Lat.7530 Nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus ut hic magister genitivus quia per eum genus cuiuscumque querimus ut huius magistri dativus quia per eum nos dare alicui aliquid significamus ut da huic magistro | Vat.Lat.5873 Nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus ut hic magister genitivus quia per eum genus cuiuscumque querimus ut huius magistri filius dativus quia per eum nos dare alicui aliquid significamus ut da huic magistro | A Nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus ut hic magister genitivus casus quia per eum genus cuiuscumque quaerimus ut huius magistri filius dativus quia per eum nos dare alicui aliquid demonstramus ut da huic magistro post filius add. vel quod rem significamus ut huius magistri A2 | b nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus ut hic magister genitivus quia per eum genus cuiuscumque quaerimus ut huius magistri dativus quia per eum nos dare alicui aliquid demonstramus ut da huic magistro post magistri add. filius vel quod rem significamus huius magistri in marg b2 | Z nominativus casus dictus quia per eum aliquid nominamus ut hic magister genitivus quia per eum genus cuiuscumque querimus ut huius magistri dativus quia per eum nos dare alicui aliquid demonstramus ut da huic magistro post querimus add. ut huius magistri filius vel quod rem significamus in marg. Z2 |
Nell’esposizione sui casi riportata da Bern. l’esempio del genitivo huius magistri manca del termine di riferimento. Nella tradizione isidoriana la maggior parte dei testimoni concorda nel trasmettere ut huius magistri filius vel quod rem significamus ut huius magistri (vd. Tabella 4); soltanto TU aggiungono poi liber, come segnala Spevak in apparato 16. Dalle collazioni emerge che, oltre ad A1K1L1, nemmeno Par.Lat.7530 Vat.Lat.5873 b1Z1 riportano vel quod … magistri (non abbiamo riportato il testo di t perché la pergamena in questo punto è mutila). Eccezion fatta per il codice parigino e per il vaticano, il brano mancante è stato integrato da mani correttrici successive. Si può ipotizzare che la lezione originaria fosse ut huius magistri filius, come trasmettono K1L1Vat.Lat.5873 A1b1Z1, e che poi essa fu ampliata con vel quod rem significamus ut huius magistri (liber). Dato che Bern. presenta il solo ut huius magistri, si può ipotizzare che nel modello fosse già presente l’estensione vel quod … magistri e che il copista del trattato abbia commesso un salto da pari a pari tra il primo e il secondo ut huius magistri. Potrebbe essere di una qualche rilevanza notare che nelle Explanationes in Donatum (GL IV, 534, 27) l’esempio, che in questo caso non si sdoppia, si riduce al solo ut huius magistri, anche se allo stato attuale non sappiamo molto dei rapporti fra questo testo, o uno simile perduto, e Bern. per stabilire se ci sia una qualche loro influenza in questo luogo17.
Poco più avanti, nell’esposizione del dativo, Bern., come del resto anche la maggior parte dei testimoni isidoriani, presenta dativus quia per eum nos dare alicui aliquid demonstramus. Come indicato in apparato da Spevak, K1L riportano significamus, lezione che troviamo anche nel Par.Lat.7530 e nel Vat.Lat.5873 e che quindi è considerabile come propria della famiglia β, in quanto dalle collazioni nessun altro testimone risulta trasmetterlo. Anche in questo caso Bern. evita una lezione propria di β.
Tabella 5
| Bern. 88, 2-4 Ablativus ideo dicitur, quia per eum nos auferre aliquid cuiquam significamus, ut ‘aufer a magistro’. | Etym. 1, 7, 32 Ablativus, quia per eum nos auferre aliquid cuiquam significamus, ut aufer a magistro. nos om. B | aliquid om. A1 | ut aufer a magistro non hab. K1L | K Ablativus quia per eum nos auferre aliquid cuiquam significamus post significamus add. ut auferam magistro K2 | t Ablativus quia per eum nos auferre aliquid cuiquam <sig>nificamus |
| L Ablativus quia per eum nos auferre aliquid cuiquam significamus | A Ablativus quia per eum nos aliquid auferre cuiquam significamus ut aufer a magistro | Z Ablativus quia per eum nos auferre aliquid cuiquam significamus |
Passiamo ora alla discussione dell’ultimo brano rilevante ai fini della nostra dimostrazione: la spiegazione dell’ablativo. Bern. segue Isidoro così come ha fatto nelle righe precedenti e riporta l’esempio ut aufer a magistro (vd. Tabella 5). Dalle collazioni è emerso che esso non è trasmesso da K1Lt e nemmeno da Z. Anche in questo luogo, quindi, siamo di fronte a un caso in cui Bern. non presenta un’omissione che caratterizza i più antichi manoscritti della famiglia β.
Conclusioni
I passi analizzati fanno emergere una situazione piuttosto chiara per quanto riguarda il modello utilizzato, direttamente o indirettamente, dal compilatore dell’Ars Bernensis: esso non apparteneva alla famiglia β, o almeno non presentava le lezioni che troviamo nei manoscritti di β della seconda metà dell’VIII secolo, che, secondo l’ipotesi di Holtz sulla datazione di Bern., sarebbero coevi alla compilazione del trattato18. Per quanto invece riguarda la collocazione di questa ars grammatica a Bobbio, la ricerca non ha evidenziato alcun collegamento certo tra il trattato e A, sicuramente vergato a Bobbio nella seconda metà dell’VIII secolo19. La sistematica distanza tra Bern. e le lezioni proprie dei manoscritti più antichi di β è ciò che emerge con maggiore chiarezza dall’indagine: accettando dunque l’ipotesi di Holtz sull’origine bobbiese della grammatica, alla luce dei risultati ottenuti dalla ricerca, possiamo dedurre che tra la metà e la fine dell’VIII secolo a Bobbio era presente un manoscritto delle Etymologiae appartenente alla famiglia α da cui il compilatore di Bern. trasse le citazioni isidoriane. Potremmo spingerci fino a ipotizzare che il modello utilizzato da Bern. sia stato l’antigrafo di A, ma non ci sono evidenze incontrovertibili che puntino in questa direzione, per quanto sia significativo l’accordo su generantur (Bern. 82, 5-8; ma vd. n. 20). La presenza di esemplari della famiglia β a Bobbio, allo stato attuale della nostra conoscenza, è limitata al solo L, che fu portato nel milieu piacentino da un certo Boniprandus, ad un’altezza cronologica non specificata ma antecedente alla prima metà del IX secolo.
Bibliografia
Bassetti, Massimiliano (2018), All’incrocio di culture tra Antichità e Medioevo. Storie di palinsesti a Verona, tra Ravenna e Bobbio, «Scripta», 11, p. 9-35.
Bauer, Bernhard – Krivoshchekova Victoria (2022), Definitions, dialectic and Irish grammatical theory in Carolingian glosses on Priscian: a case study using a close and distant reading approach, «Language & History», 65, 2, p. 85-112.
Biondi, Laura (2022), Teoria linguistica e grammaticografia del Latino nell’Alto Medioevo. Temi, modelli e metalinguaggio, Pisa, ETS.
Bramanti, Andrea (2022), M. Plotii Sacerdotis artium grammaticarum libri I-II; [Probi] De Catholicis; [M. Plotius Sacerdos]; introduzione e edizione critica sinottica a cura di Andrea Bramanti, 2 voll., Hildesheim, Weidmann, «Bibliotheca Weidmanniana. Collectanea grammatica latina» (17).
— (2018), Una mancata ubiquità: presenza e assenza di Varrone in Sacerdote II – Catholica Probi, «Latinitas», n. s. 6, p. 17-34.
Canfarotta, Laura (2008), Elementi priscianei nella Grammatica di Alcuino, «Mediaeval Sophia. Studi e ricerche sui saperi medievali», 4, p. 46-57.
Chittenden, John (1982), Donatus Ortigraphus. Ars grammatica, Turnholti, Brepols, «Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis» XL d.
Davies, Luned M. (1997), Isidorian Texts and the Hibernensis, «Peritia», 11, p. 207-249.
De Paolis, Paolo (2022), La riscoperta umanistica della letteratura grammaticale ‘minore’: il fondo bobbiese, «Paideia», 77, p. 313-340.
— (2017), «Le strategie linguistiche e didattiche dei commenti a Donato: osservazioni sulle Explanationes in Donatum», In: García, Leal A.; Prieto Entrialgo, C. E. (eds.), Latin vulgaire – latin tardif XI. XI Congreso Internacional sobre el Latín Vulgar y Tardio (Oviedo, 1-5 de septiembre de 2014), Hildesheim-Zurich-New York, Olms-Weidmann.
di Maggio, Lorenzo (2021), Virgilius redivivus. Einführung, Kommentar und Übersetzung zu Virgilius Maro Grammaticus, Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier, «Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium» 107.
Dold, Alban (1931), Zwei Bobbienser Palimpseste mit frühestem Vulgatatext aus Cod. Vat. Lat. 5763 u. Cod. Carolin. Guelferbytanus. Anhang: Geschabte Paulustexte der 1. Hälfte des 7. Jahrhunderts mit einer gleichzeitigen unbekannten Liste paulinischer Leseabschnitte in einer Bobbienser Handschrift (Cod. Vat. Lat. 5755), 19-20, Beuron, Kunstschule der Erzabtei, «Texte und Arbeiten».
Hagen, Hermann (1870), Supplementum continens Anecdota Helvetica ex recensione Hermanni Hageni, Lipsiae, Teubner, «Grammatici Latini» VIII.
Herren, Michael W. (1995), Virgil the Grammarian: a Spanish Jew in Ireland?, «Peritia», 9, p. 51-71.
Holtz, Louis (1995), «L’Ars Bernensis, essai de localisation et de datation», In: Picard J. M. (ed.), Aquitaine and Ireland in the Middle Ages, Dublin, Four Court Press, p. 111-126.
— (1992), Una nuova fonte manoscritta dell’Arte bernese, «Annali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (filol.)», 14, p. 5-29.
— (1981a), Donat et la tradition de l’enseignement grammatical: étude sur l’Ars Donati et sa diffusion (IVe-IXe siècle) et édition critique, Paris, CNRS éditions.
— (1981b), «Irish grammarians and the Continent in the seventh century», In: Brennan M. and Clarke H. B. (eds.), Colombanus and Merovingian Monasticism, Oxford, BAR, International Series, 113, p. 135-152.
Jeudy, Colette (1972), L’Institutio de nomine, pronomine et verbo de Priscien: manuscrits et commentaires médiévaux, «Revue d’histoire des textes», 2, p. 73-144.
Law, Vivien (1982), The Insular Latin Grammarians, 3, Woodbridge, Boydell Press, «Studies in Celtic History».
Lindsay, Wallace M. (1911a), Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. Lindsay, 2 voll., Oxonii, Oxford University Press.
— (1911b), The Editing of Isidore Etymologiae, «The Classical Quarterly», 5/1, p. 42-53.
Löfstedt, Bengt (1965), Der hibernolateinische Grammatiker Malsachanus, Uppsala, Uppsala Universitet, «Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Celtica Upsaliensia», 3.
Lo Monaco, Francesco (2006), «De fatis palimpsestorum bibliothecae sancti Columbani bobiensis», In: Escobar, A. (ed.), El palimpsesto grecolatino como fenómeno librario y textual, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», «Colección Actas Filología».
Mancini, Marco (2014), «Il latino di Gallia e Virgilio grammatico: tra ecdotica e linguistica storica», In: Molinelli P., Cuzzolin P. e Fedriani C. (eds.), Latin vulgaire – Latin tardif X. Actes du Xe colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Bergamo, 5-9 septembre 2012, vol. 3, Bergamo, Bergamo University Press/Sestante Edizioni, p. 937-992.
Ó Corráin, Donnchadh (2017), Clavis Litterarum Hibernensium. Medieval Irish Books & Texts (c. 400 – c. 1600), vol. 2, Turnhout, Brepols, «Corpus Christianorum».
O’ Rorke, Jason (2020), On the Date, Authorship, and Newly Discovered Old Irish Material in the Ars Ambrosiana, «The Journal of Medieval Latin», 30, p. 67-84.
Passalacqua, Marina (2005), «Priscianus Caesariensis – Institutio de nomine et pronomine et verbo», In: Chiesa, P.; Castaldi, L. (a cura di), La trasmissione dei testi latini del Medioevo (Te. Tra.), Firenze, SISMEL – Edizioni del Galluzzo, 2, p. 514-517.
Reydellet, Marc (1966), La diffusion des Origines d’Isidore de Séville au Haut Moyen Âge, «Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’Ecole Française de Rome», 78/2, p. 383-437.
Spevak, Olga (2020), Isidore de Séville, Étymologies. Livre I. La grammaire. Texte établi, traduit et commenté per O. Spevak, Paris, Les Belles Lettres.
— (2017), Les additions dans Isid. Etym. I: témoins d’un travail rédactionnel, «Archivum Latinitatis Medii Aevi», 75, p. 59-88.
Stansbury, Mark (2015), «The “Private” Books of the Bobbio Catalogue», In: Moran P. and Warntjes I. (eds.), Early medieval Ireland and Europe: chronology, contacts, scholarship, Turnhout, Brepols, «Studia Traditionis Theologiae», 14, p. 625-641.
Steinová, Evina (2021), Two Carolingian Redactions of Isidore’s Etymologiae from St. Gallen, «Mittellateinisches Jahrbuch», 56/2, p. 298-376.
Tolkiehn, Johannes (1928), Clementis Ars Grammatica, «Philologus», Supplementband 20/3.
Warnes, Julia (2020), Dúngal: A Study of his Life and Works, PhD thesis, University of Toronto, Centre for Medieval Studies.
Zetzel, James E. G. (2018), Critics, Compilers, and Commentators. An Introduction to Roman Philology, 200 BCE – 800 CE, Oxford, Oxford University Press.
Zironi, Alessandro (2004), Il monastero longobardo di Bobbio. Crocevia di uomini, manoscritti e culture, Spoleto, Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, «Istituzioni e Società», 3.
Note
- Per maggiori informazioni sulle artes grammaticae rimando al fondamentale manuale di Law 1982, cui si è aggiunto in tempi recenti quello curato da Zetzel 2018. Bibliografia aggiornata su Bern. è raccolta in Ó Corráin 2017: 661-662, Zetzel 2018: 358 e Biondi 2022: 62 n. 66. Il trattato è giunto mutilo: comprende infatti soltanto la sezione de octo partibus orationis, de nomine e de pronomine.
- L’unica edizione integrale di Bern. è quella pubblicata da Hagen 1870: 62-142. A questa si aggiunge un’edizione parziale dei passi presenti anche nel manoscritto di Ripoll curata da Holtz 1992: 13-29.
- Recenti contributi su Viriglio Marone grammatico sono il volume curato da Di Maggio 2021 e la scheda in Ó Corráin 2017: 717-723, dove è fornita una buona base bibliografica. Sull’annosa questione riguardo alla sua collocazione cronologica e geografica, rimando al contributo di Mancini 2014: 937-941, nonché agli articoli di Holtz 1981b: 138 e di Herren 1995, interamente dedicato all’argomento.
- Sull’uso dell’Ars grammatica di Prisciano (ormai è questo il titolo cui ci si riferisce all’opera maggiore del grammatico, e non più Institutiones grammaticales) nei trattati grammaticali insulari si veda anche Canfarotta 2008: 47 e Bauer – Krivoshchekova 2022: 85-86.
- Sui rapporti tra Bern., Clemente e DO rimando anche a Law 1982: 77. Il trattato di DO è stato pubblicato da Chittenden 1982; per quanto invece riguarda la grammatica attribuita a Clemente, l’edizione di riferimento è Tolkiehn 1928. Il mio progetto di dottorato mira ad approntare una nuova edizione critica di questa, che tenga conto dei nuovi testimoni manoscritti e degli studi che sono stati svolti intorno alle fonti e alle altre artes grammaticae coeve.
- Tale argomento è stato però messo in discussione da Bramanti nei suoi recenti studi su Sacerdote (Bramanti 2018; Bramanti 2022). Egli, infatti, ritiene che le cinque citazioni non siano attribuibili a Sacerdote e conclude affermando che nei brani attribuiti a Claudius in Bern. «sia stata impiegata più di una fonte e che Sacerdote abbia costituito il probabile punto di partenza, poi arricchito e alterato da una personale pratica di giustapposizione di altri materiali di differente provenienza» (Bramanti 2018, 24-25).
- Già Davies 1997: 230-231 aveva fornito una breve analisi del rapporto tra le Etymologiae e alcune grammatiche insulari (Ars Bernensis, Ars Ambrosiana, Ars Malsachani, Anonymus ad Cuimnanum e le artes di Bonifacio e Tatuino), arrivando a concludere che «no clear case can be made for the influence of any particular family or manuscript of OR [Origines] on the grammars because Isidore’s text was adapted so much by the grammarians». Dei cinque esempi presi in considerazione da Davies, nelle prossime pagine ne saranno discussi tre: Bern. 67, 2-4; 82, 5-8; 87, 13-17. Gli altri due passi ricordati nell’articolo del 1997(Bern. 82, 2; 82, 25), in realtà, alla luce delle collazioni che abbiamo svolto (vd. sotto n.14), non apportano alla questione tutto quel significato che Davies vuol dare loro.
- Sulla questione delle famiglie di tradizione delle Etymologiae e sulla costruzione dello stemma, sono molte le riflessioni che si sono succedute dall’edizione di Lindsay (1911a) fino a quella di Spevak (2020). Per meri motivi di spazio devo sorvolare sulla questione: dunque, per una visione d’insieme delle proposte avanzate negli anni, rimando a Lindsay 1911b, Reydellet 1966, Spevak 2020: LXXX-CXIV e Spevak 2017.
- Rimando alla prossima n. 13 per lo scioglimento delle sigle dei manoscritti delle Etym. Sia K sia L sono stati corretti da mani successive che hanno integrato o emendato alcune delle lezioni proprie della famiglia β presenti nei due codici. Non essendo riuscita a trovare contributi specifici su K2 e L2, ho chiesto un consulto paleografico al Prof. A. Mastruzzo, che ha gentilmente analizzato le due mani correttrici e ha datato K2 come risalente all’XI secolo inoltrato e L2 probabilmente al X secolo; dal punto di vista geografico, le due mani non sono ascrivibili a nessuna zona in particolare.
- La prima ipotesi dell’origine bobbiese di K e L fu espressa da Dold 1931. Su K e L, oltre alla bibliografia indicata a testo, rimando anche a quella citata in De Paolis 2022: 326 n.33.
- Sulla “sindrome di Boniprandus”, «vale a dire il tentativo di difendere a ogni costo, e talvolta contro l’evidenza dei fatti, la supposta origine bobbiese di un manoscritto» rimando a Lo Monaco 2006: 60; sui libri di Boniprandus a Warnes 2020: 103 n. 3 e a Stansbury 2015: 630-631 che, però, non ricorda L, ma si focalizza soltanto sui libri appartenenti a Boniprandus segnalati nel catalogo della biblioteca di Bobbio del X secolo.
- I passi di Bern. sono citati secondo il testo pubblicato da Hagen 1870, fatta eccezione per i brani presenti nell’edizione di Holtz 1992, che segnalo anteponendo tre asterischi (***) al riferimento. Ecco la lista completa dei paralleli isidoriani in Bern.: Bern. 62, 8-9 cfr. Etym. 1, 6, 1; Bern. 62, 14-19 cfr. Etym. 1, 6, 1-2; Bern. 63, 1-3 cfr. Etym. 1, 6, 2; Bern. 63, 7-9 cfr. Etym. 1, 6, 2; Bern. 63, 33-34 cfr. Etym. 1, 7, 1; Bern. 64, 6-7 cfr. Etym. 1, 7, 1; Bern. 67, 2-4 cfr. Etym. 1, 7, 3; ***Bern. 82, 2-4 cfr. Etym. 11, 1, 2; ***Bern. 82, 5-8 cfr. Etym. 1, 7, 28; ***Bern. 82, 25-26 cfr. Etym. 1, 7, 28; ***Bern. 83, 16-19 cfr. Etym. 1, 7, 29; ***Bern. 87, 13-18 cfr. Etym. 1, 7, 31-32; Bern. 87, 32-88, 3 cfr. Etym. 1, 7, 32; Bern. 88, 27-30 cfr. Etym. 1, 7, 33.
- I manoscritti collazionati sono i seguenti (alcuni sono acefali o presentano solo estratti; per maggiori informazioni rimando al progetto curato da E. Steinová, Innovating Knowledge, URL:<https://innovatingknowledge.nl/>, dove sono raccolti tutti i testimoni delle Etymologiae anteriori al XII secolo finora conosciuti): della famiglia β, K (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, Weiss. 64, s. VIII); L (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5763, s. VIII); M (Cava dei Tirreni, Archivio dell’Abbazia, MS 2, s. VIII4/4); k (Vercelli, Biblioteca Capitolare, MS CXXVIII, s. X1/2); r (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7803 s. IXmed.); t (Modena, Biblioteca Capitolare, O.I.17, 760-778); Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XXIV.1, s. XII1/2; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 7783, s. XI; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5873, s. XII; Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Plut.90 sup.17/3, s. XIII; Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Hs 23375, 1146-1155; Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 7530, s. VIII. Di α, invece, A (Milano, Biblioteca Ambrosiana, L 99 sup., s. VIII2/2); a (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1953, s. IX1/4); b (Bern, Burgerbibliothek, MS 224, s. IX1/3); c (Cesena, Biblioteca Malatestiana, S.XXI.5, s. IX1/3); D (Basel, Universitätsbibliothek, F III 15, s. IX1/4); d (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 10292, s. IX3/4); e (El Escorial, Monasterio San Lorenzo, P.I.8, s. VIII/IX); F (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 17159, s. IX); f (Reims, Bibliothèque Municipale, MS 425, s. IXmed.); I (Bruxelles, Koninklijke Bibliotheek, II 4856, s. VIIIex.); l (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 10291, s. IX); N (Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, Aug. Perg. 57, s. VIII2/2); n (Reims, Bibliothèque municipale, MS 426, s. IX1/4); P (Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 7582, s. IX); q (Laon, Bibliothèque Suzanne Martinet, MS 447, s. IX2/3); Y (Valenciennes, Bibliothèque Municipale, MS 399, s. IXin.); y (Montpellier, Bibliothèque interuniversitaire, H 53, s. IX2/2); Z (Zofingen, Stadtbibliothek, Pa 32, s. IX2/3).
- Negli ultimi due passi analizzati è presente anche Z, appartenente alla famiglia α, ma, come evidenziato da Steinová 2021: 330, frutto di un’attività redazionale che ebbe luogo a San Gallo e che implicò anche l’uso di un manoscritto, ormai andato perduto, riconducibile alla famiglia β. Nelle tabelle non riporto il testo di tutti i manoscritti collazionati perché non tutti presentano le lezioni particolari di β, ma concordano con la maggior parte della tradizione delle Etym.; inoltre, come segnalato sopra alla n. 13, non tutti sono testimoni completi.
- Apparentemente unici nella tradizione, Par.Lat.7530 e Vat.Lat.5873 leggono instituit anziché voluit.
- Il termine liber, per quanto rarissimo nella tradizione,è essenziale nell’ampliamento, perché non sarebbe altrimenti chiara l’estensione alla res.
- Le Explanationes in Donatum sono due commenti all’Ars minor e all’Ars maior di Donato, risalenti uno alla metà del V, l’altro al VI secolo; maggiori informazioni sono reperibili in Zetzel 2018: 321-322 e in De Paolis 2017. Il brano in questione è il seguente: «genitivus casus dictus est, quod per eum genus cuiusque vel rem significemus, ut huius magistri» (GL IV; 534).
- Si tenga comunque presente, come accennato sopra per la duplex lectio in Bern. 82, 5-8, che non è da escludersi la possibilità che l’artigrafo avesse accesso al testo delle Etymologiae grazie a tramiti diversi, pratica frequentemente seguita nella compilazione di opuscoli coevi.
- Davies (1997: 230-231) sottolineava una certa vicinanza tra Bern. e AK, ma, avendo effettuato collazioni di tutti i passi delle Etym. citati in Bern., abbiamo dimostrato che il trattato non presenta inconfutabili segni di vicinanza né con A né tantomeno con K, fatta eccezione per la duplex lectio di Bern. 82, 5-8, per cui vd. sopra ad. loc. e n. 19.