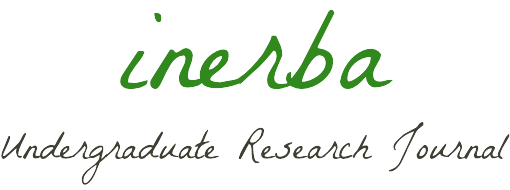Inquadramento generale
La condizione femminile in Spagna durante il periodo della dittatura di Francisco Franco, che si protrasse dal 1939 al 1975, è una tematica che, recentemente, ha prodotto un’intensa proliferazione di studi e ricerche, ma anche, e soprattutto, di discussioni e incontri (Egido León 2011: 19). Uno di questi fu il convegno Mujeres bajo la dictadura franquista, che ebbe luogo nel Circolo delle Belle Arti, a Madrid, il 2 e il 3 dicembre del 2008. Patrocinato dalla Fondazione Pablo Iglesias, lo scopo fu quello di attirare l’attenzione sull’importanza del recupero della memoria storica e della testimonianza, entrambe considerate essenziali poiché permettono di raccogliere sia l’esperienza individuale sia quella collettiva. Ma il vero protagonista di questo incontro fu il tema della repressione che, utilizzata dal regime con l’appoggio della Chiesa Cattolica, assunse tratti particolarmente violenti nei confronti delle donne. I recenti studi parlano, infatti, di una doppia repressione: politica e di genere (Moreno 2013: 1 – 3). “Mujeres y rojas” erano le accuse per cui le spagnole di qualsiasi età e appartenenza sociale vennero prima arrestate, poi interrogate e torturate e, infine, imprigionate o uccise. Il semplice fatto di essere donna costituiva un aggravante per tutte coloro che provenivano da famiglie anarchiche, comuniste o repubblicane. Non solo, erano considerate anche responsabili dei reati compiuti dai loro mariti, dai loro padri o dai loro fratelli.
Ma facciamo un passo indietro: subito dopo la fine della Guerra Civile, i cittadini spagnoli furono immediatamente privati di tutti quei diritti democraticamente concessi dalla Costituzione Repubblicana del 9 dicembre del 1931. In particolare, coloro che subirono maggiormente questa ingiustizia furono le donne, che non riuscirono in alcun modo a difendere quei pochi privilegi faticosamente raggiunti. Tra questi ricordiamo, ad esempio, il diritto di voto, un’assicurazione lavorativa in caso di maternità, il riconoscimento del matrimonio civile e del divorzio. In pratica, la Repubblica di pochi anni prima aveva proclamato e garantito l’uguaglianza tra uomo e donna, prerogativa mai esistita prima di allora e nuovamente abolita con l’instaurazione della dittatura franchista. Così, la donna fu costretta a rioccupare quell’infimo livello sociale, politico e giuridico di subordinazione e di dipendenza rispetto all’uomo e quel sogno democratico di parità ed equilibrio si spense per sempre. È molto importante ricordare, inoltre, che alle donne non era mai stato permesso di partecipare attivamente alla vita politica o comunitaria; l’unico spazio in cui, e non sempre, avrebbero potuto avere voce in capitolo era quello esclusivamente domestico. Per questo motivo, agli occhi del regime e della Chiesa Cattolica, l’aver osato oltrepassare i limiti dell’ambito familiare, interessandosi alla politica, al diritto e alla cultura, costituiva una ribellione imperdonabile (Aguado e Verdugo 2011: 56 – 57). In Spagna, infatti, era da sempre esistita una concezione ideologica puramente maschilista e misogina, secondo cui l’intera società si disponeva in maniera gerarchica, permettendo soltanto agli uomini di accedere alla vita pubblica e politica, confinando, invece, le donne entro i limiti della sfera domestica. Questa sistemazione dell’intera collettività, dove la famiglia patriarcale era simbolo di ordine, rispondeva all’esigenza di un’armonia e di un equilibrio sociale. Era così previsto che le donne fossero perennemente soggette alla volontà del padre o del marito, i quali si arrogavano qualsiasi diritto, soprattutto quello di comandare e di punire, lasciando, così, alla madre o alla moglie un copione da mera comparsa, senza alcuna possibilità di decisione, nemmeno sulla sorte dei propri figli. Di conseguenza, questo assetto sociale imponeva un forte sentimento antifemminista e una mentalità estremamente retrograda, secondo cui uomini e donne, per natura, non avrebbero mai potuto essere considerati uguali; gli uomini, reputati superiori, possedevano forza e talento, virtù che avrebbero potuto sfruttare nell’ambito pubblico e politico, mentre le donne, viste come esseri inferiori e troppo deboli, avrebbero dovuto portare a termine l’unico compito assegnato loro, cioè quello di essere delle buone madri (Ortega López 2008: 57 – 60).
Allo stesso tempo, però, il ruolo della moglie e della madre, in seno alla famiglia, non era assolutamente da sottovalutare, poiché costituiva il fulcro dell’intera società e dell’intera nazione; la donna garantiva la continuità di una generazione e, quindi, di un popolo. Più un popolo era forte e numeroso e più veniva temuto e rispettato. Tutti i regimi, insieme a quello di Franco, in questo senso, concessero alla donna un ruolo da protagonista, sebbene riguardasse solo l’ambito familiare. Inoltre, la difesa della famiglia patriarcale costituì un punto d’incontro tra la dittatura spagnola e la Chiesa Cattolica, che, da sempre, aveva ostacolato qualsiasi tipo di emancipazione femminile. Secondo le Sacre Scritture, infatti, il destino di ogni donna sarebbe stato quello di essere una sposa e una madre esemplare. Per questo motivo, era categoricamente vietato il divorzio e qualsiasi forma di ribellione rispetto all’uomo, con lo scopo di preservare, non solo l’intera società, ma anche il volere del Dio cristiano (Ortega Lopéz 2008: 64 – 69). Per reindirizzare, quindi, tutte coloro che avevano smarrito la strada maestra, fu necessario prima di tutto una severa punizione, che avrebbe avuto la funzione di purificare la loro anima e la loro mente, gravemente contaminate da ideologie considerate eretiche. In un secondo momento, poi, attraverso il lungo e paziente processo della rieducazione, tutte avrebbero potuto prendere coscienza dei propri errori e risanare, così, i peccati compiuti contro Dio, la Chiesa e lo Stato, assumendo il ruolo da sempre assegnatogli. Nell’ottica franchista, riccamente nutrita dagli studi pseudoscientifici dello psichiatra Antonio Vallejo Nágera, essere una donna repubblicana, “una roja”, significava sostanzialmente essere una sgualdrina, soprattutto se, oltre ad approvare l’ideologia marxista, agiva fornendo aiuti ai suoi familiari e al resto dei compagni nella guerriglia. Infatti, nei numerosi fascicoli e nei registri penitenziari non è raro imbattersi in pesanti giudizi morali, che la accusavano di: “conducta licenciosa” (Pérez Lacruz 1942), “organizar orgías” (Estruch Espinós 1940), “malos antecedentes de conducta moral y social” (Aragón Valiente 1942) o di “excesos de lenguaje” (Estela Alama 1942). Lo scopo non era altro se non quello di screditare totalmente l’imputata, rifiutandosi di riconoscerla come una detenuta politica, come un soggetto pensante, con coscienza e capacità di discernimento. Si voleva declassarla, facendo credere che la sua colpa fosse strettamente legata al genere di appartenenza, ritenendola capace solo di essere una “mujer caída con faltas de moralidad”. Difatti, capitò più e più volte che, durante i lunghissimi interrogatori, la Guardia Civile, l’Esercito o la Falange obbligassero le sospettate, attraverso supplizi e torture, a confessare di esercitare la prostituzione nella guerriglia. Ce ne parla anche Remedios Montero, una delle tante militanti repubblicane, sopravvissuta alla dittatura: «ha habido mucha gente que ha querido desprestigiarnos y ha hecho creer que estábamos allí, en la guerrilla, para entretenimiento de los hombres» (Montero Martínez 2008).
Questa volontà, da parte del regime, di diffamare in pubblico giovani madri, adolescenti e anziane, senza alcuna discriminazione, apriva il passo a una forma di repressione molto più crudele e spietata. Era sufficiente anche solo aver preso parte a piccole attività solidali, intonare canzoni non permesse dal regime, venire denunciate dai vicini di casa (nonostante mancassero prove) di aver a che fare, ad esempio, con la guerriglia, con il contrabbando o con la propaganda per essere immediatamente arrestate e trascinate in questura, il luogo infernale per eccellenza. Qui, infatti, gli uomini di Franco perpetravano indicibili violenze, abusi e torture. Grazie a numerose testimonianze, siamo venuti a conoscenza di pratiche terribili come la rasatura a zero e l’imposizione di bere olio di ricino attraverso un imbuto conficcato in gola, che provocava ferite e vomito e, pochi istanti dopo, anche diarrea e gastroenterite. Poi, sporche, disidratate, indebolite e coperte di mosche, le imputate venivano denudate in pubblico, derise e addirittura lapidate. L’intenzione era quella di annichilirle fisicamente e psicologicamente, senza nemmeno risparmiare loro la presenza delle loro madri, obbligate ad assistere a queste pratiche scellerate (Moreno 2013: 3). Inoltre, coloro che aspettavano un bambino o che erano prossime al parto chiedevano di non essere colpite sulla pancia, sicure che una richiesta del genere non sarebbe rimasta inascoltata. Si sbagliavano: ignare del fatto che avrebbero presto ricevuto violenti colpi sull’addome, molte di loro rischiarono aborti o emorragie. Come se non bastasse, i carnefici accompagnavano queste violenze abominevoli con commenti altrettanto ripugnanti, esclamando, ad esempio: “Un rojo menos!”, riferendosi a un’innocente creatura che, secondo loro, non avrebbe dovuto avere nemmeno il diritto di nascere. Ma lo stretto controllo del regime non si fermò qui; la repressione franchista varcò anche la soglia intima e privata delle abitazioni. Furono innumerevoli le retate notturne e i sopralluoghi improvvisati, da parte degli agenti del Caudillo, al fine di catturare fuggitivi e repubblicani della guerriglia. Era noto, infatti, che le donne fornissero grossi aiuti ai compagni esuli sui monti: cibo caldo, acqua, medicinali, coperte e, ai feriti, anche un riparo per la notte. Proprio per questo, furono loro a pagare il prezzo più alto: donne che, invece di occuparsi esclusivamente delle pulizie domestiche e dell’educazione della prole, avevano assunto un ruolo dinamico e decisionale che non gli apparteneva.
La pericolosità delle pseudoscienze
A fomentare questo atteggiamento dispotico e misogino, contribuirono anche la scienza e la letteratura. Già nel 1923, il filosofo e saggista spagnolo José Ortega y Gasset affermava, addirittura, che la donna doveva essere considerata in gruppo, in quanto genere biologicamente diverso da quello maschile, e non come un singolo individuo. E continuò incessantemente a sottolineare le grandi differenze tra uomo e donna, individuando, nel primo, una forte volontà d’azione e la difficoltà a non accontentarsi mai, e, nella seconda, una propensione alla quotidianità e alla vicinanza all’ambiente casalingo. A proposito, poi, del contesto scientifico e medico, è impossibile non fare riferimento al già citato Nágera, intimo e grande ammiratore di Franco. Direttore dell’ospedale psichiatrico militare di Ciempozuelos e professore di psichiatria nell’Accademia di Sanità Militare, era ossessionato dall’eugenetica e dal voler perfezionare l’intera società, evitando che nascite di esseri umani considerati inferiori contaminassero il resto della popolazione. Addirittura, arrivò a sostenere un’impellente necessità di castrazione di tutti i malati mentali e una pulizia etnica, pari a quella attuata dai nazisti nella vicina Germania (Vallejo Nágera 1937). Il 10 di agosto del 1938 scrisse personalmente a Franco, chiedendo il permesso di poter avviare delle investigazioni a livello psicologico, per poter ufficialmente riconoscere come patologiche le ideologie politiche di sinistra. Due settimane più tardi ricevette l’autorizzazione e avviò l’inchiesta, scegliendo, come campioni, 50 detenute repubblicane della prigione di Málaga, di cui 30 in attesa della loro esecuzione. Inoltre, per fare in modo che i risultati della sua ricerca fossero conformi alle sue teorie, sottopose le prese ad alcuni test psicologici solo quando si trovavano visibilmente sull’orlo del collasso fisico e mentale. L’obiettivo era quello di dimostrare la stretta correlazione tra la presenza del “gene comunista e marxista” e il deficit cognitivo. Dopo aver raccolto i risultati dei test, Nágera riuscì a dimostrare la validità della sua teoria: quando nella figura femminile si indeboliscono i freni imposti dalla società e si liberano così gli impulsi istintivi, si risveglia una crudeltà senza precedenti, che non si soddisfa una volta compiuto il crimine, ma, al contrario, aumenta sistematicamente durante la messa in atto del reato, per l’adrenalina accumulata nella sfida a un’imposizione. Arrivò a sostenere che il genere femminile sarebbe stato più propenso di quello maschile a commettere crimini; di conseguenza, per ripulire l’intera collettività, erano assolutamente necessari tutti i provvedimenti presi a livello carcerario da parte del regime ed era certo che sarebbe stato solo un bene separare gli elementi nocivi, come le donne anarchiche e repubblicane, dal resto della società (Preston 2011: 916 – 917).
L’importanza del ricordo
Ricollegandoci alle tematiche della testimonianza e della memoria storica, uno degli eventi che proprio non possiamo permetterci di dimenticare è la permanenza sottochiave e poi la fucilazione de “las trece rosas”, avvenuta il 5 di agosto del 1939. Da subito, il popolo spagnolo diede questo soprannome a 13 giovanissime donne, la maggior parte delle quali minori di età (la più giovane, Blanquita, non aveva ancora compiuto i 16 anni) e quasi tutte appartenenti alle “Juventudes Socialistas Unificadas”, che furono barbaramente uccise, insieme ai loro compagni di lotta, davanti alle mura del Cimitero dell’Est di Madrid. Furono giudicate colpevoli dal Tribunale de las Salesas con l’accusa di aver commesso atti di sabotaggio e di complotto a danni del regime. Pochi attimi prima della loro esecuzione, gridarono fiere e senza rimpianti: “Viva la República!”. Nel frattempo, sulla scrivania dell’ufficio della direttrice del carcere di Ventas, Carmen Castro, restavano le sollecitudini di indulto che ognuna delle giovani donne aveva scritto dopo la propria condanna a morte, tutte speranzose nella clemenza di Franco. La loro esecuzione, in realtà, non servì ad altro che a vendicare la morte dell’ufficiale della Guarda Civile, Isaac Gabaldón, di sua figlia di 17 anni e del loro autista, rimasti uccisi in una sorta di attentato, di cui furono considerati colpevoli i repubblicani. Tutto cominciò, però, negli ultimi giorni del mese di marzo dello stesso anno: dopo la trionfale entrata delle truppe di Franco a Madrid, mentre la maggior parte dei dirigenti pubblici e privati erano stati costretti all’esilio o imprigionati, un gruppo di giovani (uomini e donne) si dedicò a salvare quel che rimaneva della “JSU” e del partito socialista con la ferma intenzione di cambiare il corso drammatico degli eventi, aiutando sia i compagni arrestati e le loro famiglie sia i perseguitati dal regime, obbligati a fuggire e a nascondersi. Sfortunatamente non riuscirono nel loro intento e presto anche loro furono scovati dalla milizia franchista e arrestati. Giunti a questo punto, è giusto e doveroso ricordare i nomi di queste 13 vittime, perché non finiscano mai nell’oblio e nell’indifferenza: Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibañez, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García e Luisa Rodríguez de la Fuente. Infine, estrapolando, tra questi nomi, soltanto quello di Julia Conesa Conesa, detta “Julita”, si resta folgorati dalla sua straziante richiesta di non essere dimenticata, non solo rivolta ai suoi cari, bensì al mondo intero, soprattutto ai posteri, racchiusa nell’ultima lettera che scrisse a sua madre prima di venire fucilata. Queste sono le sue parole: «Salgo sin llorar. Me matan inocente pero muero como debe de morir una inocente. Madre Madrecita me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós madre querida, adiós para siempre. Que mi nombre no se borre de la historia» (Romeu Alfaro 2002 : 218). I già citati documenti, fascicoli e testimonianze sono molto preziosi perché rappresentano una ricchezza dal valore inestimabile, sia per il loro esiguo numero, sia per il loro contenuto che, a stento, avremmo altrimenti creduto possibile. Ricerche e studi sulle carceri franchiste, sui terribili trattamenti rivolti alle donne e, in generale, sull’intero sistema dittatoriale spagnolo, hanno iniziato a vedere la luce solo dagli anni ’90 in poi; prima, infatti – ma, in alcuni casi, anche tuttora – era molto difficile, se non impossibile, accedere agli archivi penitenziari o militari. Ed è proprio dall’inizio degli anni ’90 che iniziarono a farsi sentire le prime organizzazioni ed associazioni, con la ferma intenzione di coinvolgere sempre più cittadini, ricordando quello che era stato il loro passato. L’intero movimento di sensibilizzazione prese il nome di “Ley de Memoria Histórica”, che aveva lo scopo di avvalersi di una quantità sempre maggiore di documenti per poter soddisfare l’estremo bisogno di risposte, soprattutto alla domanda: “perché?”. Ma la difficoltà nel recupero di tutta la documentazione riguardo alle carceri franchiste è dovuta anche al fatto che la maggior parte di queste memorie scritte sono andate perdute con il passare del tempo, dato che il regime degli ultimi anni, per evitare che questi orrori documentati venissero letti o, ancor peggio, pubblicati, decise di distruggerli, contando sul fatto che nessuno avrebbe creduto alle storie raccontate dalle sopravvissute. Fortunatamente, però, storici, giornalisti e scrittori sono riusciti ad appropriarsi di prove che hanno dimostrato la veridicità delle loro testimonianze orali. Nonostante siano passati ormai ben 44 anni dalla fine della dittatura di Franco e dalla sua morte, ancora oggi risulta molto complicato riuscire a consultare determinati fascicoli. Per fare un esempio, non è possibile visitare l’archivio storico penitenziario della prigione di Picassent, a Valencia, le cui fonti sono sotto la stretta competenza della Direzione Generale delle Istituzioni Penitenziarie del Ministero dell’Interno.
L’inferno della prigionia
Dal convegno Mujeres bajo la dictadura franquista, già precedentemente menzionato, emerse un’opera collettiva, basata sugli interventi dei numerosi studiosi e partecipanti, che la storica Mary Nash si preoccupò di riunire e di pubblicare. Dopo una sua breve introduzione, il testo presenta le varie tesi che, toccando numerosi aspetti dell’oppressione di Franco, illustrano specialmente la sopravvivenza all’interno delle prigioni femminili dell’intera Spagna. Infatti, il luogo simbolo della doppia repressione e della conseguente rieducazione delle donne repubblicane è proprio il carcere, dove moltissime trovarono la morte. Uno dei sistemi di prigionia più tristemente ricordato, sia per la sua elevata mortalità, che per le sue scarse condizioni igieniche, era il carcere di Ventas, a Madrid. Agli inizi del 1940 la sua struttura, con una capienza di sole 500 detenute, ne ospitava ben 6.000, costrette, per mancanza di spazio, a dormire nei sottoscala e nei bagni. L’ingente difficoltà nell’affrontare questa situazione preoccupò moltissimo le autorità, non tanto per motivi umanitari e igienici delle detenute, bensì per altre ragioni. Una, ad esempio, riguardava la possibilità di un collasso nell’amministrazione della giustizia: questo significava dover assumere una cifra spropositata di avvocati (equivalente ad un altissimo prezzo da pagare per le casse dello Stato), senza alcuna esperienza pratica o specializzazione e freschi di studi. Una seconda motivazione, sempre di natura economica, era l’enorme costo dei detenuti, delle detenute e dei bambini che vivevano con loro in prigione; nonostante i tagli delle risorse destinate alle carceri e le razioni di cibo sempre più scarse, le cifre per poterli mantenere rimasero da capogiro. La terza, ed ultima ragione, riguardava l’irrisolto problema delle rivolte, più o meno organizzate, che prendevano vita in quasi tutti i centri di reclusione; la situazione per le detenute stava diventando insostenibile e una diretta conseguenza del sovraffollamento era proprio la ribellione. Così, le autorità decisero di prendere seri provvedimenti al riguardo: dal 25 gennaio del 1940 iniziarono a commutare le pene più alte con altre inferiori. Già da prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, infatti, il sovraffollamento nelle carceri si ridusse sempre di più, non solo a causa di queste contromisure amministrative, ma anche, e soprattutto, per la morte, che non risparmiava i più deboli, ossia donne e bambini (Vinyes 2010: 25 – 32). Veniva dato loro da mangiare soltanto ogni 30/40 ore e la pietanza consisteva in una ciotola di brodo di rape e qualche buccia di patata. Erano molte le donne costrette a sopravvivere in quelle circostanze con i loro bambini, spesso malnutriti, malati, scheletrici e troppo deboli per riuscire a guarire anche da un semplice raffreddore. Il 1941 fu un anno terribile: secondo i pochi dati che ci sono rimasti, in quell’estate morirono 6/7 bambini ogni giorno solo a Ventas. Era impossibile che la situazione avesse margini di miglioramento, peggiorava a ritmo accelerato; le detenute erano consapevoli che il giorno dopo sarebbe stato ancora peggio di quello appena passato e che forse per loro sarebbe stato l’ultimo. Si addormentavano senza avere la certezza di risvegliarsi la mattina dopo o senza sapere se i loro bambini avrebbero superato la notte. Le condizioni disumane in cui riversavano i neonati e i bambini poco più grandi colpivano nel vivo le madri che, oltre a pensare alla propria sopravvivenza, dovevano occuparsi anche della salute dei loro figli, costretti a crescere in celle umide, maleodoranti e senza ventilazione, avendo, inoltre, a disposizione una razione di cibo estremamente scarsa e poco nutriente. Era totale la mancanza di acqua, e non solo quella potabile per poter dissetarsi: non c’era la possibilità di lavarsi o di lavare i panni sporchi dei propri bambini. Secondo alcune testimonianze, le madri erano addirittura obbligate, vista la drastica situazione, a far rindossare ai loro figli più piccoli i pannolini sporchi, che venivano solo stesi all’aria ad asciugare. È facile comprendere come potessero poi svilupparsi veri e propri contagi mortali: la dissenteria era una presenza quotidiana, per non parlare, poi, dei pidocchi, delle piattole e della scabbia. Gli odori all’interno delle celle erano insopportabili (Egido León 2011: 30). Inoltre, paradossalmente, la gestione delle misere razioni destinate alle detenute, gli scandalosi trattamenti che subivano in infermeria (in caso di malattia o di parto), e le severe punizioni, erano tutte prerogative di monache appartenenti ad alcuni ordini religiosi quali, ad esempio, “Las Hijas de la Caridad” o “Las Hijas del Buen Pastor”. È quindi possibile riscontrare un primo paradosso della dittatura franchista: quello di destinare donne di chiesa e di Dio e luoghi considerati sacri (soprattutto per un paese così cattolico come la Spagna) a scopi di violenza e di morte. Per completare il quadro sull’universo carcerario franchista, è importante procedere con una classificazione, poiché due grandi categorie differenziarono le detenute: coloro che vennero catturate anteriormente o posteriormente la vittoria di Franco. Le prime, che vennero arrestate in diverse circostanze di guerra, costituivano una massa eterogenea e caotica; tra loro erano presenti madri, mogli, figlie e sorelle di simpatizzanti della Repubblica esiliati, donne che avevano ricoperto importanti cariche nell’amministrazione pubblica, poi insegnanti, giornaliste e professioniste di vario tipo. Questa moltitudine costituì, insieme ai detenuti uomini, l’enorme massa carceraria spagnola dei primissimi anni successivi alla Guerra Civile. Coloro, invece, che furono catturate dopo, subirono violenze con uno scopo diverso, perché molto più mirato a estorcere informazioni efficaci per smantellare le deboli reti clandestine, estirpare ogni possibile sforzo di riorganizzazione antifranchista e localizzare la nascosta, ma vivace, guerriglia urbana. Per di più, le catturate dopo la vittoria di Franco ebbero la sfortuna di subire soprusi molto più crudeli e spietati, poiché la milizia e la Falange avevano avuto tutto il tempo per preparare nuove modalità volte a una sofferenza più sistematica. Un esempio è l’uso di scariche elettriche, come testimonia la detenuta Antonia García, allora sedicenne: avendo poco seno per la sua giovane età, le scariche furono applicate nelle orecchie, causandole la perdita di entrambi i timpani. Infine, a differenza delle anteriori, le seconde non ebbero più la possibilità di beneficiare degli indulti e furono giudicate da un nuovo apparato legale, costituito anche dal Tribunale Speciale per la Repressione della Massoneria e del Comunismo. Ma la natura mostruosa e inumana del regime è riscontrabile, soprattutto, nelle pratiche, strettamente connesse, di furti di neonati alle detenute e di adozioni illecite. Le conseguenze di queste prassi quotidiane all’interno delle prigioni sono tuttora tangibili: solo pochissimi bambini di allora, per sempre separati dalla propria madre biologica e dalla loro famiglia d’origine, ormai adulti, hanno avuto la fortuna di recuperare informazioni sul loro vero passato e sono riusciti a riabbracciare la propria madre o gli eventuali fratelli. L’insieme di questi casi costituisce una testimonianza concreta di una crudeltà senza limiti e di una ansante necessità di ricomporre il puzzle della propria identità.
«Nos sentimos como un árbol sin raíces, como amputados» (Musci 2011: 9).
Prima di tutto, al momento del parto, la prassi solitamente adottata prevedeva che la detenuta sarebbe dovuta essere isolata dal resto delle sue compagne di cella; le monache spiegavano che si trattava di una questione di intimità e di privacy, ma il vero motivo era nascondere, agli occhi di inaffidabili testimoni, la pratica che avrebbero attuato senza alcuna pietà, cioè quella di togliere immediatamente il neonato alla madre, convincendola che il bambino era nato morto e che non ci sarebbe stato più nulla da fare. Alle donne che subirono una privazione così importante non veniva concesso nemmeno un istante per poter tenere il proprio bambino tra le braccia, perché non era permesso che si stringesse alcun legame tra la madre e il nascituro. Dietro a questo abuso di potere intollerabile, c’era una subdola ragione esclusivamente politica: l’assoluta libertà con cui Franco si impossessava di neonati di detenute repubblicane o comuniste, gli permetteva di estirpare quasi totalmente quel “germe” nocivo di sinistra una volta per tutte. Dopo aver sottratto il bambino, che sicuramente sarebbe stato cresciuto con modelli, nozioni e idee avverse al regime, la sua intenzione era quella di plasmarlo, attraverso un’educazione estremamente cattolica, nazionalista e franchista, per dare vita a un perfetto cittadino spagnolo, difensore della Patria, della Chiesa e della dittatura. Il suo obiettivo era convertire tutti i piccoli “rojos” in sudditi fedeli e devoti. Riuscì completamente nel suo intento: il numero di tutti coloro che furono barbaramente strappati dalle braccia delle loro madri e dalle loro famiglie originarie è così mostruosamente alto da essere indeterminabile, anche perché i casi di chi scopre di essere in realtà un orfano, uno dei tanti figli persi di Franco, adottato in un secondo momento, si verificano ancora oggi in tutto il territorio spagnolo. Si tratta di uomini e di donne che trovano, dopo interminabili ricerche, la prova dell’inganno: il fatto che la loro vera madre, in realtà, fu una povera detenuta, che non volle abbandonarli di sua spontanea volontà, ma perché costretta dalle forze del regime. Il professore di storia contemporanea dell’università di Barcellona, Ricard Vinyes, è uno degli autori più competenti e accreditati riguardo al tema della repressione e della violenza franchista. In una delle sue più recenti pubblicazioni, egli affronta proprio la problematica della perdita fisica della famiglia, quella che lui chiama “zona de riesgo de pérdida familiar”, e l’impossibilità di avere qualsiasi tipo di notizie dopo l’avvenuta separazione. È esattamente quello che successe a migliaia di nuclei familiari, dilaniati per sempre dalla crudeltà del regime di Franco. Egli dedica un intero capitolo all’argomento, soffermandosi sul soffocante clima della prigione di San Isidro, nella provincia di Alicante, dove le madri e i loro bambini furono costretti a sopportare le più atroci angherie, ricatti e allontanamenti forzati. Questo spazio fu creato appositamente per tutte quelle madri che non avrebbero potuto separarsi dai loro bambini, troppo piccoli, mentre erano obbligate a scontare la pena, esattamente come la “Prisión Habilitada de Predicadores”, necessaria per smaltire la massa carceraria della prigione di Torrero, a Zaragoza. Qui, le madri e i loro bambini dormivano in celle separate; venivano sgarbatamente svegliati alle 7.00 ogni mattina per la prima preghiera del giorno. In generale, la permanenza permessa con il proprio figlio durava all’incirca soltanto un’ora, ma succedeva che venissero addirittura del tutto private di questo tempo prezioso in caso di punizione: questo rimedio aveva il crudele scopo di renderle innocue e molto più manovrabili, poiché nessuna di loro avrebbe voluto rinunciare al proprio bambino, anche solo per così poco tempo. I piccoli passavano tutto il pomeriggio all’aperto, sia che piovesse sia che nevicasse. Non venivano praticamente mai accuditi, cibati o dissetati, tanto che, a sera, il cortile era pieno di bambini infreddoliti e immobili, impossibilitati dal freddo o anche morti di dissenteria o di ipotermia. Le regole erano estremamente severe e le madri non avevano la facoltà di intervenire o di aiutarli. Questa separazione forzata, che richiama il paradosso della sbandierata maternità, era qualcosa di innaturale. Le istituzioni che rispondevano direttamente al Caudillo volevano tenere il bambino e la madre divisi il più possibile, con lo scopo ideologico e sociale di far crescere i piccoli secondo un’educazione che fosse contraria a quella che invece gli sarebbe stata impartita dalla loro madre biologica, da una “roja”. Franco ne fece un uso prettamente propagandistico, lanciando un messaggio di liberazione per tutti quei bambini “salvati” da una miseria non solo materiale, ma soprattutto morale; era convinto del fatto che i loro genitori, una volta terminato il loro processo di redenzione e rieducazione, sarebbero stati riconoscenti di questo provvedimento. Già nel 1942, il numero dei figli “messi al riparo” dalle grinfie dell’ideale repubblicano ammontava a 9.000 e nel 1943 la cifra salì a 12.000, di cui circa il 60% erano bambine (intorno alle 8.000). Solitamente, tutte le figlie femmine di detenuti erano destinate a centri religiosi e a monasteri. Il desiderio di controllo educativo della Chiesa era molto più evidente nei loro riguardi, perché molto più plasmabili. Alcune di loro, poi, crescendo, si rifiutarono addirittura di ritornare a casa o anche solo di rivedere i propri cari e decisero di entrare a far parte di quel mondo religioso che, in fondo, le aveva cresciute. Si fecero suore per uno scopo ben preciso: poter redimere i peccati dei propri genitori, che avevano agito contro il regime, la Chiesa Cattolica e Dio.
La scuola primaria sotto la dittatura franchista, in particolare negli anni 1939 – 1951, rappresentò uno dei tanti strumenti usati dal regime per portare a termine il tanto ambito progetto di ordine e di redenzione dell’intera società spagnola. Rispecchiando la sistemazione gerarchica e segregazionista di tutta la collettività, le classi non erano miste e alle bambine si impartiva un tipo di educazione e di insegnamento completamente diverso rispetto ai bambini. Per le bambine, infatti, la scuola costituiva una preparazione a tutto tondo su come avrebbero dovuto comportarsi da adulte, sugli atteggiamenti che avrebbero dovuto adottare in pubblico, ma soprattutto sulle mansioni domestiche di moglie e di madre che avrebbero dovuto adempiere all’interno del nucleo familiare. In pochissimi casi, bambini e bambine di campagna continuarono la loro formazione scolastica dopo i 13 o i 14 anni di età; coloro che abitavano nei piccoli borghi o nelle grandi città furono più fortunati, perché, essendo figli di artigiani o di piccoli imprenditori, ebbero la possibilità di accedere all’università. Una ferrea disciplina e un indottrinamento basato su numerosi e severi castighi erano i due pilastri su cui si basava la scuola di Franco: bastava veramente poco per essere puniti.
Ribellione femminile e lotta antifascista: Dolores Ibárruri
Nella disperazione dilagante delle carceri franchiste, però, non si perse mai la speranza e l’alternativa a rinunciare non venne nemmeno presa in considerazione: erano miliziane repubblicane, donne forti, abituate al sacrificio e al duro lavoro. Nessuna volle accettare inerme il proprio destino, senza per lo meno provare a impedirlo. Avevano tutte fatto parte della resistenza antifranchista durante la guerriglia insieme ai loro compagni esuli sui monti; avrebbero, quindi, continuato a farne parte anche in prigione. La resistenza, infatti, fu l’altra faccia della medaglia e il fenomeno diametralmente opposto alla repressione del Caudillo. Caratterizzata dalla determinazione, dal coraggio e dalla dignità femminili, cercava di soppiantare con un lungo processo di erosione gli infimi scopi del regime: l’annullamento fisico e mentale, la passività e la resa. Figura dinamica e poliedrica e simbolo universale della resistenza antifascista fu l’inarrestabile Dolores Ibárruri, politica, attivista e miliziana. Nel 1930, venne eletta nel Comitato Centrale del Partito Comunista Spagnolo. L’anno dopo si trasferì a Madrid, dove divenne editrice del quotidiano di sinistra Mundo Obrero e lavorò per il miglioramento della condizione femminile, ma a causa delle sue attività dichiaratamente anti-dittatoriali, venne arrestata e rilasciata spesso. Eletta alle Cortes parlamentari nel 1936, fece una campagna per il miglioramento delle condizioni lavorative, abitative e sanitarie. Con lo scoppio della Guerra Civile, il 19 luglio del 1936, diventò una vera e propria icona per l’intero popolo spagnolo, innalzando la sua voce in difesa della Repubblica con lo slogan diventato poi celebre: “¡No pasarán!”: «¡Obreros, campesinos, antifascistas y patriotas españoles! ¡Todos de pie para defender la República, las libertades populares y las conquistas democráticas del pueblo! ¡Que nadie vacile! Todos dispuestos para la acción. ¡Viva la unión de todos los antifascistas! ¡Los fascistas no pasarán! ¡No pasarán! » (Ibárruri 1936).
I suoi appelli internazionali alla lotta contro il fascismo rendevano la questione spagnola un problema mondiale: carichi di energia e di vivacità, i suoi discorsi, facilmente rintracciabili ancora oggi in alcuni siti di storia su internet, infiammavano ed esortavano all’azione intere folle, tanto da essere soprannominata “la Pasionaria”. Immediatamente il regime si affrettò a censurare con ogni mezzo l’intervento esortativo della Ibárruri, impedendo che qualsiasi traccia del suo discorso potesse sfuggire alle stampe, animando ancora una volta gli animi del popolo, che doveva essere lasciato totalmente all’oscuro da ogni influenza considerata scomoda per il progetto di Franco. Solo una minima percentuale di quotidiani di sinistra riuscì a spargere la notizia, al punto che la fama locale della Pasionaria, a poco a poco, raggiunse anche i Paesi stranieri, come la Francia, l’Italia e l’Unione Sovietica. Quando, nel 1939, cadde Madrid sotto i bombardamenti dell’esercito della Falange, Dolores esiliò in URSS, da dove continuò la sua azione politica e giornalistica. Nel 1944 divenne Segretario Generale del Partito Comunista Spagnolo, carica che conservò fino al 1960, quando assunse il titolo di Presidente del PCE e acquisì la cittadinanza sovietica. Ricevette, inoltre, una laurea honoris causa nel 1961 dall’Università di Mosca e il Premio Lenin per la Pace nel 1964. La sua autobiografia, No Pasarán, fu pubblicata nel 1966. Solo dopo la morte di Franco, questa donna forte, emblematica, carismatica e simbolo della resistenza riuscì a tornare in Spagna che, nel frattempo, non l’aveva mai dimenticata. Non fu l’unica a prendere la decisione di esiliare per salvare la propria vita e i propri ideali: moltissimi, come lei, fuggirono o furono costretti a farlo.
Bibliografia
Aguado, Ana; Verdugo, Vicenta (2011), Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar y reeducar, sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca.
Alonso Briales, Mariana; Grana Gil, Isabel (2009), La educación de las mujeres en Andalucía durante el franquismo a través de las historias de vida, in «Fundación Dialnet», vol. 2, Pamplona – Iruñea.
Barranquero Texeira, Encarnación; Eiroa San Francisco, Matilde (2011), La cárcel de mujeres de Málaga en la paz de Franco, sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca.
Barranquero Texeira, Encarnación (2009), Hambre, hacinamiento y doctrina: las presas en las cárceles de Franco durante la posguerra, sezione «Antifranquistas», in «AH: Andalucía en la Historia», anno VII, 25, Málaga.
Di Febo, Giuliana (2006), Resistencias femeninas al franquismo. Para un estado de la cuestión, in «Cuadernos de Historia Contemporánea», vol. 28, Roma, Universidad de Roma Tre.
Duch Plana, Montserrat (2011), Una perspectiva de género de la represión concentracionaria franquista a partir del caso de la cárcel de Las Oblatas de Terragona (1939 – 1943), sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca.
Egido León, Ángeles (2011), Mujeres y rojas: la condición femenina como fundamento del sistema represor, sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca.
Garrido Cárdenas, Pilar; Higueras Rodríguez, Lina (2013), El papel de la mujer en el Franquismo y en la democracia. Análisis comparativo entre épocas, in «ReiDoCrea. Revista electrónica de investigación Docencia Creativa», vol. 2, Granada.
Hernández Holgado, Fernando (2011), La prisión militante. Ventas (Madrid) y Les Corts (Barcelona), sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca.
Martins Rodríguez, María Victoria (2011), Cárceles y mujeres en Galicia durante el franquismo, sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca.
Molinero, Carme (2009), Entre el silencio y la invisibilidad. La mujer en los estados totalitarios, sezione «Heroínas invisibles», in «AH: Andalucía en la Historia», anno VII, 25, Barcelona.
Moreno Gómez, Francisco (2009), Guerrilleras y enlaces: las mujeres en la resistencia antifraquista, sezione «Heroínas invisibles», in «AH: Andalucía en la Historia», anno VII, 25, Sevilla.
Musci, Mónica Beatriz (2011), Niños adoptados, perdidos, robados en el franquismo. Las lecturas de la prensa española, in «Diálogos transatlánticos. Memoria del II Congreso Internacional de literatura y cultura españolas contemporáneas», vol. 2, Santa Cruz, Universidad Nacional de la Patagonia Austral.
Nash, Mary (2013), Represión, resistencias, memoria: las mujeres bajo la dictadura franquista, Granada, Comares Historia.
Romeu Alfaro, Fernanda (2002), El silencio roto. Mujeres contra el franquismo, Oviedo, El Viejo Topo.
Sánchez Sánchez, Pura (2009), Individuas y sujetas. Las andaluzas represaliadas por los tribunales militares, sezione «Heroínas invisibles»,
in «AH: Andalucía en la Historia», anno VII, 25, p. 16 – 19.
Sonlleva Velasco, Miriam; Torrego Egido, Luis (2014), La escuela primaria del primer franquismo desde las voces del alumnado segoviano: una iniciación en la investigación educativa, in «Tendencias Pedagógicas», 24, Valladolid, p. 285 – 306.
Vinyes, Ricard (2011), Doblegar y transformar: la industria penitenciaria y sus encarceladas políticas. Tan sólo un examen, sezione «Historia Contemporánea», in «España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones», 29, Salamanca, p. 35 – 54.
Vinyes, Ricard (2010), Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles fraquistas, Madrid, Temas de Hoy.
Sitografia
Bulot, Jean (2017), Dolores Ibárruri: “No pasarán!”, «Arte» (ultima consultazione: 30/11/2019).
«España Contemporánea: semestral de historia, cultura e instituciones» (ultima consultazione: 30/11/2019).