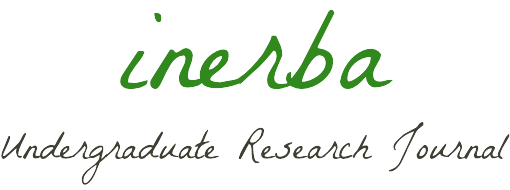Si traduce dall’edizione curata da Sumnikova, T. A. (2011).
Nel primo giorno del mese di agosto celebriamo Cristo pieno di misericordia e la sua purissima Madre
È bene che si sappia, amati fratelli, che nel giorno della grazia divina del Pantocratore celebriamo il nostro pio e devoto zar e principe Andrej, che istituì questa festa insieme all’imperatore Manuele per ordine del patriarca Luca, del metropolita di tutta la Rus’ Konstantin e del vescovo di Rostov Nestor.
Quando l’imperatore Manuele viveva in pace, amore e accordo fraterno con il nostro devoto principe Andrej, accadde che un giorno andarono in battaglia: quello da Costantinopoli contro i saraceni, questo da Rostov contro i bulgari. Il principe Andrej aveva un’usanza: quando andava in guerra, due presbiteri dall’anima pura vestiti in abiti sacerdotali portavano l’icona della nostra Signora Madre di Dio Semprevergine Maria e la croce. E mentre il principe e quelli che erano con lui prendevano dai santi misteri il corpo e il sangue del Signore, il principe disse «Madre di Dio, Padrona, che hai partorito Cristo Dio nostro, chiunque riponga in te la speranza non perirà. Io, tuo servo, ho te come riparo e protezione e la croce di tuo Figlio come arma potentissima contro i nemici e fuoco che brucia i volti degli avversari che vogliono fare la guerra con noi». E tutti caddero in ginocchio davanti all’icona della santa Madre di Dio e la venerarono con le lacrime. E allora, dopo essere partiti, presero quattro città bulgare e la quinta fu Brjachimov sulla Kama. Tornando dalla battaglia, tutti videro dei raggi infuocati provenire dall’icona del Salvatore Signore Dio nostro, e tutto il suo [del principe (n.d.t)] esercito ne era circondato. Il principe tornò indietro, annientò quelle città con il fuoco e rase al suolo quella terra, mentre costrinse con l’assedio altre città a pagare un tributo. Quella stessa visione la ebbe in quel luogo anche l’imperatore Manuele il primo giorno di agosto e stabilì di celebrare la grazia e la misericordia di Dio, come disse il profeta: «Userò misericordia con chi vorrò, e avrò pietà di chi vorrò averla» (cfr. Rm 9,15).
Così ora, Signore proteggi la terra della Rus’, tutte le tue genti che ripongono speranza in te. Per questo tutti ci prostriamo a te dicendo: «Signore Gesù Cristo, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (cfr. Mt 6,12).Giacché grande sei tu e meravigliose le tue opere, non c’è limite alla tua grandezza. Di generazione in generazione sono lodate le tue opere. Benedetto Signore Dio, che non ci hai dato in prigionia ai nostri nemici, tu stesso sorvegliaci con la tua grazia e difendici con la tua misericordia. Con la gloria hai innalzato alla destra coloro che ripongono speranza in te e, dopo aver ascoltato la preghiera di tua Madre, hai perdonato le tue genti con la grazia della tua misericordia. La Chiesa, Signore, si è riempita della tua gloria; l’hai mostrata come porta celeste in terra e in essa ti preghiamo dicendo: «Signore, sorvegliaci dal cielo, guarda e proteggi la tua vite e fai fruttare ciò che ha piantato la tua santa destra. Gli occhi di tutti, Signore, sono rivolti a te in attesa della tua grazia e della tua benevolenza. Intoniamo lodi e canti alla tua gloria. Dio dai molti nomi e Salvatore nostro, tu stesso glorifica coloro che ripongono speranza in te. Tu che hai per trono il cielo e poggi i piedi sulla terra, sorveglia con i tuoi occhi benevoli tutte le genti che ripongono speranza in te, nella tua Purissima Madre e in tutti i santi che hanno sofferto nel tuo nome per noi peccatori, che innalziamo a te questa supplica».
Io scrissi questo su ordine dell’imperatore Manuele e di tutti i ministri della Chiesa, affinché nel primo giorno del mese di agosto celebrassimo tutti insieme nella gloria della santa Trinità. Amen.
Questo successe nel 6672 (1064).
Andrej, con suo figlio Izjaslav, con suo fratello Jaroslav e con il principe di Murom Jurij, li aiutarono Dio e la santa Madre di Dio contro i bulgari: e [i bulgari] fecero cadere in quantità e presero i loro vessilli, il principe bulgaro riuscì a stento a scappare con la piccola družina fino alla Grande Città e i cristiani conquistarono le loro gloriose città. Andrej se ne andò vittorioso dopo aver visto i bulgari pagani sconfitti e la sua družina del tutto illesa. I fanti stavano sul campo di battaglia con l’icona della santa Madre di Dio sotto i vessilli. E avanzò il principe con tutta la družina fino alla santa Madre di Dio e ai fanti, si inchinò a lei con grande gioia e le rese lodi e canti.
Questo fu un nuovo miracolo dell’icona della santa Madre di Dio di Vladimir che il principe Andrej aveva preso con sé da Vyšgorod [Vyshorod] e che portò con gloria e collocò nella Chiesa dalle cupole d’Oro a Vladimir, dove si trova tutt’ora.
Sui miracoli dell’icona della santissima Madre di Dio di Vladimir
Così come Dio ha creato il sole ma non lo ha collocato in un solo luogo, e risplende, girando intorno a tutto l’universo, lo illumina con i suoi raggi, allo stesso modo anche questa immagine della nostra santissima Signora Madre di Dio Semprevergine Maria non elargisce i miracoli e i doni di guarigione in un solo luogo, ma, visitando tutti i paesi del mondo, li illumina e li libera dalle varie disgrazie.
Quando il principe Andrej volle regnare nella terra di Rostov, iniziò a interessarsi alle icone. Gli raccontarono dell’icona della nostra santissima Signora Madre di Dio nel monastero femminile a Vyšgorod che per tre volte si era mossa dal suo posto: la prima volta quando entrarono in chiesa e la videro là in mezzo che si reggeva da sola; e la collocarono in un altro luogo. La seconda volta la videro con il volto rivolto all’altare e dissero: «Vuole stare nell’altare», e la spostarono dietro la mensa. La terza volta la videro che si reggeva da sola, sospesa sopra la mensa. E si erano verificati anche numerosi altri miracoli.
Udito ciò, il principe Andrej si rallegrò, si recò nella chiesa e iniziò a cercare con gli occhi tra le immagini l’icona che le superava tutte. Dopo che la ebbe vista, si gettò a terra, pregando e dicendo: «O santissima Deipara, Madre di Cristo nostro Signore, se vuoi essere mia protettrice nella terra di Rostov, fai visita ai neobattezzati e tutti faranno la tua volontà».
E così, presa l’icona, si diresse nella terra di Rostov. Prese con sé anche il coro e durante il cammino trovò un uomo che gli facesse da guida. Arrivato al fiume Vazuza, vide che era esondato e mandò l’uomo nel fiume a cercare un guado. Ma quando costui entrò nel fiume a cavallo, affondò. Allora il principe iniziò a pregare rivolto all’icona della nostra santissima Signora Madre di Dio Semprevergine Maria: «Sarò io colpevole della sua morte, o Signora, se non lo salvi». E così accadde: dopo molte preghiere, ecco che all’improvviso dalle profondità del fiume emerse l’uomo a cavallo e, aiutandosi con una verga, riuscì a raggiungere la riva. Alla vista dell’uomo il principe si rallegrò e dopo averlo ricompensato, lo congedò.
Questo fu il primo miracolo della santissima Madre di Dio.
Miracolo secondo
Quando il principe era sui campi di Rogoža, la moglie del pope Mikula era in viaggio su un carro con sua nuora. Arrivate presso una sorgente, scesero dal carro [per rifocillarsi (n.d.t.)], giacché la moglie del pope era incinta. Quando vollero oltrepassare il cavallo, però, il diavolo si impossessò di lui: disarcionò il cocchiere, gli ruppe una gamba e colpì la moglie del pope Mikula con le zampe anteriori, così che gli zoccoli del cavallo rimasero impigliati nella pelliccia della donna, che fu morsa dal cavallo più volte. Pensarono che fosse morta e fecero arrivare la notizia al pope Mikula: «Tua moglie è morta». Egli, avendo rivolto lo sguardo all’icona della santissima Madre di Dio, disse: «Signora, Purissima Padrona, solo tu puoi liberarla dalla morte, poiché lei è già morta». E il cavallo, liberati gli zoccoli dalla pelliccia, fuggì nel bosco e, bloccato dalla fitta boscaglia, si fermò. Chiesero alla moglie dell’attacco subito da parte del cavallo, e quella rispose così: «Sono salva grazie alle preghiere della santissima Madre di Dio. Mi dispiace solo per il fazzoletto e per il copricapo [che indossavo (n.d.t.)] che il cavallo si è mangiato».
Giunto a Vladimir il devoto principe Andrej edificò una chiesa in nome della santissima Madre di Dio e, dopo averla decorata con la massima devozione, vi collocò l’icona taumaturgica della nostra santissima Padrona Madre di Dio.
Miracolo terzo
Trascorso un po’ di tempo, un uomo fu colto da malattia. A causa di tale malattia perse la parola e gli si rinsecchì la mano. Riavutosi, iniziò a fare segni con la mano sana. Capirono che voleva andare da San Nicola; nelle vicinanze, infatti, c’era la chiesa del santo. E lo condussero da San Nicola, ed egli fece cenno di passare oltre, ma non lo capirono. Allora si diresse da solo in città dalla santa Madre di Dio. Giunse nella chiesa della santa Madre di Dio al mattutino e si fermò di fronte all’altare, ma al termine del mattutino cadde. Pensarono che fosse caduto a causa della malattia che lo affliggeva. Lo portarono nell’atrio, e lì rimase sdraiato fino alla liturgia e, quando riuscì ad alzarsi, iniziò a raccontare che aveva visto la santa Madre di Dio spostarsi dal suo posto e andare verso di lui. E disse ancora: «L’ho vista vicino a me e sono caduto, e non ho visto più nulla». Nessuno conosceva quell’uomo.
E iniziarono a intonare la santa liturgia. Egli entrò in chiesa e cominciò a pregare rivolto all’icona della santissima Madre di Dio. E quando fece per baciare l’icona della nostra santissima Signora e Padrona e tese verso di lei la mano malata, la santa Signora Madre di Dio lo prese con la sua mano; furono testimoni di ciò il principe Andrej, il pope Nestor e la moltitudine delle persone che erano in chiesa. Questo accadde durante la liturgia. Il pope Nestor chiamò il coro e diede ordine di indossare l’abito liturgico. Dopo aver preso le croci, fecero il giro della chiesa per tre volte. Egli sedeva in chiesa. Il pope celebrò l’evento, chiamò a sé il principe con i boiari e colui che era guarito e, dopo aver omaggiato quest’ultimo con doni, lo congedò. E ci fu grande gioia quel giorno a Vladimir.
Miracolo quarto
Trascorso un po’ di tempo, nel giorno della festa della Signora, il principe Andrej si trovava in chiesa per il canone, intonando cori, ma in cuor suo si doleva per sua moglie, che da due giorni era in travaglio. Dopo il canone aspersero con l’acqua l’icona della santissima Madre di Dio, ed egli fece recapitare quella stessa acqua alla principessa. Ella ne prese un sorso e diede alla luce un infante sano e lei stessa si riprese subito per le preghiere della santa Madre di Dio.
Miracolo quinto
Qualcuno, su istigazione del diavolo, compì malìe su un uovo. E un fanciullo lo prese e lo mangiò. E sull’occhio gli spuntò un grosso orzaiolo, che dall’occhio si spostò come una nuvola e gli ricoprì il volto. E alcuni dicevano: «Il giovane morirà», mentre altri dicevano: «Perderà l’occhio». Dopo aver asperso con l’acqua l’icona della santa Madre di Dio, gli portarono quell’acqua. E quando lo cosparsero con quell’acqua, la malattia lo abbandonò ed egli guarì, e l’occhio rimase integro.
Miracolo sesto
A Murom una donna soffriva di una malattia al cuore. Aveva sentito parlare dei miracoli compiuti dall’icona della santa Madre di Dio. Fece recapitare nella chiesa di Vladimir un’ampolla, affinché prendessero l’acqua dall’icona della santa Madre di Dio. E quando le portarono l’acqua, ella ne prese un sorso e guarì, smise di soffrire di cuore.
Miracolo settimo
A Perejaslavl’, nella Rus’, nel monastero di Slavjatin, si fece monaca la figlia di Židislav, di nome Marija. Per la vita virtuosa le affidarono l’egumenato nel monastero fondato da suo nonno. E fu colpita da una malattia agli occhi e non riusciva più a vedere. Ella inviò il pope da suo fratello Boris. Boris chiese di sua sorella, e quello rispose: «È stata colpita da una malattia agli occhi e non riesce più a vedere. Sono già tre anni che ha bisogno di assistenza». Boris, chiamato il pope di nome Lazar’, lo pregò: «Aspergi l’icona della santa Madre di Dio con dell’acqua e portamela». Il pope andò e gli portò l’acqua. Boris, avendo raccolto quell’acqua santa in un’ampolla e avendola sigillata con la cera, la fece recapitare a Perejaslavl’ nella Rus’ a sua sorella. Dopo essere arrivato, il pope le raccontò dei miracoli compiuti dall’acqua della santa icona. Ella in cuor suo si rallegrò e gli chiese: «Quando mi porterai questa acqua?». Il pope rispose che l’acqua l’aveva già con sé. Ella ne prese un sorso, si cosparse con quella gli occhi e subito riacquistò la vista, come se non si fosse maiammalata. Questo fu un grande miracolo dell’icona della santa Madre di Dio di Vladimir.
Miracolo ottavo
Questo nuovo miracolo dell’icona della santa Madre di Dio, invece, accadde a una donna di nome Evfrosinija. Questa donna, che soffriva di cuore da sette anni, aveva cercato la guarigione presso molti, ma non l’aveva trovata. Chiamò il pope Lazar’ e gli disse: «Cosa potrebbe aiutarmi contro questa malattia?». Il pope rispose: «Se non ti libererà la santa Madre di Dio, questa malattia non ti risparmierà». E quella, avendo udito dal pope dei miracoli compiuti dall’acqua dell’icona della santissima Madre di Dio, gli affidò orecchini e gioielli d’oro, affinché li offrisse all’icona della santa Madre di Dio a Vladimir, dicendo: «Che mi portino quell’acqua santissima». E quando gliela portò, ne prese un sorso, e da quel giorno guarì dalla malattia, iniziò a mangiare e a bere con piacere.
Miracolo nono
Questo miracolo invece accadde a Tver’. Una donna era in travaglio da tre giorni. Arrivò il pope Lazar’ e si fermò da lei. Quella domandò al pope come stava. Egli rispose: «Siamo in salute, ma non tutti: la nostra boiarina è in fin di vita». Dopo queste parole, giunse da parte sua il messaggio: «O padri, andate. Mi sto pentendo [dei miei peccati (n.d.t)] perché sono prossima alla morte». Il pope Lazar’ le rispose: «Se non farai voto alla santa Madre di Dio di Vladimir, non ti salverai». Ella promise di farlo e disse al pope: «Andatevene di qui». E ordinò di offrire loro cibo e bevande. Ed ecco che giunse da parte sua la notizia che aveva già partorito un figlio e che lei stessa era in salute. E fece recapitare, come aveva promesso, i suoi orecchini e gioielli d’oro all’icona della santa Madre di Dio a Vladimir.
Miracolo decimo
Il nobile principe Andrej fece realizzare le Porte d’Oro per la festa della santa Vergine e disse ai boiari: «Quando le persone si riuniranno per la festa, vedranno le Porte».
Il giorno della festa il popolo si riunì presso le Porte. La calce con cui erano state murate non si era ancora asciugata. All’improvviso, le Porte si staccarono dal muro, crollarono sulle persone e ne schiacciarono dodici.
Avendo udito questo, il principe Andrej iniziò a pregare con fervore rivolto all’icona della santissima Madre di Dio, dicendo: «Signora, Padrona purissima, se non salvi quegli uomini, io, peccatore, sarò responsabile della loro morte». E dispose che la sua boiarina provvedesse a tutto quanto era necessario per le vittime. Egli, invece, giunto sul posto, sollevò le Porte e vide che tutti coloro che erano rimasti sotto di esse erano vivi e incolumi. E avendo visto questo miracolo, la popolazione si meravigliò.
Sull’icona della Madre di Dio Odigitria
Icona della santa Madre di Dio. L’icona della santa Madre di Dio fu dipinta dall’evangelista Luca e ancora oggi la portano ogni martedì al monastero, affinché compia miracoli di guarigione per coloro che vi si recano con fede.
Un monaco pregava assiduamente la santa Madre di Dio, dicendo: «Signora, mostrati a me come eri nella carne». E udì una voce che diceva: «Vai nella chiesa apostolica e mi troverai raffigurata nell’altare vicino alla croce. Tale ero nella carne».
Un tempo a Costantinopoli ci fu l’iconoclastia. Allora portarono l’icona della santa Madre di Dio Odigitria al monastero del Pantocratore e la nascosero nell’altare in un’intercapedine del muro e accesero lì davanti una lampada. Gli iconoclasti governarono a Costantinopoli per sessant’anni. Dopo si riaffermò l’ortodossia. Allora si misero a cercare l’icona della santa Madre di Dio e il patriarca ordinò di pregare in tutti i monasteri e in tutti gli eremi. E apparve in sogno a un eremita: «Cercate», disse, «l’icona della santa Madre di Dio nel monastero del Pantocratore». E la trovarono. E la lampada, che in sessant’anni non si era spenta, è ancora accesa. Gli ortodossi si rallegrarono alla vista dell’icona della santa Madre di Dio.
La discendenza di Luca officia tutt’ora davanti a questa icona.
Sulla veste
La veste della santa Vergine e un frammento della cintola sono nel santuario delle Blacherne.
Una volta giunsero dei militi via terra e via mare. Il patriarca Sergio immerse la veste della santa Madre di Dio in mare, il mare si increspò e fece annegare i militi, mentre altri furono accecati e fuggirono per il terrore.
Commento alla traduzione1
Introduzione
Nel presente commento ci proponiamo di analizzare e spiegare alcune delle scelte traduttive che sono state fatte per la resa di espressioni o termini culturospecifici, che per definizione non hanno un traducente esatto in italiano. Abbiamo tradotto il testo dallo slavo ecclesiastico, aiutandoci di tanto in tanto con la traduzione russa. Il nostro obiettivo è stato quello di restituire il testo di partenza cercando di mantenere, per quanto possibile, gli elementi specifici della cultura slava ortodossa, il registro di lingua e la struttura sintattica del testo, senza tuttavia precluderne l’accessibilità a chi non abbia familiarità con i temi trattati e, essendone incuriosito, voglia avvicinarvisi.
Il Racconto dei miracoli dell’icona della Madre di Dio di Vladimir appartiene alla tradizione scrittoria del medioevo slavo orientale. In area slava ortodossa per il periodo medievale con “letteratura” si intende l’intera produzione scrittoria, la quale è esclusivamente ecclesiastica. In questo tipo di letteratura il concetto di autorialità in senso moderno non emerge perché il testo non è il frutto della creatività di un individuo, ma è la testimonianza del compiersi del ruolo provvidenziale della Rus’. La produzione libraria ha luogo nelle comunità monastiche e quindi l’autore è molto spesso un monaco poiché possiede capacità scrittorie.
Si tratta di un testo databile tra il XV secolo e il XVII secolo e si trova in otto codici manoscritti: il codice Egorovskij, su cui si basa l’edizione dalla quale abbiamo tradotto, databile tra gli anni ’60 e ’70 del XV secolo; il codice Sofiskij degli anni ’30 del XVI secolo; il codice Tolstovskij della seconda metà degli anni ’30 del XVI secolo; il codice Uspenskij della fine degli anni ’40 del XVI secolo; il codice Šibanovskij degli anni compresi tra il 1549 e il 1578; il codice Carskij della metà degli anni ’50 del XVI secolo; il codice Miljutinskij degli anni 1646-1654; il codice Akademičeskij del XVII secolo (Sumnikova 2011: 19-20).
Nel testo slavo viene indicata la data del 6672 come anno in cui viene istituita la festa di Cristo e della Madre di Dio. Questo anno corrisponde al 1064 secondo il computo del tempo a partire dalla nascita di Cristo. Questa differenza si basa sul fatto che il calendario slavo, come quello bizantino, inizia a contare gli anni dalla presunta data di creazione del mondo, e non dall’anno della nascita di Cristo. Nella traduzione italiana abbiamo deciso di specificare tra parentesi la data secondo il computo più familiare al lettore italiano per una maggiore chiarezza.
Nella traduzione del testo abbiamo riscontrato alcune difficoltà nella resa di termini appartenenti alla tradizione ortodossa, per i quali la ricerca di corrispondenti nella tradizione latina è spesso fuorviante. Una delle strategie che più abbiamo utilizzato per ovviare al problema dell’intraducibilità di tali termini e per garantire la fruizione anche a un lettore non specializzato è stata quella della generalizzazione (Osimo 2011: 283).
Nel presente commento andremo ad analizzare, in questo ordine, i termini relativi all’architettura delle chiese, gli epiteti riferiti a Dio e alla Madre di Dio, la questione delle citazioni bibliche, l’onomastica e la toponomastica presenti nel testo e alcuni termini relativi alla cultura materiale slava orientale.
Elementi architettonici delle chiese ortodosse
Gli elementi architettonici delle chiese pongono una sfida interessante dal punto di vista traduttivo: i traducenti esatti di alcuni termini rischiano di essere poco noti a un lettore che non possieda il lessico tecnico-specialistico proprio di questo ambito. Anche quando un termine sembrerebbe avere un corrispondente esatto in italiano, bisogna sempre verificare se nella lingua e cultura di arrivo il significato effettivamente coincida con quello della lingua e cultura di partenza. Per queste ragioni, ai traducenti di difficile comprensione o ambigui nella ricezione abbiamo preferito termini più comuni, evitando così anche il ricorso alle note a piè di pagina che avrebbero appesantito la lettura. Prima di discutere più in dettaglio gli elementi architettonici per i quali abbiamo riscontrato maggiori difficoltà, è utile descrivere brevemente la struttura architettonica di una chiesa ortodossa.
Le chiese cristiano-ortodosse hanno una pianta a croce greca, che si inscrive in un quadrato con una cupola principale, in cui navata e transetto si intersecano a metà della loro lunghezza. La pianta è prolungata sul lato orientale tramite una abside generalmente suddivisa in altre due aree più piccole e verso occidente attraverso il nartece («vestibolo, parte riservata ai catecumeni e ai penitenti»2) e l’esonartece («vestibolo più esterno, corrispondente al braccio anteriore dell’atrio a quadriportico»3) (cfr. cerkov’ in Roty 1983).
Di seguito sono riportati i termini per cui abbiamo riscontrato maggiori difficoltà da un punto di vista traduttivo:
- Trjapeza/trapeza: il Dictionnaire russe-francais des termes en usage dans l’Eglise russe riporta queste accezioni: la prima è quella di tavolo monastico, dove i monaci consumano i pasti in comunità; la seconda è quella di refettorio. Può riferirsi però anche alla parte occidentale della chiesa, fra navata e nartece, dove si celebra l’Eucaristia (cfr. trapeza in Roty 1983). A noi interessa l’ultima accezione che il dizionario elenca, ovvero quella di «tavola sacra», cioè il tavolo quadrato in pietra situato al centro dell’altare, spesso ricoperto da un baldacchino. Per tradurre questo termine abbiamo utilizzato il dizionario paleoslavo-greco-latino a cura di F. Miklosich (1862-1865): alla voce trapeza il termine latino corrispondente all’accezione che qui ci interessa è mensă. Consultando il dizionario latino-italiano Olivetti online, notiamo che la settima accezione della voce mensă è: «tavola dell’altare per i sacrifici». Nel dizionario italiano Il Nuovo de Mauro online, mensa, nella quarta accezione, è «il piano marmoreo dell’altare, su cui il sacerdote compie i riti dell’Eucaristia». Il Vocabolario Treccani, invece, alla terza accezione della voce mensa, riporta questa definizione: «nella liturgia cattolica, la parte superiore dell’altare, generalmente costituita da una lastra orizzontale di pietra (o di marmo) nel cui incavo centrale si trova il sepolcreto con alcune reliquie di martiri e sulla quale il sacerdote celebra il sacrificio eucaristico; ma nella letteratura cristiana antica il termine fu variamente usato anche per indicare sia l’Eucaristia stessa, sia un altare eletto sulla tomba di un martire, sia la tomba stessa». Abbiamo ritenuto quindi opportuno adottare il termine mensa.
- Altar’/Oltar’: è la parte della chiesa situata oltre l’iconostasi («nelle chiese greche di rito ortodosso è una parte con tre porte che separa il presbiterio dallo spazio riservato ai fedeli»4). L’altar’ è composto da tre absidi al cui centro troviamo la mensa, spesso coperta da un baldacchino. Dietro la mensa ci sono un candelabro a sette bracci, una grande croce e un’icona della Vergine (cfr. altar’/oltar’ in Roty 1983). Anche se la traduzione sembra immediata, è opportuno cercare questo termine in Miklosich (1862-1865): alla voce ol’’tar’, troviamo proprio il latino altare. La nostra scelta, quindi, è ricaduta sul sostantivo corrispondente italiano altare che usiamo però non nell’accezione di mensa, ma per indicare la parte della chiesa situata oltre l’iconostasi.
- Pritvor’’: si tratta di un elemento architettonico diffuso anche nell’architettura occidentale conosciuto con il nome di nartece. È un vestibolo della chiesa, sui cui banchi sedevano i penitenti e i catecumeni, ai quali era vietato l’accesso alla navata. Oggi è utilizzato come oratorio dai monaci, mentre il clero e i fedeli vi si recano in processione durante i vespri dei giorni di festa (cfr. pritvor in Roty 1983). Miklosich (1862-1865) traduce questo termine con il latino portĭcŭs. Nel dizionario Olivetti, la traduzione italiana riportata è «atrio». Essendo un sostantivo di immediata comprensione, la nostra scelta è ricaduta su questo traducente.
Epiteti riferiti a Dio e alla Madre di Dio
Passiamo ora ad analizzare gli epiteti riferiti a Dio e alla Madre di Dio. Come già accennato, nel testo sono presenti vari termini specifici della tradizione ortodossa che si riferiscono a Dio o alla Madre di Dio. Alcuni di questi richiedono un’attenzione particolare nella traduzione, poiché si rischia di incorrere in imprecisioni o in interpretazioni sbagliate (in presenza di differenze dottrinali). In particolare, richiedono una spiegazione più accurata i termini: Pantokrator (riferito a Dio); Bogorodica, Vladyčica, Gospoža, stena e pokrov’’ (riferiti alla Madre di Dio).
Per la traduzione di questi epiteti e attributi abbiamo fatto riferimento agli studi di M.C. Ferro e F. Romoli (Ferro, Romoli 2013; Ferro, Romoli 2014), che hanno messo in evidenza proprio la difficoltà di tradurre i testi della tradizione slava ecclesiastica per l’assenza di strumenti adeguati (Romoli 2016: 26). Questa assenza rende necessario l’uso di dizionari generalisti, che però, come vedremo nel corso della nostra analisi, spesso sono fuorvianti o non adatti a spiegare termini dell’ambito in questione (Ferro, Romoli 2013: 237). Da qui è nato il progetto, tuttora in corso, volto alla redazione di un lexicon paleoslavo-slavo ecclesiastico-russo-italiano, che raccolga termini religiosi e filosofico-teologici (Romoli 2016: 26).
Per una descrizione accurata del metodo utilizzato da Ferro e Romoli per analizzare e rendere in italiano il significato di tali termini, si rimanda agli articoli citati. L’applicazione di tale metodo da parte nostra prevede delle semplificazioni per ragioni di competenza5. La ratio dietro il lavoro svolto è, comunque, la seguente: quando ci siamo trovate di fronte a un appellativo o a un epiteto riferiti a Dio o alla Madre di Dio, abbiamo effettuato una ricerca sui dizionari di slavo ecclesiastico, quali Miklosich (1862-1865) e Sreznevskij (1893-1912), che forniscono una traduzione in latino e in greco (Sreznevskij anche in russo); ci siamo poi rivolte al dizionario monolingue russo Tolkovyj slovar’ živago velikoruskago jazyka. Vladimira Dalja per un ulteriore riscontro. Raccolte tutte le informazioni necessarie, abbiamo scelto caso per caso un traducente che fosse adatto al contesto e al registro di lingua del testo.
L’appellativo di Dio Pantokrator’ (Pandokrator’) non è presente nei dizionari Miklosich (1862-1865) e Sreznevskij (1893-1912), tuttavia Miklosich (1862-1865) presenta il lemma Pan’’dokratorov’’, aggettivo per il quale restituisce l’equivalente latino pantocratoris. Consultando il Vocabolario Treccani si trova la voce Pantocratore che chiarisce l’origine greca del termine e restituisce come prima definizione «che può tutto, onnipotente». Per non distaccarci dal testo originale abbiamo deciso di tradurre Pantokrator’ con il termine italiano Pantocratore, certo di lessico alto, ma comunque adatto al contesto, piuttosto che ricorrere a parafrasi quali che tutto può, che tutto domina o al traducente Onnipotente che è più vicino al termine latino (Ferro, Romoli 2013: 239-240).
Per quanto riguarda l’appellativo Bogorodica i principali traducenti sono Madre di Dio, Vergine, Deipara, Teotoco. Abbiamo optato per l’utilizzo di Madre di Dio in quanto si tratta di un termine etimologicamente simile all’originale e che è adatto a tutti i contesti in cui appare nel testo. Solo in un’occorrenza abbiamo tradotto Bogorodica con Deipara per evitare delle ripetizioni che avrebbero eccessivamente appesantito il testo. Da evitare, invece, il termine Madonna in quanto si tratta di un attributo di tradizione latina utilizzato esclusivamente nella religione cattolica (Ferro, Romoli 2014: 100).
I termini Vladyčica e Gospoža sono simili nel significato, per entrambi infatti i dizionari restituiscono il traducente Signora. Miklosich (1862-1865) fornisce inoltre la traduzione latina domina. In questo caso abbiamo deciso di alternare le traduzioni Signora e Padrona a seconda del contesto (Ferro, Romoli 2014: 101-102).
Il termine stena, che letteralmente significa muro, è in generale utilizzato in modo metaforico come attributo della Madre di Dio, per sottolineare il suo carattere di difesa e baluardo dei fedeli. Abbiamo optato per la traduzione riparo in quanto si tratta di un termine generico adatto al contesto in cui appare (Ferro, Romoli 2014: 110-111).
Il discorso è un po’ più articolato per il termine pokrov’’. Questo, infatti, indica il manto indossato dalla Madre di Dio. Il riferimento è a un miracolo compiuto dalla Madre di Dio nel 902 d.C. Costantinopoli era sotto assedio e durante una funzione liturgica Andrea Salos (anche noto come il folle in Cristo) ebbe una visione della Madre di Dio che copriva i fedeli in preghiera con il suo manto. In memoria di questo miracolo fu anche istituita una festa liturgica. Il manto rappresenta quindi la protezione della Madre di Dio nei confronti dei fedeli. Per questo motivo abbiamo scelto di tradurre pokrov’’ con il termine più generico protezione, in quanto in italiano non esiste un traducente specifico che si rifaccia al miracolo in questione (Ferro, Romoli 2014: 106-107).
Citazioni bibliche
I testi che appartengono alla letteratura slava medievale sono ricchi di citazioni bibliche che spesso sono dirette, cioè sono segnalate al lettore nelle edizioni moderne tra virgolette e da speciali marcatori nel testo. In questo caso, chi scrive non nasconde di fare riferimento al testo biblico. Nell’introduzione ai miracoli, infatti, troviamo due riferimenti biblici: una citazione diretta da Rm 9,15 e un riferimento che richiama Mt 6,12. L’uso delle citazioni bibliche è finalizzato a creare un doppio livello di lettura: il primo corrisponde al significato letterale, il secondo al livello anagogico (Picchio 1977; Garzaniti, Romoli 2013). Per tradurre queste citazioni abbiamo prima svolto un lavoro di ricerca nella Bibbia russa6, sempre tenendo conto che chi scriveva citava spesso a memoria, e che pertanto si basava sulle proprie reminiscenze del testo biblico (ricordiamo che la prima Bibbia completa in slavo risale al XV secolo). Questo implica che le citazioni che troviamo nei testi non corrispondono in maniera letterale alle versioni attualmente in circolazione della Bibbia. Una volta individuata la citazione nella Bibbia russa, ci siamo servite della versione italiana secondo la Bibbia di Gerusalemme.
Onomastica e toponomastica
Passiamo ora a considerare il modo in cui abbiamo trattato l’onomastica e la toponomastica in traduzione.
Per quanto riguarda i nomi propri abbiamo distinto tra nomi di tradizione slava e nomi di tradizione greco-bizantina. Come è consuetudine fare, abbiamo traslitterato i primi (in ordine alfabetico: Andrej, Boris, Evfrosinija, Izjaslav, Jaroslav, Jurij, Konstantin, Lazar’, Marija, Mikula, Nestor, Židislav) e tradotto i secondi (Luca, Manuele).
La stessa convenzione è stata applicata ai nomi dei luoghi. Abbiamo infatti tradotto il nome della città di Costantinopoli e il Santuario delle Blacherne, mentre abbiamo traslitterato i nomi delle città di Rostov, Murom, Vladimir, Rogoža, Perejaslavl’, Tver’ e del fiume Vazuza, per i quali manca un corrispettivo italiano; laddove però fosse presente un termine italiano, come nel caso di Moskva (Mosca), sarebbe buona norma adottarlo.
Alcuni luoghi menzionati nel testo hanno cambiato nome nel corso dei secoli o non esistono più (in particolare Brjachimov sulla Kama e Višgorod, oggi Vyshorod, indicato tra parentesi quadre nel testo). In questo caso abbiamo deciso di utilizzare e traslitterare la denominazione presente nell’originale (quindi quella che i luoghi avevano in passato) piuttosto che inserire il nome odierno. Questa scelta si rifà all’intenzione di mantenere un’accuratezza storica nella traduzione.
La Chiesa dalle cupole d’Oro (Zlatoverchaja cerkov’) di cui si parla nel testo è la Cattedrale della Dormizione di Vladimir (Uspenskij sobor). Pur esistendo dunque una denominazione ufficiale della cattedrale, abbiamo preferito restare aderenti al testo e tradurre Chiesa dalle cupole d’Oro.
Anche per quanto riguarda le Porte d’Oro (Zolotye vorota) della città di Vladimir abbiamo deciso di tradurre rimanendo aderenti al testo originale invece di traslitterare il nome, poiché questo sarebbe rimasto oscuro ad un lettore che non conosca il russo. Inoltre, si tratta di un monumento che ha una denominazione anche in italiano.
Cultura materiale
Come accennato in precedenza, anche nell’ambito della cultura materiale incontriamo diversi termini slavi che non trovano corrispondenza in italiano.
Nel secondo miracolo vengono menzionati alcuni capi d’abbigliamento della moglie del pope: kortel’, otlog’’ e uvisla.
Prima di analizzare questi termini, è però necessaria una precisazione a proposito della «moglie del pope»: se il termine pope è entrato nella lingua italiana da diversi secoli7, il termine popad’ja non ha un traducente specifico, e dev’essere reso, appunto, con questa perifrasi esplicita.
Per quanto riguarda kortel’, dalla definizione che ne dà Sreznevskij (1893-1912), ricaviamo che si tratta di un soprabito femminile, foderato di pelliccia. Nel caso degli altri due termini, per avere un’idea più chiara del tipo di indumento a cui si riferiscono, abbiamo effettuato un confronto con il testo russo: qui vengono tradotti rispettivamente con bašlyk (un tipo di copricapo8) e ubrus (una sorta di fazzoletto, di foulard9). Seguendo la strategia di generalizzazione, abbiamo proposto i termini pelliccia, copricapo e fazzoletto.
Nei miracoli sesto e settimo abbiamo incontrato delle difficoltà nella resa dei termini che designano alcuni oggetti. Per quanto riguarda kuzn’, se la traduzione latina data in Miklosich (1862-1865) è piuttosto generica («res e metallo cuso factae»), nel testo russo abbiamo la perifrasi kovanye ukrašenija, dove ukrašenija fa pensare a degli elementi ornamentali. Se è chiara la componente metallica dell’oggetto (a cui allude l’aggettivo kovanyj), dal contesto si deduce che si tratta di un recipiente, magari un’ampolla, poiché viene usato per prendere dell’acqua.
Il termine voščanica, invece, nello Slovar’ drevnerusskogo jazyka (XI-XIV vv.), è definito come «nebol’šoj sosud iz voska» («piccolo recipiente di cera»), mentre Miklosich (dove viene riportato come voštanica) fornisce il corrispondente latino «vas inceratum» (1862-1865). La traduzione latina consente di farsi un’idea più chiara dell’oggetto: trattandosi di un recipiente per raccogliere liquidi, è verosimile, però, che sia sigillato con la cera, piuttosto che fatto di cera.
È opportuno, inoltre, fare una riflessione riguardo a una coppia di espressioni che non appartengono agli ambiti sopra citati, il cui significato esatto resta, però, ancora incerto. All’inizio del terzo miracolo, un uomo viene colpito da una grave malattia, che gli causa la perdita della parola e la cancrena alla mano. Alla malattia in questione ci si riferisce prima con ognennaja bolezn’ e poi con lichaja bolest’ (bolest’ è una variante di bolezn’). Non è chiaro di quale malattia si tratti e, in questo caso, la traduzione russa non viene in aiuto, poiché le espressioni utilizzate sono le stesse. La collocazione ognennaja bolezn’ è riportata nel Frazeologičeskij slovar’ russkogo literaturnogo jazyka, dove è indicata come espressione obsoleta per lichoradka, cioè febbre. Possiamo formulare due ipotesi riguardo al significato di questa espressione: date le gravi conseguenze sulla salute dell’uomo, è possibile che si tratti di una malattia specifica; o, più semplicemente, gli aggettivi ognennyj (che ha la radice di ogon’, fuoco) e lichoj (malvagio, cattivo), potrebbero alludere alla fase acuta di questo male. In ogni caso, poiché la denominazione esatta non è rilevante ai fini della comprensione del testo, per non incorrere in errori di interpretazione, abbiamo optato per un generico malattia.
Meritano, infine, alcune considerazioni due sostantivi che possono risultare di difficile comprensione al lettore estraneo alla cultura russa: družina ed egumenato.
Secondo la prima definizione (in base al contesto, è proprio questa accezione che ci interessa) fornita dal Tolkovyj Slovar’ Ušakova online, nell’antica Rus’ la družina era la guardia armata del principe. Non esiste un corrispondente italiano del termine, ma spesso nelle traduzioni si trova in traslitterazione, come družina, appunto: a una perifrasi abbiamo, dunque, preferito la traslitterazione, per non appiattire troppo il testo alla cultura di arrivo e per favorire l’avvicinamento del lettore a una cultura distante (nel tempo e nello spazio) dalla propria.
Per quanto riguarda igumen’stvo, invece, non abbiamo optato per una traslitterazione, poiché un corrispondente italiano sembra esistere. L’egumenato è, infatti, un’istituzione della Chiesa ortodossa (non solo russa) che, pertanto, non è del tutto sconosciuto in Occidente. Il ruolo a cui si fa riferimento è quello dell’egumeno che, secondo quanto riportato nel Vocabolario Treccani online, è il «capo di una comunità monastica della Chiesa greca, carica corrispondente a quella di abate nella Chiesa latina»10. Il termine egumenato, invece, non compare nei dizionari italiani consultati, ma se si effettua una ricerca su Internet se ne trovano numerose occorrenze: per tale motivo ci è parso opportuno utilizzare questo traducente.
Bibliografia / Sitografia
Bibliografia
Ferro, Maria Chiara; Romoli, Francesca (2013), Gli attributi di Dio. Per una traduzione slavo ecclesiastico-russo-italiano del lessico religioso e teologico-filosofico, «Studi slavistici»,X, Firenze University Press, p. 237-248.
Ferro, Maria Chiara; Romoli, Francesca (2014) Appellativi e attributi della Madre di Dio. Per un lexicon slavo ecclesiastico-russo-italiano dei termini religiosi, «Studi Slavistici», XI, Firenze University Press, p. 99-122.
Garzaniti, Marcello; Romoli, Francesca (2013), Le funzioni delle citazioni bibliche nella letteratura della Slavia Ortodossa, «Contributi italiani al XV Congresso Internazionale degli Slavisti (Minsk, 20-27 agosto 2013)», Firenze, Firenze University Press.
Kovalev, Vladimir (2019), Il Kovalev. Dizionario russo-italiano. Ital’jansko-russkij slovar’, Bologna, Zanichelli.
Miklosich, Franc (1862-1865), Lexicon Paleoslovenico-Graeco-Latinum emendatum auctum, Wien.
Osimo, Bruno (2011), Manuale del traduttore, Milano, Hoepli.
Picchio, Roberto (1977), The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of “Slavia Orthodoxa”, SHi 1.
Romoli, Francesca (2016), Studi per un lexicon plurilingue dei termini religiosi e filosofico-teologici. Ancora a proposito degli appellativi e degli attributi della Madre di Dio,«Stephanos», 5, p. 26-44.
Roty, Martine (1983), Dictionnaire russe-français des termes en usage dans l’Eglise russe, Paris, Institut d’études slaves.
Sreznevskij, Izmail Ivanovič (1893-1912), Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po pis’mennym pamjatnikam, I-III, Sankt-Peterburg.
Sumnikova, Tat’jana Alekseevna (2011), Skazanie o čudesach Vladimirskoj ikony Božiej Materi, «Žurnal’nyj klub Intelros. Istorija filosofii», 16, p. 19-34.
Sitografia
«Bašlik», In: Tolkovyj Slovar’ Ušakova online, consultato il 10/09/2024, URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=1745>.
Bible online, consultato il 10/09/2024, URL: <https://only.bible/>.
«Družina», In: Tolkovyj Slovar’ Ušakova online, consultato il 10/09/2024, URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=14441>.
«Egumeno», In: Vocabolario Treccani, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/egumeno/>.
«Esonartece», In: Vocabolario Treccani, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/esonartece/>.
La Sacra Bibbia in italiano in Internet, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.laparola.net/>.
«Iconostasi», In: Il Nuovo De Mauro, consultato il 10/09/2024, URL: <https://dizionario.internazionale.it/parola/iconostasi>.
«Mensa», In: Dizionario Latino Olivetti, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-flessione.php?parola=mensa>.
«Mensa», In: Il Nuovo De Mauro, consultato il 10/09/2024, URL: <https://dizionario.internazionale.it/cerca/mensa>.
«Mensa», In: Vocabolario Treccani, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/mensa/>.
«Nartece», In: Vocabolario Treccani, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/nartece/>.
«Ognennaja Bolezn’», In: Frazeologičeskij slovar russkogo literaturnogo jazyka, consultato il 10/09/2024, URL: <https://phraseology.academic.ru/388/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C>.
«Pantocreatore», In: Vocabolario Treccani, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/pantocratore/?search=pantocr%C3%A0tore%2F>.
«Pope», In: Il Nuovo De Mauro, consultato il 10/09/2024, URL: <https://dizionario.internazionale.it/parola/pope>.
«Portĭcŭs», In: Dizionario Latino Olivetti, consultato il 10/09/2024, URL: <https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-flessione.php?parola=porticus>.
«Ubrus», In: Tolkovyj slovar’ živago velikoruskago jazyka. Vladimira Dalja, consultato il 10/09/2024, URL: <https://slovardalja.net/word.php?wordid=40828>.
«Voščanica», In: Slovar’ drevnerusskogo jazyka (XI-XIV vv.), consultato il 10/09/2024, URL: <https://old_russian.academic.ru/2474/%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0>.
Note
- La traduzione presentata è il frutto del lavoro svolto da quattro studentesse: Sara Benedetti ha tradotto Nel primo giorno del mese di agosto celebriamo Cristo pieno di misericordia e la sua purissima Madre; Michela Rocchi: Sui miracoli dell’icona della Santissima Madre di Dio di Vladimir, Miracolo secondo; Martina Ferrigno: Miracolo terzo, Miracolo quarto, Miracolo quinto, Miracolo sesto, Miracolo settimo; Rossella Stalfieri: Miracolo ottavo, Miracolo nono, Sull’icona della Madre di Dio Odigitria, Sulla veste. Per quanto riguarda il commento, Sara Benedetti si è occupata dell’introduzione e del paragrafo 3; Rossella Stalfieri del paragrafo 1; Michela Rocchi dei paragrafi 2 e 4; Martina Ferrigno del paragrafo 5.
- Vocabolario Treccani, s.v. nartece, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/nartece/>
- Vocabolario Treccani, s.v. esonartece, URL:<https://www.treccani.it/vocabolario/esonartece/>
- Il Nuovo De Mauro, s.v. iconostasi, URL: <https://dizionario.internazionale.it/parola/iconostasi>
- Si segnala che nella nostra analisi si è fatto talvolta riferimento a dizionari differenti da quelli usati da Ferro, Romoli 2013 e Ferro, Romoli 2014.
- Bible online, URL: <https://only.bible/>
- Il Nuovo De Mauro riporta come data di prima attestazione della parola il 1611. Il Nuovo De Mauro, s.v. pope, URL: <https://dizionario.internazionale.it/parola/pope>
- Nel Tolkovyj slovar’ Ušakova online, è definito come «caldo copricapo, spesso indossato sopra il berretto – cappuccio di panno con lunghe estremità» (trad. nostra). Si veda Tolkovyj slovar’ Ušakova online, s.v. bašlik, URL: <https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=1745>
- La prima accezione riportata nel Tolkovyj slovar’ Dalja online è quella di «plat, platok», cioè «fazzoletto, scialle». Si veda Tolkovyj slovar’ živago velikoruskago jazyka. Vladimira Dalja, s.v. ubrus, URL: <https://slovardalja.net/word.php?wordid=40828>
- Vocabolario Treccani, s.v. egumeno, URL: <https://www.treccani.it/vocabolario/egumeno/>