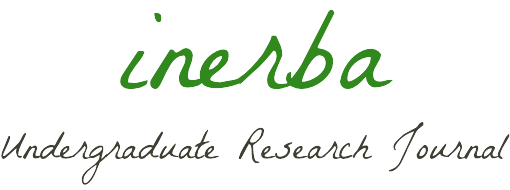Nel cuore di Clemente Rebora palpita da sempre un contrasto tra “eterno e transitorio”: egli vive in uno «stato di continuo dissidio […] con sé stesso e la realtà circostante» (Valli 1997: 75), diviso senza sosta tra il male di vivere e la sete di infinito, tra «l’adeguamento alla vita banale e l’esigenza di assoluto» (Rocco Carbone 1994: 21)1. Costretto ad allontanarsi da una formazione familiare priva di ogni apertura alla trascendenza, negli anni della giovinezza cerca quella luce nel mondo, che si rivela, però, una prigione ancora più crudele e spietata: l’ambiente nozionistico accademico, che sottopone l’individuo a un continuo esame di sé, lo soffoca; l’esperienza militare lo allontana dalla vita; l’insegnamento lo risucchia nel labirinto disumano della società moderna, gettandolo nella carneficina di un sistema scolastico che rende difficile l’esercizio di questa professione. Lo salvano soltanto, dal buio interiore, l’affetto degli amici, la passione per la musica, l’armonia che gli trasmette la natura, il piacere del donarsi agli altri, la poesia; di grande importanza è poi l’esperienza nella “Voce” e il suo tentativo di rispondere alla crisi dell’esistenza moderna, così fortemente sentita dallo stesso Rebora. È qui, in questo eterno dissidio tra luce e buio, che nascono nel 1913 i Frammenti lirici, il prodotto più autentico dell’interiorità reboriana negli anni della sua giovinezza, nel quale egli riversa tutte le contraddizioni del suo animo, costruendo una poesia inscindibile dall’esperienza di vita e dalla stessa realtà.
La prima impressione che si ha, immergendosi in questa raccolta, è quella di inoltrarsi nell’oscurità del giovane Rebora: una bufera di versi che riporta sulla pagina poetica i dolori e le necessità di questo suo indicibile tormento. L’esistenza si mostra fin da subito in tutta la sua contraddizione e il poeta prova a trovarne il senso: «l’egual vita diversa urge intorno» (Fr. I, v. 1), recita il primo verso della raccolta. A mettere in scena questo dissidio interiore è, in particolare, il contrasto tra la dimensione cittadina e quella naturale, che domina la prima parte della raccolta, caratterizzata da un sentito entusiasmo volontaristico. Sia all’interno dei singoli componimenti (suddivisi spesso da un “ma” avversativo) sia nella stessa struttura della raccolta2, queste due dimensioni si scontrano simulando il conflitto solitario del poeta con la realtà: alla livida città, dominata da indifferenza e materialismo, emblema del caos della modernità e del suo tormento esistenziale3, si contrappone la quieta presenza della natura, che ridona a Rebora «l’armonia con il mondo altrimenti spezzata» (Munaretto 2008: 828)4. Egli ci appare eternamente in lotta, lacerato dall’oscillazione continua tra tenebre e luce, tra reale e ideale, tra città e natura: la vita è per lui una «belva» contro la quale combattere «in una gabbia chiusa» (Fr. XIV, v. 29)5.
Quest’agire sfrontato è però destinato presto a fallire. La fiducia in una conciliazione dei termini del suo tormento attraverso la lotta si rivela impossibile: «per una sorta di cortocircuito», man mano che il soggetto si lacera in questa battaglia, entra «in scacco» la convinzione «di poter risanare il mondo [soltanto] aggredendolo» (Munaretto 2008: 840). Nel corso della raccolta emerge infatti un’altra dimensione, quella del dono e dell’amore, dell’annullamento di sé negli altri, già annunciata dal Fr. I, in funzione di proemio:
Pur vorrei maturar da radice
La mia linfa nel vivido tutto
E con alterno vigore felice
Suggere il sole e prodigar il frutto.
(Fr. I, vv. 19-22)
È soprattutto nella zona che ruota intorno ai componimenti XX-XXVII che si fa strada questa dimensione. Di contro al «perentorio individualismo» insito nella dimensione cittadina, nel Fr. XX Rebora afferma che la «realizzazione di sé» può avvenire soltanto «nell’ascolto dell’altro e nell’oblio della propria soggettività» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 268)6; nel Fr. XXIV, poi, dichiara: «il fato di ciascuno è dentro al mio / Come nell’occhio lo sguardo» (vv. 16-17). La compartecipazione al destino di ognuno, ossia il sentire sé stesso come parte di un qualcosa di più grande, lo allontana lentamente dalla seduzione del vortice della lotta. Prende così corpo «l’unanimismo reboriano» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 336), cioè la tendenza dell’io a identificarsi «con qualunque polo della natura e dell’agire umano» (Del Serra 1976: 72) e a immedesimarsi, dunque, nella realtà: «come saetta ch’aria in luce stringe, / O realtà, essere in te vorrei» (v. 37), scrive nel Fr. XXV. Riprendendo la “preghiera” del proemio, formula l’aspirazione a una vera e propria comunione con la realtà:
Terso vigor di zampillo,
Quiete di riso tranquillo,
Paga blandizie del senso,
Labile cosa del tempo
Fra labili cose, io sia:
Ma nell’urto del piccolo piede
Il passo divino ascoltare,
Tacita guida a chi crede
(Fr. XXV, vv. 52-59)
È in atto una «reificazione dell’io»: il soggetto perde le sembianze umane e si fa cosa «peritura», non più «vittima esclusa» in una lotta solitaria, ma assorbita nel fiume di un’esistenza anonima, di una «sorte comune», che racchiude tutti nel suo grande destino (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 325). Il dissidio di Rebora si stempera a poco a poco «in una dimensione di fraternità» (Valli 1997: 35) che comprende gli altri e l’intera realtà. Egli percepisce nell’annullamento di sé l’unico modo per «ascoltare nel turbine della realtà il passaggio silenzioso del divino» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 325): «io sento la maravigliosa bellezza seria della finitezza e dell’infinità della piccola grande eterna vita» (Rebora 2004: 156)7. Affiorano man mano in lui l’amore, la bontà, l’ansia di sacrificio e dono «che [pur] sostanziano la sua anima»: forse più forti del suo contrasto interiore, scavano una luce nel suo cuore e puntano a trasformarsi, nel corso del poema, in azioni «storicamente util[i] ed efficac[i]» (Giovannini, in Rebora 2008: 156)8.
La fine dell’individualismo e il modello della natura
La seconda parte della raccolta mette in scena la «partecipazione attiva con le cose» (Parronchi 2005: 94) come unica soluzione alla crisi e alla lotta. Non c’è alcun allontanamento dalla responsabilità del vivere né alcuna ricerca di un riparo dalle contraddizioni del mondo: la vera liberazione «consiste […] nell’impegno a far trionfare l’amore» anche nel caos e a nutrire «la fiducia in una trasformazione del mondo» (Beschin 1993: 238).
È il frammento centrale della raccolta (Fr. XXXVI), dedicato all’esperienza dell’insegnamento, a determinare la svolta di questo percorso e a rianimare nel giovane Rebora il senso dell’esistenza. È il «sacrificio muto» (Fr. XXXVI, v. 46) di un compito fatto di «ascesi segreta / Del [proprio] nume» (vv. 44-45), in cui l’io dona tutto agli altri, che porta il poeta a «sorger libero e terso» (v. 26) e a mutare definitivamente la sua dialettica io-mondo9. «L’alternativa [iniziale] tra natura e città» viene meno (Munaretto 2008: 834); perde senso quella lotta nella quale il poeta aveva cercato un significato e s’impone il dovere di fare spazio alla vasta bontà del cosmo:
Io non ho né numi né glorie,
Io non ho né donne né bimbi,
Io non ho né lucri né mete,
Ma un vasto cuore intero
Che toglie dall’ora di tutti
L’infinita ricchezza e la dona.
(Fr. LXIII, vv. 55-60)
In particolare, nei frammenti L-LXXI si moltiplicano i riferimenti all’annullamento di sé, in quanto massima espressione della forza della bontà e del dono. Il poeta insiste su «un vero e proprio dissolvimento che [gli] consente di immettersi pienamente nella coralità dell’esistenza» (Munaretto 2008: 838), «anche a costo di perder[si]» (Rebora 2004: 126)10. È il Fr. XXXIX che decreta la fine dell’individualismo: oltre «l’irrisione e [l’egocentrismo] della schizofrenica società» moderna (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 466), s’intona una «voce unita» (v. 25), un coro unanime che condivide lo stesso dolore, in cui ognuno è destinato a morire nella propria individualità per rinascere negli altri11. Rebora non è più solo: si dissolve quell’amara solitudine della realtà moderna, da lui stesso sperimentata; nel Fr. XL cinge d’«un intenso amor alato […] / Ogni persona» (vv. 9-10) e dichiara con emozione: «dagli altri vivi più non mi distinsi» (v. 11). È in atto una pacificazione con la realtà; egli ha trovato la chiave dell’esistenza nel puro atto d’amore:
Ma benedetti voi,
Meravigliosi doni:
Esistere e pensare,
Cinger di sé l’ignoto
Universo e amare,
Per ridiscender domani
Umanamente pronti
Al terribile giorno.
(Fr. L, vv. 101-108)
L’unica soluzione per risolvere il difficile rapporto io-mondo è «l’immersione a capofitto nell’incomprensibile realtà» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 642), una «continuità fra [il soggetto] e ciò che [lo] circonda» (Rebora 2004: 131)12, come dichiara nel canto di liberazione intonato nel Fr. LVI:
Come canto in melodia,
Come nota in armonia,
Nell’amor della gente mi paleso:
E vil mi sembra quando con tormento
La voce si smarrisce appena mia.
Come vena profonda alle radici,
Come pioggia feconda,
Rinascer tento negli altri felici.
(Fr. LVI, vv. 5-12)
Rebora confessa finalmente «il [vero] destino cui si sente chiamato» (Rebora 2004: 131): dare tutto sé stesso senza ricevere nulla in cambio, annullarsi per il bene degli altri, sentire scorrere e palpitare nel proprio battito il «sangue di tutti» (Fr. LVI, v. 4). Egli dichiara:
ho dato (o creduto dare) moltissimo, e nulla o quasi ho ricevuto; e talvolta mi vien voglia – vilmente corrucciato – di chiudere la partita. Ma per fortuna trionfa infine la mia voce intima che m’assicura ch’io son nato per questo; e m’accontento quasi (anzi, si direbbe, m’industrio) di non ricevere nulla, e dare – quando so e posso – agli altri (Rebora 2004: 95)13.
S’impone dunque in lui un’assoluta necessità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, di un riassorbimento di tutto ciò che è «individuale nel collettivo» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 647): solo dissolvendosi in una grande unità, egli può mettere a tacere il suo tormento interiore, perché «divino è l’esser fra cose che sono» (Fr. LX, v. 16). Il problema della felicità si risolve «aderendo all’essere del mondo» (Fortini 1995: 18), facendo scorrere la propria linfa «nel vivido tutto» (Fr. I, v. 20).
La natura e la «soluzione cosmica»
In quest’ascesi dell’uomo e poeta Rebora, è la natura ad assumere un ruolo di grande importanza. Nella seconda parte della raccolta, venendo lentamente meno quella lotta tra io e mondo, sembra mutare anche il suo ruolo: essa si svincola dall’eterno contrasto con la dimensione cittadina e si pone, sempre di più, al centro del discorso reboriano; il poeta la osserva in tutte le sue caratteristiche e pare farne il modello per il cambiamento intrapreso dall’io.
Verso la metà del poema, nel Fr. XXXIII, il poeta riconosce per la prima volta «nella natura la fonte d’ispirazione di ogni grande uomo» e la definisce come l’unico vero «libro di verità e ispirazione» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 398)14. Nei frammenti successivi si sofferma poi su un confronto tra lo stato di natura e quello umano: nel Fr. XLIV esprime un sentimento di invidia per i grilli, cantori «di silenzi» (v. 7), che rivelano la serenità dello stato naturale di contro all’inquietudine dell’uomo; nel Fr. XLI si identifica in alcuni elementi naturali, prestandosi a una vera e propria metamorfosi in uno stato di natura, in una sorta di riconciliazione cosmica tra «natura umana» e «natura del cosmo» (Ramat 1976: 91).
Ero il trillo d’una fonte
Che nel verde delle sponde
È felice di fluire,
Ero il soffio d’una valle
Che nell’erba fa ghirlande
E richiama
Voci in aria,
Ero il volo d’una nube
Con le chiome ampie di luce
E giù fida
L’ombra schiva.
(Fr. XLI, vv. 5-16)
La pioggia del Fr. XLV non è più la pioggia della dimensione cittadina, che scendeva livida nel Fr. XIV, ma è la «pioggia dell’ora ammonitrice» (Fr. XLV, v. 8) che, come portavoce del cambiamento intrapreso dal poeta, si fa messaggera di una possibile «comunicazione tra terra e cielo» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 522) e rivolge un potente monito al mondo15.
Il vero cambiamento si compie però con il Fr. LXII, che apre la sezione dei “frammenti cosmici”16. È qui che avviene definitivamente l’allargamento di prospettiva dalla città al cosmo, il passaggio «dall’io al non-io, […] dalla lotta al dono» (Munaretto 2008: 842). Rebora approda a una «soluzione cosmica» (Fortini 1995: 13), passando da un’«operosità-individualità» a un’«operosità-verità (universalità)» (Rebora 2004: 177)17, che segna il limite alla via da lui stesso tentata. Perde forza l’«eroico volontarismo» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 691) della parte iniziale e s’impone, al suo posto, una «sapienza cosmica» (Fortini 1995: 26) che rivela la direzione dominante dell’intero poema. L’«antagonismo storico» tra il poeta e la realtà cittadina (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 684) si dilata in un dissidio che si fa «cosmic[o] [e] universale»: l’uomo non è più protagonista, ma «soggetto anonimo di una respirazione cosmica» che lo riporta alle sue dimensioni reali, inglobandolo nel grande flusso del cosmo (Giovannetti 1987: 411).
Nel Fr. LXII, nell’attaccare «l’atteggiamento prevaricatore» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 691) dell’uomo, chiuso nel suo «sprezzante egocentrismo», incapace di guardare fuori dal suo ristretto campo e di accettare la sua vera natura18, il poeta si appella proprio agli enti naturali, unici testimoni dell’armonia dell’universo, affinché denuncino «come tutta la realtà partecipi dell’amore divino, tranne l’uomo» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 692):
Stella in baglior di nebulose avvinta,
Notte succhiata dal cuor dei tramonti,
Goccia indistinta nel grido del mare,
Rupe sommersa nel clivo dei monti,
Pianta dispersa mentre inseni fonda,
Forza agli ordigni nascosta e feconda,
Anonima rozza che il carro trascini,
Dite dite l’arcana maniera
Dell’invisibile amore
A noi, che meschini
Coniamo dei nostri suggelli
Il lavoro di Dio
Gridando: Io, io, io!
(Fr. LXII, vv. 14-26)
Soltanto la natura conosce l’arcana maniera dell’amore invisibile del cosmo; solo gli elementi naturali possiedono la capacità di annullare il proprio ego nell’armonia universale.
Nell’ordine naturale del mondo non esiste […] divisione o dissidio, ma ogni ente aderisce perfettamente e totalmente al tutto, e lo spazio non è un monstrum famelico e aggressivo, ma il cosmo nel quale ogni cosa trova il posto che le è proprio, fino a sparire in esso, realizzando così quell’unità nel molteplice cui aspira […] l’autore (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 685).
Gli elementi naturali vivono in nome di un sacrificio verso un’unità superiore che li anima e li comprende e che in loro nasce e rinasce senza fine; è con questa stessa fedeltà e questo stesso sacrificio che l’uomo deve imparare a vivere, orientandosi «sui binari di una totalità cosmica, […] che non deve […] solamente sopportare ma […] cercar di realizzare dentro di sé» (Ramat 1976: 92). Egli deve perdere sé stesso come il «solitario palpito di stella» (Fr. XXX, v. 2) che sacrifica la propria luce per contribuire allo splendore del cielo19; deve imparare a donarsi con «vispezza e amore» (Fr. LVII, v. 3) come «l’uccelletto» (v. 2) che accorre ingenuamente ai richiami del cacciatore e muore intonando «un ultimo trillo» (v. 6)20. Dunque, è sull’esempio della natura che l’uomo, questa «creatura di ventiquattr’ore» (Fr. LXII, v. 6), deve modellare il suo comportamento per trovare la luce dell’esistenza: non più ergendosi «sugli uomini, sulle cose, su Dio stesso», in un cieco «volontarismo etico» (Ramat 1976: 92) capace di acuire soltanto il tormento, ma adattandosi al flusso d’amore dell’universo sul modello dell’ordine naturale del cosmo.
Nei frammenti finali si moltiplicano i riferimenti agli elementi naturali, che sembrano completare questo percorso. Nel Fr. LXIII gli alberi si fanno modelli di «umiltà» e «animazione spirituale»: il vero «anello di giuntura tra terra e cielo», tra «concreto e spirituale», tra realtà e idea (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 712). Nel Fr. LXIX torna poi, per la terza volta, la pioggia, che ora «trascende la semplice manifestazione di un fenomeno atmosferico» per caricarsi di «tratti metafisici» e agire sulla scia del monito già espresso nel Fr. XLV (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 760): non è più soltanto il poeta ad accordarsi al suo grido, ma un’istanza soggettiva, un «noi» (v. 21) «che ambisce a uno spessore generazionale e storico» (Giovannetti 1987: 413)21. Infine, nel Fr. LXX, si incontra il massimo emblema dell’obiettivo cui punta tutta l’etica reboriana: la vetta.
Dai piani colline giogaie catene
Si lamina enorme la vetta
Su vertebre e stinchi a vedetta
Con l’anima ardente nei geli costretta.
Sopra, il vuoto dell’ombra e del fuoco
In infinita voragine turbina:
Sotto, dal vano dell’aria la terra
– Fra bave di nubi e tormenta –
L’ultime scaglie le avventa,
E fugge ghermendo la vita
Effimera d’orme e di voci
In vertigine atterrita.
(Fr. LXX, vv. 45-56)
Essa incarna lo stesso fragile equilibrio tra due abissi vissuto dal poeta: sebbene partecipi alla vita, legata da catene inestricabili al caos infernale della realtà, essa non smette di tendere verso un oltre, verso il cielo rispetto al quale misura la sua fede, in un confronto «terribile, coraggioso e solitario» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 790), aspirando senza fine all’eterno. È proprio questa la scelta alla quale Rebora approda: vivere comunque nella realtà, attuando continuamente in essa una tensione verso l’Assoluto. È questa l’unica condizione morale alla quale si deve tendere per placare il contrasto della modernità: «un’altissima tensione filosofica e spirituale, radicata [però] nelle faccende del mondo» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 789); una «responsabilità cosmica» (Ramat 1976: 97) che si attua in una partecipazione alla realtà orientata al compimento dell’armonia universale; una condizione in cui non c’è nulla di idillico, ma solo il riflesso del fragile equilibrio di una scelta etica difficile, che si fonda tutta sul senso del sacrificio.
La poesia come strumento: la realizzazione nella vita
Se è questo il vero cammino da intraprendere, anche la stessa poesia non può rimanere uno «slancio che non sa trasferirsi alla realtà» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 501) o il motore solitario del rovello infinito dell’io che gira su sé stesso. «A che tu, poesia, / Se dentro animi il mondo e fuor non sai?» (Fr. XLIII, vv. 31-32), si chiede Rebora in un frammento centrale della raccolta; essa deve necessariamente farsi grido d’azione nella realtà: solo trasformandosi in «potenza d’azione» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 792) potrà rendere reale il messaggio reboriano.
In questo senso, è il discorso metapoetico del Fr. XLIX a fornire la chiave interpretativa dell’intera raccolta e a rivelare la vera meta del poema22. Rebora descrive una poesia che non giudica il mondo ma si identifica in esso: una poesia tutta «terrestre e mondana, fatta di fango come Adamo» (Mengaldo 1994: 386), radicata nell’infinito tumulto quotidiano, mescolata «indissolubilmente alla realtà» in tutte le sue forme (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 570). Essa è allo stesso tempo«tristezza» (v. 24) e «letizia» (v. 27); «non è un primum rispetto alle cose, ma concresce insieme a loro» (Ramat 1976: 95), fatta «di sterco e di fiori» (v. 31), schiava del mondo, «morta e rinata» tra le sue catene (v. 33), ma capace di libertà. La sua natura è dunque tutta «strumentale» (Munaretto 2008: 846) e Rebora lo dichiara apertamente nell’ultimo frammento, in cui «espone la volontà di tradurla in esperienza di vita» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 805):
Il mio verso è un istrumento
Che vibrò tropp’alto o basso
Nel fermar la prima corda:
Ed altre aspettano ancora.
Il mio canto è un sentimento
Che dal giorno affaticato
Le notturne ore stancò:
E domandava la vita.
(Fr. LXXII, vv. 11-18)
È dunque la poesia stessa dei Frammenti lirici a rivelarsi, alla fine, incessante ricerca di vita e il canto di Rebora da soggettivo e utopico si fa voce della generazione tormentata degli anni Dieci del Novecento, alla quale è dedicata la raccolta23, invitata una volta per tutte «a riconoscere il proprio mondo nelle parole del poeta» (Fortini 1995: 813) e ad aprirsi a una potente azione d’amore. È così che nell’ultimo frammento Rebora riapre il dialogo con il lettore, instaurato nel proemio, e il «breve suono» della sua poesia si fa «chicco dell’immenso» (Fr. LXXII, vv. 19-20). Egli condensa nell’esperienza della sua anima il destino di tutti e invita ogni uomo a «riconoscersi nell’Io lirico che porta il suo nome» (Fortini 1995: 31). Solo riportando questo cammino al proprio, forse allora il lettore potrà comprenderlo; solo attraverso un «fruttuoso consentire»24, cioè sentire insieme «nella coralità laboriosa della creazione ininterrotta» del tutto (Ramat 1976: 98), si «porterà a compimento il senso [ultimo e] autentico dei Frammenti lirici» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 806).
Si compie, dunque, la piena trasformazione accennata in apertura della raccolta. È questa «vita che è vita» (Fr. LXXI, vv. 72-84) che il poeta alla fine domanda, è la realizzazione nell’esistenza tra «cielo e carne» (Ramat 1976: 100), è la «libertà» che ride «fra le catene» della vita (Fr. LXXI, v. 44). La tormentata ricerca dei Frammenti lirici assume così «una valenza universale e umana» (Lauretano 2013: 35). Dalla crisi iniziale Rebora approda a un realismo cosmico: la soluzione del tormento consiste nell’immersione in una realtà che non è più solo ostile, ma nasconde le tracce di un’armonia del tutto che ogni uomo deve imparare a riconoscere e ad attuare dentro di sé.
Bibliografia
Beschin Giuseppe (1993), «Il significato dell’amore in Antonio Rosmini e Clemente Rebora», In: Beschin G., De Santi G. e Grandesso E., Clemente Rebora nella cultura italiana ed europea: Atti del Convegno Rovereto 3-5 ottobre 1991, Accademia roveretana degli agiati di scienze lettere ed arti, Roma, Editori Riuniti, p. 219-265.
Del Serra Maura (1976), Clemente Rebora. Lo specchio e il fuoco, Milano, Vita e pensiero.
Fortini Franco (1995), «”Frammenti lirici” di Clemente Rebora», In: Asor Rosa A., Letteratura italiana. Le Opere, vol. IV.I, Torino, Einaudi, p. 1-35.
Giovannetti Paolo (1987), Clemente Rebora, «Belfagor», 4, vol. XLIII, p. 405-430.
Lauretano Gianfranco (2013), Incontri con Clemente Rebora. La poesia scoperta nei luoghi che le hanno dato vita, Milano, Rizzoli.
Mengaldo Pier Vincenzo (1994), «I vociani», In: Mengaldo P.V., Il Novecento, Bologna, Il Mulino, p. 210-218.
Munaretto Matteo (2008), «Il libro dei Frammenti lirici: struttura e senso poematico», In: Rebora C., Frammenti lirici, a cura di Mussini G. e Giancotti M., con la collaborazione di Munaretto M., Novara, Interlinea Edizioni, p. 815-852.
Parronchi Alessandro (2005), «Messaggio del poeta», In: Grandesso E., Una parola creata sull’ostacolo. La fortuna critica di Clemente Rebora. 1910-1957, Venezia, Marsilio Editori, p. 91-94.
Ramat Silvio (1976), Storia della poesia italiana del Novecento, Milano, Mursia.
Rebora Clemente (2004), Epistolario, Clemente Rebora. Volume I. 1893-1928. L’anima del poeta, a cura di Carmelo Giovannini, Bologna, Edizione Dehoniane.
— (2008), Frammenti lirici, a cura di Mussini G. e Giancotti M., Novara, Interlinea Edizioni.
Rocco Carbone Lorenza (1994), Ineffabile Novecento. Il ritorno a Rebora, Empoli, Ibikos Editrice.
Valli Donato (1997), Cinque studi su Clemente Rebora, Lecce, Congedo Editor.
Note
- «Mi sbatto nel contrasto fra l’eterno e il transitorio, fra quello che sento (e amo) necessario e quello che vorrei non fosse, fra la potenza e l’atto, fra la cosa conosciuta e il lasciarla partire, fra la rozzezza di un fabbro e la permalosità di un insofferente» (Rebora 2004: 120).
- I frammenti più tragici, che fanno riferimento al mondo della città, sono inframezzati dai cosiddetti “idilli”, nei quali domina la presenza della natura.
- La «città vorace» (Fr. X, v.7) è una «Venere neutra immonda» (v. 14), «che nella fogna […] tutti affratella» (v. 8). Essa divora e distrugge con rapidità tutto ciò che incontra, dissolve il singolo uomo nel gorgo della massa e gli impedisce di «essere persona» (v. 12); l’individuo, costretto a smarrirsi «nei molti» (v. 5), è svuotato della sua «intima pace» (v. 6). Il suono della città è il «grido delle macchine e dei lucri» (Fr. V, v. 58): essa «immane ferve» (Fr. XXXIV, v. 2), alimentando lo scontro del progresso e riecheggiando «di macchine […] e di monete» (Fr. XXXIV, v. 3); è un luogo privo di ogni purezza, il riflesso di un’epoca consunta dai ritmi frenetici e dalla fretta. In essa la vita dell’uomo non è nient’altro che un «carro vuoto su un binario morto» (Fr. XI, v. 1).
- Da sempre la natura trasmette al poeta armonia e serenità. Nella lettera del 4 luglio 1908 scrive a Daria Malaguzzi: «squilla un cielo turchino che mi narra cose meravigliose e non so più dolermi per così poco» (Rebora 2004: 38). Al mondo cittadino egli contrappone la quiete e l’armonia di una natura in cui si compie quella serenità desiderata, dominata da leggi oscure agli uomini.
- «La vita, che qui di respiro in respiro / È con noi belva in una gabbia chiusa!» (Fr. XIV, vv. 28-29).
- Egli utilizza l’immagine «fortemente moralizzata» del volgersi continuo del mare verso ogni sponda (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 268).
- Si cita dalla lettera del 10 dicembre 1912 ad Angelo Monteverdi.
- Per comprendere l’affiorare di questi concetti di dovere, sacrificio, missione e azione è necessario, come afferma Carmelo Giovannini, «tenere presente il pensiero» di Mazzini, che influenza profondamente il poeta negli anni della giovinezza: «i principi del mazzinianismo acquisiti dai genitori», che ruotano intorno al concetto di «vita come missione di servizio, amore [ed] educazione», gli indicano «la meta alla quale […] indirizzare ogni suo sforzo», dando un «senso alla sua ansia di sacrificio e dono»; essi si armonizzano «perfettamente con l’ideale di bontà, cui Rebora [sta] impostando la propria esistenza» (Giovannini, in Rebora 2004: 138-139).
- Nella lettera del 2 marzo 1911 a Daria Malaguzzi scrive: «tutto il mio tempo lo dono all’insegnamento, che faccio con esattissimo dovere ed abbandono e prodigalità: sento di avere (ed è questo che me lo rende sacro) delle creature alle quali io posso far qualche bene» (Rebora 2004: 95).
- Si cita dalla lettera del 9 febbraio 1912 a Daria Malaguzzi.
- «Oh voce risorgi dal cuore di ognuno: / E ognuno, dove muore, scoprirà / Chi l’attendeva a vivere» (Fr. XXXIX, vv. 66-68).
- Si cita dalla lettera del 5 marzo 1912 ad Antonio Banfi.
- Lettera del 2 marzo 1911 a Daria Malaguzzi.
- «Oh risentirci come creatura / Viva nel mondo saliente in noi / E l’evangelo di tutti gli eroi / Riconoscere dove fu natura!» (Fr. XXXIII, vv. 15-18).
- «Con me in persi indicibili moti / È la pioggia che fila giù bieca, / Mentre senz’eco di color ignoti / Presagi l’aria notturna distende / E a la giornata cieca / Immobile discende, / Quasi eterno coperchio sopra un’urna» (Fr. XLV, vv. 1-7); «e tu barbaglio sull’anima cieca, / E tu, pioggia che fili giù bieca!» (Fr. XLV, vv. 45-46).
- Gianni Mussini e Matteo Giancotti individuano, tra gli ultimi componimenti del poema, un «piccolo filone astrale» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 684). Esso comprende i frammenti: LXII, LXIII, LXVI, LXVIII e LXX.
- Si cita dalla lettera del 24 febbraio 1913 a Daria Malaguzzi.
- Rebora attacca l’uomo della società moderna, che «si leva signore» (Fr. LXII, v. 8) del mondo e «nel fil del suo sguardo ha l’universo» (v. 9). Egli è abituato a gridare «io, io, io» (v. 26), nello sforzo di una sua affermazione assoluta sul mondo; crede che ogni cosa sia stata creata per lui e considera la sua azione più forte di qualsiasi altra forza, anche di quella naturale e divina.
- Nel Fr. XXX, Rebora costruisce una vera e propria «favola morale» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 367) rappresentando nell’immagine della stella solitaria che si confonde tra le altre quell’elogio all’anonimato e al desiderio del dissolvimento di sé.
- Esso «palpita nelle accorte / Mani un poco, e la morte / Dal becco gli esce in un ultimo trillo» (Fr. LVII, vv. 4-6). Il poeta confessa: «Cader così vorrei dietro il mio cuore; / Così finir, con generoso squillo» (vv. 7-8).
- «Ma per noi, fredda amazzone implacata, / O pioggia di scuri e di frecce / Tu sei redentrice adorata / Del rinnegato bene; / Per noi, che sentiamo insolubil mistero / Quando vita si sdraia alle cose, / Mentre l’eterno in martirio di prove / Ci sembra spontanea purezza del vero, / Tu susciti come il silenzio / Dove natura è più forte (Fr. LXIX, vv. 21-30).
- Nel frammento sono presenti temi e immagini che si legano ad altri componimenti, ponendosi come veri e propri «riferimenti metatestuali», «consapevoli richiami a passi importanti di testi già composti» (Mussini e Giancotti, in Rebora 2008: 559).
- «Ma qui c’è un cuore e vorrebbe / Altri cuori trovare» (Fr. XXXIX, vv. 9-10); «venga chi non ha gioia a ritrovare / Questa voce che mia / Par soltanto e di sogno» (vv. 1-3).
- Gli ultimi due versi della raccolta recitano: «Odi il senso del tuo mondo: / E consentire ti giovi» (Fr. LXXII, vv. 21-22).