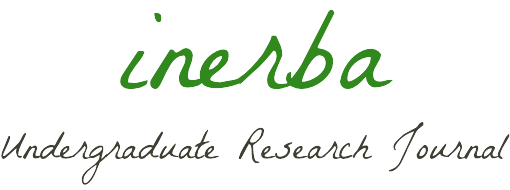Introduzione
Dalle più profonde regioni dello sconosciuto sistema binario Z Reticuli si ode ormai da tempo un segnale registrato al radiofaro che avverte di stare il più lontano possibile da quella zona. Cose strane accadono, ed il film Alien del 1979, con Ridley Scott alla regia, si propone di metterci in guardia dai pericoli che orbitano intorno a quella galassia. Eppure, nel 2012 il suddetto regista torna alla carica con un prequel di Alien, intitolato Prometheus, con lo scopo di spiegare gli eventi accaduti nei vari film della saga; o forse per gettarvi ancora di più un alone di mistero? Certo è che un titolo così evocativo poco sembra avere a che fare con la tematica aliena protagonista dei precedenti film, ed in effetti se ne discosta leggermente, pur rimanendovi collegato. L’analisi che segue mira ad osservare ed esaminare gli aspetti del film che più rimandano all’archetipo prometeico, e di come questi possano essere integrati nel genere fantascientifico o fanta-horror.
Elemento prometeico: dove si colloca?
In questo viaggio attraverso il tempo e lo spazio andiamo sia indietro, poiché il film è ambientato circa 30 anni prima dell’Alien originale, sia avanti, perché ci troviamo già in una società tecnologicamente avanzata, tant’è che l’anno in cui si svolge la vicenda è il 2093. La spinta in avanti non è solo letterale però, è anche figurata: prima e dopo la visione del film, la domanda che sorge spontanea è la stessa su cui si basa la nostra tesi, ovvero se il titolo Prometheus sia riferito ad un particolare personaggio o se rappresenti qualcosa di più grande, come l’idea che si cela dietro a questo viaggio. Ebbene, qual è la più corretta? Difficile a dirsi, dato che entrambe sono giuste, seppur la seconda sia forse quella che più racchiude il significato del film. È necessario, però, aggiungere che una non esclude forzatamente l’altra.
La figura di Prometeo1, il titano dei miti classici che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, è centrale per la nostra comprensione del film. Essendo Prometeo colui che innova, plasma e rivoluziona, cercheremo di ritrovare queste sue caratteristiche nelle azioni dei personaggi, nelle scene e nei diversi aspetti su cui si incentra la trama.
Elementi “secondari”
È possibile riconoscere la componente prometeica in elementi cosiddetti “secondari” (non per importanza, ma per esigenza, in quanto ci soffermeremo maggiormente su altri fattori). Nell’elenco che segue ne presenterò alcuni: il titolo, la prima cosa su cui si sofferma lo spettatore; il paesaggio, un rimando all’elemento Ice, notiamo infatti che è una terra ostile e disabitata, spoglia e fredda (in netta contrapposizione al tipico Fire prometeico); gli Ingegneri, creature umanoidi dall’aspetto statuario o, per meglio dire, titanico; Elizabeth, la protagonista del film, e altri personaggi.
“Prometeico” nel senso di conoscere, osare, andare oltre
L’idea di fondo del film risiede e ruota attorno alla sua trama. È pertanto impossibile parlarne senza ripercorrerne i passaggi più importanti.
Ci troviamo sull’isola di Skye (Scozia), nell’anno 2089, dove una coppia di archeologi, ovvero Elizabeth Shaw e suo marito Charlie Holloway, trova in una grotta dei graffiti che mostrano delle figure umanoidi che indicano una costellazione, con ai loro piedi figure più piccole a venerarle. I graffiti rinvenuti sono identici ad altri reperiti presso diverse culture in alcun modo collegate tra loro. Convinti che essi rappresentino i creatori dell’umanità, da loro poi soprannominati Ingegneri, e che queste costellazioni siano una meta da seguire, si rivolgono alla Weyland Corporation (una compagnia multimiliardaria dai loschi scopi), che finanzierà la ricerca col fine di trovare il modo di sconfiggere la morte. Per raggiungere il luogo indicato dalla mappa viene costruita la nave Prometheus, con un equipaggio a cui è stato affidato l’incarico di trovare tracce degli Ingegneri sul pianeta. Quest’ultimo è in realtà la luna LV-223 del gigante gassoso Calpamos, un pianeta grande cinque volte Giove. Durante la spedizione, però, l’equipaggio si imbatte in qualcosa di misterioso e terribile.
La trama prosegue poi con altri sviluppi, ma per ora faremo un approfondimento su questa prima parte. Il momento più cruciale del film, e forse anche quello di non ritorno, è proprio quando l’equipe decide di partire, spinti appunto da una sorta di moto prometeico. I nostri protagonisti hanno interpretato i graffiti come un invito, ed è qui che risiede il loro primo errore: non c’è niente, infatti, che possa avvalorare la loro ipotesi, l’unico modo per scoprirlo è quello di andare a vedere. Senza rendersene conto, hanno implicitamente sfidato gli “dèi” (in questo caso rappresentati dagli Ingegneri) e ciò è estremamente pericoloso, in quanto avventurarsi nel nulla cosmico senza sapere cosa risieda dall’altra parte potrebbe rivelarsi fatale. Sottostimare in questo modo la potenziale minaccia può apparire come un errore grossolano, soprattutto in un film di fantascienza, ma con questa scelta il regista ha probabilmente voluto mettere in risalto il complesso prometeico che alligna in ognuno di noi: di fronte a un divieto, infatti, la prima reazione che abbiamo noi esseri umani è di infrangerlo. E c’è molto di più dietro. Ciò che sprona i personaggi, in particolar modo Elizabeth, ad agire con tanta temerarietà (o per caso, sconsideratezza?) è proprio la sete di conoscenza, il voler sapere a tutti i costi se siamo soli nell’universo, che si tramuterà in un “perché non lo siamo?”.
L’importanza del progetto è tale da far sì che la Weyland Corporation metta a repentaglio la vita degli stessi dipendenti, questo perché il vero obiettivo della compagnia è di trovare la chiave per l’immortalità. Questo indizio ci porta ad affrontare un altro tema individuato nel film, ossia la tematica Life.
La tematica Life
Tra il 15 e il 16 giugno 1816, anno che viene definito “Year without a summer”, il gruppo del circolo Diodati, di cui facevano parte anche Mary e Percy Shelley, tenne una discussione sul tema Life, vale a dire su cos’è la vita. La vita viene “comunicata” attraverso il metodo naturale (il concepimento) o attraverso la creazione? Questo è più o meno ciò che si domandano anche i nostri protagonisti, sebbene loro si interroghino su chi ha creato l’uomo, visto che secondo la loro scoperta, è sicuro ormai che gli uomini siano stati creati da qualcuno.
Prometeo però non è un creatore, bensì un plasmatore, ma questo lo rende comunque in grado di modellare gli umani e dargli vita, in un certo senso li “fabbrica”. Non è un caso, infatti, che gli esseri bianchi del film siano stati nominati “Ingegneri”: un ingegnere è colui che assembla, che mette insieme dei pezzi. Il paragone con Prometeo è qua più che ragionevole, e potrebbe stimolare in noi un altro interrogativo: siamo stati creati oppure la nostra razza e quella degli Ingegneri già coesistevano, e questi ultimi ci hanno “migliorato”? Nel film, la nostra forma di vita sembra essere stata in tutto e per tutto prodotta dagli Ingegneri, e questo cancella ogni dubbio sul quesito precedente. Tuttavia, un altro ancora viene suscitato dalla seconda parte del film: si viene a scoprire che l’obiettivo ultimo degli Ingegneri era quello di distruggerci. La motivazione di questo gesto non è chiara, e lascia per l’appunto il film con un finale in sospeso, e cioè con Elizabeth che parte alla ricerca del pianeta degli Ingegneri per scoprire come mai vogliono sbarazzarsi di noi, le loro stesse creazioni2.
Androide David 8
Durante il viaggio, la squadra è accompagnata da un androide di aspetto completamente umano, di nome David 8. Costui rappresenta il potenziale trickster, ma soprattutto il potenziale Prometeo, di questo film. È infatti il personaggio che più di tutti incarna le caratteristiche tipiche della figura prometeica, ma procederemo descrivendole per gradi. Innanzitutto, presentiamo il personaggio.
Il numero 8 è riferito al numero di tentativi che sono serviti per arrivare a lui, ossia un androide perfetto sotto tutti i punti di vista. Il nome David, invece, se l’è scelto da solo, anche se questo lo vedremo nel sequel di Prometheus, ovvero Alien: Covenant. È un dettaglio importante perché essere in grado di nominare le cose significa essere in grado di dar loro potere e di possedere, di conseguenza, una sorta di magia. Tuttavia, ciò che lo contraddistingue sono curiosità e ambizione, con quest’ultima che si traduce in una hýbris molto forte.
A causa di una serie di scelte da lui compiute nel corso del film, apprenderemo che David è fatto a imitazione degli umani (tant’è che in alcune scene lo vediamo scimmiottarci) e che il suo compito è quello di aiutare e affiancare i membri dell’equipaggio durante la missione; ciononostante verremo a conoscenza del fatto che ha sempre i suoi loschi fini, e che perciò porta una maschera che cela la sua vera natura. La sua hýbris, infatti, non è tanto di tracotanza, quanto di violenza stessa verso gli dèi, che nel suo caso sono rappresentati da noi esseri umani, in particolare Weyland. In David la dinamica di attrazione/repulsione verso gli uomini è davvero potente: è attratto dalla scienza degli umani e da questi ultimi in generale, ma allo stesso tempo li disprezza. Inoltre, non ha empatia e non conosce la paura. In che cosa, allora, un personaggio del genere è simile a Prometeo?
Non dimentichiamoci che tutti quelli elencati, seppur negativi, sono tratti prometeici3, anche se i più prominenti sono la curiosità e la “ribellione” verso il padre. La prima è evidenziata dall’atteggiamento di David che, a differenza degli altri protagonisti, non teme gli Ingegneri e anzi, si diverte a giocare con le strane sostanze trovate sul pianeta, nonostante tutti fossero stati ammoniti di non entrare in contatto con eventuali esseri alieni incontrati sul percorso. Qua emerge il complesso prometeico di David: la sua mente, per quanto sia stato progettato alla perfezione, è ancora molto infantile e lo capiamo perché le sue azioni (non tutte però) non sono dettate da scopi utilitaristici, ma da una semplice e pura curiosità. Compie certe azioni solo per vedere cosa succederà e sarà questo che porterà all’eliminazione dell’equipaggio; si può dire per certo che la catena di eventi di questo film e dei successivi, sia esclusivamente causa sua. Mira ad elevarsi fino a diventare divinità e qui si nota la sua avidità e sete di potere e conoscenza: essendo un androide è immortale e ciò lo rende già in parte divino, poiché possiede ciò che gran parte degli esseri umani brama, eppure non è abbastanza per lui.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la ribellione verso il padre, non è subito lampante, ma viene confermato nella seconda parte del film.
Il protoindoeuropeo: la lingua che ci è stata tramandata dagli Ingegneri
Veniamo a sapere che il signor Weyland, colui che ha finanziato la spedizione, è sempre stato a bordo dell’astronave, all’insaputa di tutti eccetto pochi intimi. È convinto che l’aver creato David lo renda pari agli Ingegneri che hanno creato l’umanità e, sicuro che questi possiedano la formula per la vita eterna, è convinto anche di meritarsi questo dono. Il dono che abbiamo ricevuto dagli Ingeneri, però, è ben diverso e forse anche più importante dell’elisir di lunga vita. All’inizio del film David sta imparando la lingua indoeuropea per poter comunicare con i nostri creatori; trattandosi della lingua più antica condivisa da moltissime popolazioni terrestri è possibile che non siamo stati noi ad inventarla, bensì che ci sia stata fornita da qualcuno. L’intuizione si rivela esatta, e David ha così l’opportunità di parlare con un Ingegnere e fargli domande, sotto suggerimento di Weyland.
Tuttavia, se si presta attenzione al dialogo sottotitolato4, notiamo che le traduzioni fatte da David non corrispondono perfettamente alle parole di Weyland. Quest’inefficace comunicazione veniva resa ancora più evidente in una scena tagliata, dove il dialogo tra David e l’Ingegnere era più esteso. In ogni caso, si intende che David ha volutamente cambiato delle frasi per provocare incomprensioni fra noi e il creatore, scatenandone così l’ira che però viene scagliata anche sullo stesso David (l’Ingegnere pare infatti essere infastidito dalla spavalderia di cui i vari personaggi stanno dando prova).
In questa scena, l’androide assume un atteggiamento quasi di sfida nei confronti di suo padre/dio, poiché il suo intento (oltre alla mera curiosità di “vedere cosa succede”) è di dimostrare che semmai è lui quello che ha il diritto di paragonarsi agli Ingegneri, perché lui è in grado di comprenderli. L’aver causato di proposito l’equivoco che si è creato testimonia il suo voler prevalere sulla volontà degli uomini e di provare quanto questi siano inferiori a lui.
L’enorme potere di nominare le cose non è quindi nostro, non siamo noi ad esserci evoluti e ad aver sviluppato un nostro linguaggio, ma ci è stato offerto o, per meglio dire, l’abbiamo ereditato. La parola è importantissima perché, oltre a dar vita alle cose, in un certo senso a concretizzarle, è indubbiamente indice di un intelletto elevato. Non avendola ideata noi, non possiamo più essere ritenuti “magici”.
Questa scoperta però fa cambiare completamente prospettiva sul genere umano, oltre che a far scaturire negli spettatori ancora più domande alle quali trovare risposta.
La problematizzazione della fede
L’elemento prometeico può essere inteso anche, per estensione, come la fiducia riposta in un sogno o un ideale. Un ultimo aspetto di cui vale la pena parlare è proprio quello che riguarda la religiosità della protagonista, che sembra avere un peso rilevante all’interno del film. È più corretto parlare di fede, anziché di religiosità5, perché è la fede che Elizabeth nutre fermamente nei confronti della ricerca e del suo scopo.
Distaccandoci un poco dal film, prendiamo in esempio una poesia di Alfonso Gatto, ovvero Ascolta il passo (Camilleri 2012), scritta in un tempo a noi più vicino, cioè durante la Seconda guerra mondiale (tra il 1943 e il 1947). Il poeta lancia un messaggio quasi provocatorio, in cui spiega che Dio non ci ha voluti felici, ma ci ha voluti liberi: nella visione di Gatto, Dio ha dato agli uomini il libero arbitrio, e probabilmente se la ride ogni volta che vede cosa ne abbiamo fatto. Piuttosto crudele come divinità, non è vero? Eppure, il diritto di scegliere ci ha portato solo a odio, guerre, violenza: noi esseri umani siamo un paradosso. Forse è anche per questo che David odia gli uomini. Se dovessimo utilizzare un linguaggio relativo alla specie, diremmo che noi umani difendiamo i nostri “cuccioli” e ci prendiamo cura anche dei più deboli, mentre in natura un simile atto è impensabile: i cuccioli che non sono in grado di sopravvivere vengono semplicemente abbandonati o addirittura uccisi. Come Darwin ci ha insegnato, non è una questione di essere buoni o cattivi, in natura vige solamente la legge del più forte.
Rispostiamoci all’interno della pellicola. In una delle scene iniziali6 si ha David che spia i sogni di una Elizabeth in ibernazione, anche se più che sogni sono ricordi: vediamo infatti la protagonista che, da bambina, ha una breve conversazione col padre riguardo la fede. Più tardi, a circa metà del film, è sempre David che cerca di togliere a Elizabeth la croce che porta al collo mentre dorme. Un gesto che non cela una certa cattiveria e che anzi, esprime una completa disumanità. Non è un caso che le scene riguardanti il credo si concentrino per lo più su questi due personaggi, uno amorale e scettico, e l’altra caratterizzata da una fede cieca e sincera. David mette in discussione ogni cosa, e si diverte a provocare la protagonista, spesso con un sorriso beffardo stampato in faccia. Verso la fine di quest’avventura, l’androide, incuriosito dalla tenacia di Elizabeth e la sua fede totale, le chiede appunto come sia possibile che lei sia ancora capace di credere in Dio dopo tutto quello che ha passato. La risposta di lei non lascia trasparire alcun dubbio: «Perché è ciò in cui ho deciso di credere».
Con questa affermazione si intende che finché si ha fede in qualcosa, al di là della religione, finché crediamo fermamente nei nostri ideali, sogni o qualsiasi altra cosa, nessuno potrà mai prendere il controllo su di noi. La libera autoaffermazione individuale è sempre destinata a prevalere sulle forze tiranniche esterne e collettive.
Bisogna però fare attenzione a ciò che si desidera perché, come le nostre preghiere può sentirle Dio, così le può sentire anche il Diavolo.
Questioni irrisolte e lacune nel plot
Il prequel di Alien chiude molti interrogativi connessi al primo film, ma purtroppo ne apre tanti altri. In Prometheus e nel suo sequel, sono state lasciate diverse lacune nel plot e sul destino dei personaggi, ed alcune affermazioni fatte si rivelano incoerenti e sconnesse rispetto a quanto detto in precedenza. Di seguito riporto le questioni più eclatanti, lasciate in sospeso.
- Perché nella popolazione degli Ingegneri non ci sono donne? Perlomeno, nei film non sono presenti. Questo è strano, considerato che nei vari capitoli di Alien le eroine dei film sono sempre personaggi femminili. Come nascono dunque gli Ingegneri? È giusto pensare che abbiano effettivamente un sesso? O magari hanno trovato il modo di riprodursi da soli, come alcuni esseri viventi?
- L’altro androide che accompagna la squadra durante il viaggio, Miss Vickers, sembra non essere totalmente a conoscenza dello scopo segreto della missione. Come mai? Nel film chiama Weyland «Father»7, facendo intuire che anche lei sia stata creata dal presidente della compagnia. Quest’ultimo però non sembra nutrire molta stima nei suoi confronti. Anche in questa parte, il poco rispetto mostrato verso un personaggio femminile risulta sospetto e problematico. Ciò che rende il tutto ancora più controverso è che nei film successivi, quali Alien: Covenant (2017) e Alien (1979)8, non vedremo mai più androidi femmina, quasi come se queste fossero state espunte dalla macrotrama che funge da referente alle vicende;
- In questo prequel, l’obiettivo di Weyland è di scoprire come vivere per sempre e confida nel fatto che gli Ingegneri lo sappiano. Nei sequel, invece, si viene a sapere che il vero obiettivo della Weyland Corporation è di riuscire a portare sulla Terra un campione dell’alieno, chiamato anche Xenomorfo. Cosa intendono farne?
Queste sono solo alcune delle domande che sorgono nella mente dello spettatore attento e che si aggiungono a quelle su Prometheus. Ad oggi il regista non ha ancora fatto luce su tali importanti questioni, per cui non sappiamo con certezza se siano volute o meno, ovvero, se Scott abbia abilmente disseminato le sue opere di lacune strategicamente inserite a vari livelli di significazione per aumentare il tasso di ambiguità delle opere, oppure, se si tratti di banali sviste. Chi scrive auspica che la risposta corretta sia la prima, perché sarebbe in linea con la complessità prometeica, che da tempo immemorabile si struttura nell’ambiguità.
Conclusioni
Prometheus di Ridley Scott ci ha fornito tantissimo materiale su cui lavorare per quanto riguarda la ricerca delle componenti relative al mitologema prometeico. È evidente che il titano sia stato preso come ispirazione per la stesura di questo film, fino ad essere presente addirittura nel titolo. La scelta di inserirlo in una trama fantascientifica ben si sposa con il personaggio della mitologia greca, dato che, come il suo nome etimologicamente suggerisce9, questa figura è sempre proiettata in avanti nel tempo e nella cultura, verso il progresso, con tutte le conseguenze, positive e negative, che ne derivano. È interessante, tuttavia, notare come la figura di Prometeo si sia scissa in questo film in due parti, personificate a loro volta da David ed Elizabeth: il primo rappresenta il Prometeo originale, ovvero quello orgoglioso, animato dalla classica hýbris; la seconda invece rappresenta il Prometeo che riesce a raggiungere il proprio obiettivo, ma al di là e a prescindere da essa, cosa che la accosta molto alla figura dello scienziato pazzo (come il Victor Frankenstein di Mary Shelley), infatti diverse scelte fatte da Elizabeth fanno trasparire la sua cupidigia nel voler trovare a tutti i costi le risposte. L’elemento prometeico, quindi, centrale nel film, viene parcellizzato in varie figure e modalità di rappresentazione, essendo presente sia nel contesto dell’azione, sia nella fenomenologia dei personaggi.
In ultima analisi, possiamo infine notare l’attivazione di un’altra componente del mitologema prometeico classico: la maledizione. Questo si evince dal fatto che la serie di eventi che ha portato alla nascita del famoso alieno, antagonista dei successivi film, è come una maledizione scagliata su chiunque tenti di avvicinarsi a quel sistema stellare, se non a tutta l’umanità o, perché no, all’universo intero. Teniamo sempre in mente il monito che è stato formulato fin dal primissimo capitolo del franchise, e che ha immortalato la saga, poi divenuto la tag-line: «In space no one can hear you scream».
Bibliografia / Sitografia / Filmografia
Bibliografia
Camilleri, Andrea (2012), Il capo sulle neve. Liriche della resistenza, Salerno, Fondazione Alfonso Gatto.
Hillman, James (2014), Figure del mito, Milano, Adelphi.
Morpurgo, Giuseppe (1956), Il leggendario: le favole antiche di Grecia e di Roma, Torino, G. B. Petrini.
Sitografia
«Prometheus Character Analysis: Elizabeth Shaw», In: Virtual Borderland, consultato il 12/05/2024, URL: <https://virtualborderland.wordpress.com/2012/06/04/prometheus-character-analysis-elizabeth-shaw/>.
«Prometheus, il cult di fantascienza che divide gli animi», In: Cosmopolitan, consultato il 07/05/2024, URL: <https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/cinema/a41787384/prometheus-il-cult-di-fantascienza-divide-gli-animi/>.
«Prometheus (2012 film)», In: Wikipedia, consultato il 30/04/2024, URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Prometheus_(2012_film)>.
«Religione», In: Enciclopedia online, Treccani, consultato il 29/08/2024, URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/religione/>.
Valeri, Valerio (1992), «Credenze e culti», In: Enciclopedia delle scienze sociali, Treccani, consultato il 29/08/2024, URL: <https://www.treccani.it/enciclopedia/credenze-e-culti_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/>.
Filmografia
Alien (1979), diretto da Ridley Scott, Regno Unito, Stati Uniti d’America, 20thCentury Fox, Brandywine Productions.
Prometheus (2012), diretto da Ridley Scott, Regno Unito, Stati Uniti d’America, 20th Century Fox, Brandywine, Scott Free Productions, Dune Entertainment.
Alien: Covenant (2017), diretto da Ridley Scott, Regno Unito, Stati Uniti d’America, TSG Entertainment, Brandywine Productions, Scott Free Productions.
Note
- Il mito di Prometeo è multiforme e contorto, dato che egli è considerato l’archetipo dell’esistenza umana, ma anche il simbolo della ribellione e di sfida alle imposizioni e alle autorità, ed è stato un’influenza culturale per quanto riguarda la letteratura, le scienze e molto altro. Il polimorfismo di questa figura ci aiuterà ad analizzare meglio la pellicola, e a vedere dove sono stati riprodotti i suoi molteplici aspetti.
- La creazione è uno dei concetti su cui si fonda questo film, come viene citato in un articolo della piattaforma WordPress: «The mitology behind this film is an ancient human concept about creation» (4 giungo 2022).
- Come ci viene spiegato dal saggista James Hillman: «Perfino l’impulso prometeico di portare beneficio al genere umano con gesti nobili può risultare distruttivo per la forza delicata dell’anima» (Hillman 2014:133).
- Prometheus (2012), min. 1:39:14.
- I concetti di religione, religiosità, fede, credenza e molti altri, seppur connessi tra di loro, rimandano a principi diversi, come viene esplicitato dall’Enciclopedia Treccani in https://www.treccani.it/enciclopedia/religione/, e successivamente in https://www.treccani.it/enciclopedia/credenze-e-culti_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/. La religiosità è una devozione non necessariamente legata a una particolare religione storica, mentre la fede fa riferimento proprio alla confessione religiosa.
- Prometheus (2012), min. 00:08:30.
- Prometheus (2012), min. 1:34:12.
- In questo caso i film di Scott vengono elencati non in ordine di regia, bensì vengono inseriti per come si svolge la trama cronologicamente, essendo Alien il primo capitolo della saga ad essere stato girato, ma che è ambientato dopo gli eventi di Prometheus e Alien: Covenant.
- Il nome “Prometeo”, dal greco antico Προμηθεύς, Promethéus,significa per l’appunto “colui che riflette/vede prima”.